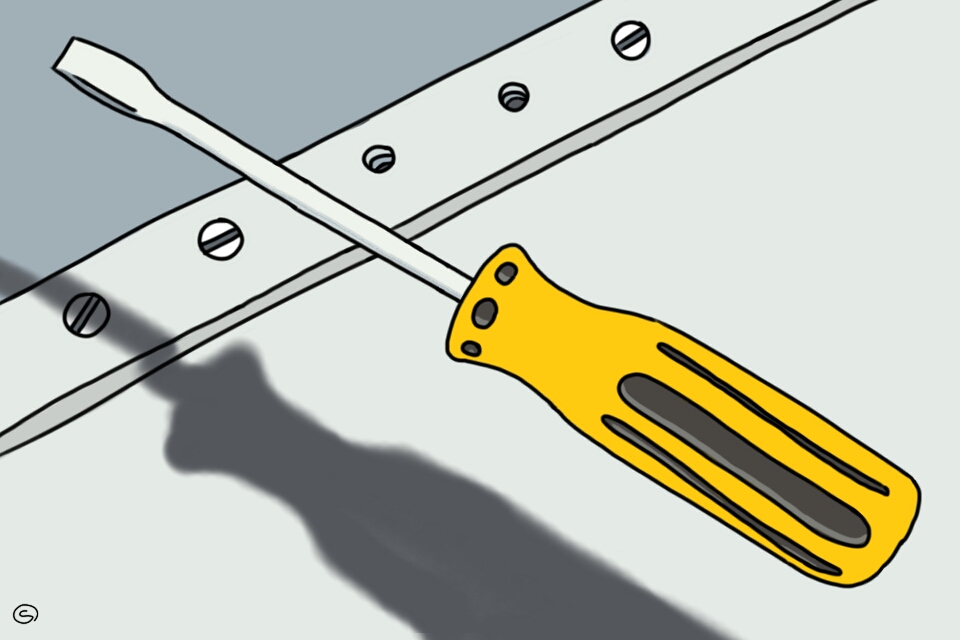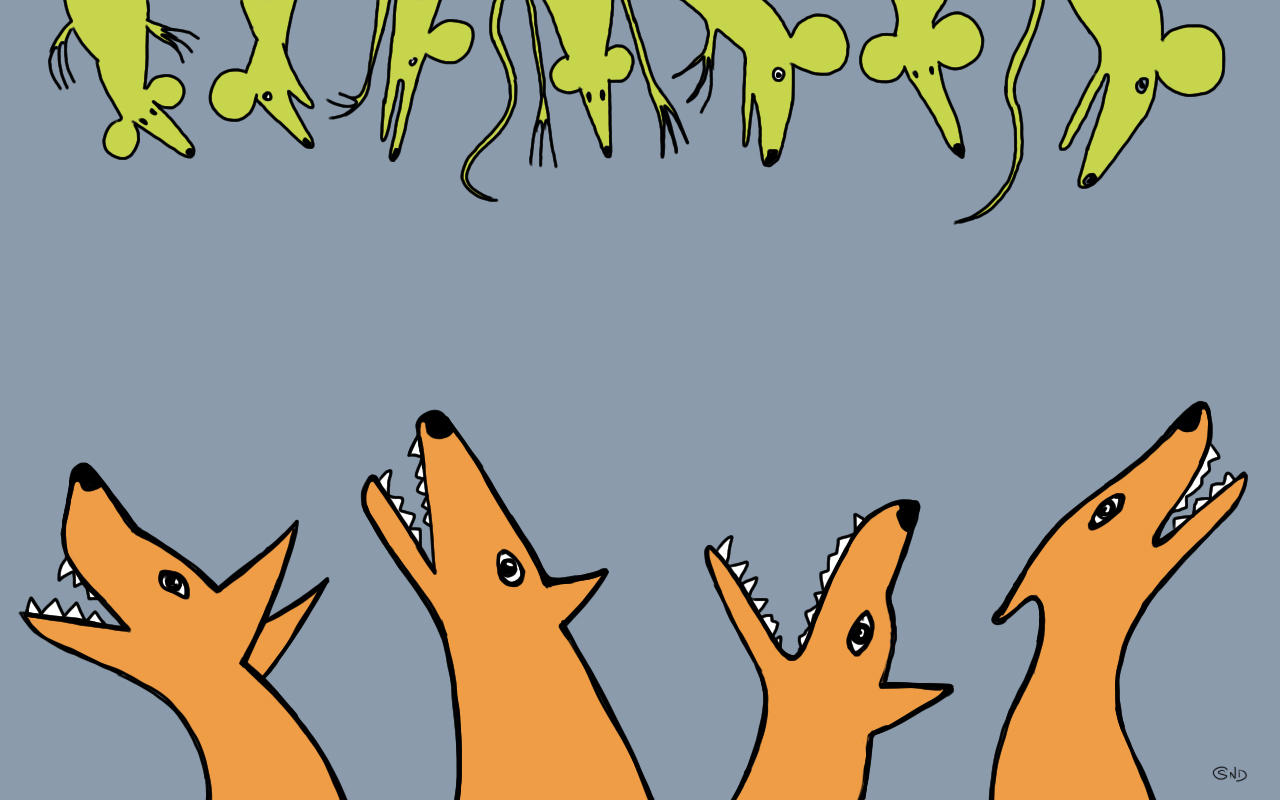di GIROLAMO DE MICHELE
Due immagini, fra le quali si muove, agisce e produce il “sistema doping”. La prima viene da Acido lattico, romanzo scritto da Saverio Fattori nel 2008: «Centoventi uova sbattute al muro, solo quelle che non si rompono diventano pulcini di campione. Il resto è frittata, iscritti alla maratona di New York nelle mani di astuti Tour Operator». La seconda viene dalla cronaca – o meglio, da un’omissione, perché non fu riportata dai giornali (la fonte è un’intervista a Sandro Donati): 2004, conferenza stampa durante il Tour de France; Lance Armstrong si accorge dell’ingresso in sala del giornalista irlandese David Welsh, co-autore dell’appena pubblicata inchiesta sui rapporti fra Armstrong e il doping (via l’alchimista italian Michele Ferrari) L.A. Confidential: Lance Armstrong’s Secrets, e senza mezze parole gli ordina di uscire in quanto persona non gradita: gli altri giornalisti – il meglio delle firme sportive internazionali – restano muti e passivi.
Queste due immagini ci dicono l’una l’ampiezza della base su cui poggia il sistema, non solo sportivo, del doping; l’altra, il grado di accondiscendenza che circonda questo sistema.
Fiumi di parole
C’è qualcosa di surreale nel dibattito giornalistico di questi giorni sul doping, vero o presunto, del marciatore Alex Schwazer.
In primo luogo, nelle ricostruzioni dei fatti, e nella scelta dei termini. Si tratterebbe dunque di un ex dopato pentito, coinvolto a seconda dei casi o in una recidiva, o in un complotto che vede in posizione di vertice Maurizio Damilano, ex campione olimpico, presidente mondiale in carica del Comitato della Marcia della IAAF, la federazione internazionale di atletica leggera (nonché fratello di Sandro Damilano, ex allenatore dello stesso Schwazer ai tempi del primo (?) doping e attuale allenatore della nazionale cinese di marcia), all’interno di una gestione del mondo della marcia nella quale le gare sarebbero decise a tavolino da una triade composta dai dirigenti delle squadre italiana, russa e cinese, sempre che sia verosimile la ricostruzione di Attilio Bolzoni, giornalista d’inchiesta dal profilo professionale non se sempre limpido (a suo tempo Bolzoni fu co-autore, assieme al celebratissimo Peppe D’Avanzo, di un instant book a rimorchio di un’ipotesi giudiziaria tanto squinternata quanto funzionale, che definiva l’assassinio di Mauro Rostagno “un delitto tra amici” – con le parole definitive di Maddalena Rostagno, «il libro potrebbe andare in onda su Rete4: è per appassionati di telenovelas». Per la cronaca: non risulta che Bolzoni si sia mai scusato di quella porcata, neanche all’indomani della sentenza che ha sancito la matrice mafiosa dell’assassinio).
Dilettantismo semantico: se le parole hanno un senso, Schwazer non è “pentito”, ma al più “dissociato” o “dichiarante”: prendere per buone le sue parole significa credere che un atleta, a zonzo solo soletto per Istanbul, può entrare in farmacia e chiedere (in turco?) se per caso hanno un po’ di Epo da vendergli senza prescrizione medica. Quanto al suo aver espiato i passati errori, desta il sorriso (in noi che non riusciamo a leggere il mondo con gli occhialino 3D della pena, espiazione e risentimento) la misura – anche solo temporale – di cotanta espiazione, portata ad esempio sulle pagine di giornali tuttora pervicacemente avversi non si dice all’agibilità politica, ma al semplice diritto di parola e opinione verso chi ha scontato ben più che qualche mese di squalifica – ma che te lo dico a fare?
D’altro canto, anche di Damilano (Maurizio) non si dice “ex dopato”, benché figurasse nel famigerato file dblab del professor Conconi: vederlo oggi al vertice della IAAF è un po’ come immaginare Prospero Gallinari a capo dell’arma dei carabinieri. Altri, invece, citano con disinvoltura il “complotto” per escludere di Schwazer come prova di un’olimpiade truccata a fini geopolitici, ovvero per escludere gli atleti russi: dimenticando che nel supposto complotto contro Schwazer la federazione dei marciatori russi rivest(irebb)e la parte non dell’agnello, ma del lupo. Ma si sa, la geopolitica è quella cosa che, spiegando qualunque cosa con qualunque disegno generale, consente qualunque giravolta, soprattutto se orientata dal rosso al bruno: persino di chiamare “compagni” Putin e Milosevic (e a breve anche l’ex fascista Erdogan).
Non bastasse, è capitato di sentire un direttore di testata Rai (uno che con le parole ci lavora, con una retribuzione a 6 cifre) tenersi in equilibrio fra il cerchio e la botte affermando che «ancora non sappiamo chi ha ucciso Kennedy, non abbiamo ancora capito cos’è successo ad Aldo Moro, figuriamoci se sapremo mai la verità su Schwazer» (e, così per sapere, su Giulio Regeni?). Ancora un passo avanti, e ci verranno a dire che Schwazer in quella farmacia di Istanbul cui è arrivato a cavallo della celeberrima Honda rossa di via Fani.
Ultimi, quelli che difendendo o attaccando Schwazer sostengono, gli uni come gli altri, di “difendere lo sport”, un po’ come ai tempi i Violante e i Dalla Chiesa “difendevano la democrazia”: senza avere il minimo sentore del fatto che di questo sport, come di quella democrazia, ci sarebbe al minimo bisogno di dire in cosa consiste, e cosa di esso meriterebbe di essere difeso. Curioso, per dire, che chi nomina Sandro Donati ometta di dire cosa Donati ha messo nero su bianco (si vedano il Rapporto sui traffici mondiali delle sostanze dopanti, 2006, e il più recente Lo sport del doping, 2013) sulla reale natura di questo sport che avrebbe ricevuto un “colpo mortale” dalla squalifica di Schwazer: ad esempio, dei rapporti non occasionali, ma strutturali fra il mercato delle sostanze dopanti – la cui produzione e distribuzione avviene all’interno di un’economia formalmente – illegale e quello del narcotraffico.
Dal corpo-macchina al corpo dopato
 Epperò, queste parole parole parole un effetto lo producono: contribuiscono a isolare e individualizzare la dimensione del doping, a reiterare, anche laddove credono di sottoporlo a critica, un dispositivo che fa del gesto sportivo una replica più muscolosa e sudata del gesto di «dandies e ai clochards, così simili (e stimabili) quando costruiscono per sé una vita come opera d’arte. Radicalizzano una vita per loro estetica, dentro una bilancia di autosufficienza e di eleganza, di dignità e di anarchia – la differenza tra loro è solo di denaro e/o di igiene – ma certamente qui non è il comune che trionfa» (Toni Negri, Sul comune. Arte e moltitudo). E aggancia il gesto sportivo a un apparato di controllo e disciplinamento del corpo.
Epperò, queste parole parole parole un effetto lo producono: contribuiscono a isolare e individualizzare la dimensione del doping, a reiterare, anche laddove credono di sottoporlo a critica, un dispositivo che fa del gesto sportivo una replica più muscolosa e sudata del gesto di «dandies e ai clochards, così simili (e stimabili) quando costruiscono per sé una vita come opera d’arte. Radicalizzano una vita per loro estetica, dentro una bilancia di autosufficienza e di eleganza, di dignità e di anarchia – la differenza tra loro è solo di denaro e/o di igiene – ma certamente qui non è il comune che trionfa» (Toni Negri, Sul comune. Arte e moltitudo). E aggancia il gesto sportivo a un apparato di controllo e disciplinamento del corpo.
L’atto sportivo, scrive David Foster Wallace (Roger Federer come esperienza religiosa), ha a che fare con «la possibilità per un essere umano di riconciliarsi con il fatto di avere un corpo». A fronte del limite che il corpo, in prima battuta, costituisce coi suoi dolori, nausee, piaghe, odori, vecchiaie, gravità, sepsi, goffaggine e malattie , «i grandi atleti sembrano catalizzare la nostra consapevolezza di quanto glorioso sia toccare e percepire, muoversi nello spazio, interagire con la materia». L’andare oltre il limite dell’atleta ha a che fare con la virtualità che eccede il reale: non solo nel dimostrare che questa eccedenza è comunque possibile, ma anche nel far percepire questa virtualità come un di più del reale che potrà essere conquistato non solo col gesto sportivo che singolarizza la potenza del corpo, ma anche con la potenza del comune nel quale si concatenano le soggettività in una macchina che dimostra, praticandola, cosa può un corpo – comune, prima ancora che individuale. È la finitezza costituente dell’umano che si fa, nella prassi, potenza costituita.
Il trucco del doping crea invece l’illusione che il rapporto fra reale e virtuale sia una mera questione di chimica farmaceutica («L’Epo ristabilisce il numero dei globuli rossi, visto che la natura lasciata sola fa cazzate, avara com’è», afferma un personaggio di Acido lattico). Non ci si prenda per nostalgici di passati sudori e fatiche: è la bellezza del corpo – la sua eccedenza, la sua grazia, la sua imprevedibilità, la sua creatività, la sua fantasia – che viene ridotta a gesto misurabile e quantificabile; è la fantasia che deve cedere il passo alle tabelle, alle griglie, ai dispositivi numerici e quantitativi che imprigionano l’imprevedibile differenza nella dittatura della ripetizione. E riducono il corpo a cosa iperindividuale, negando con l’eccezionalità della prestazione inseguita quella relazione costituente che è il comune: il corpo dopato dai muscoli ipertrofici è, insomma, la negazione di quel cyborg postumano di cui scrivevano Negri e Hardt in Il lavoro di Dioniso.
Ma ricadremmo anche noi nell’illusione individualizzante, se ci limitassimo a considerare il doping una questione privata fra l’atleta e la norma.
Il sistema-doping1
Il sistema-doping è strutturato a cerchi concentrici.
Nel circolo più interno, c’è l’atleta che viene indotto a doparsi e messo in condizione di diventare assuntore-dipendente di sostanze chimiche, fra le quali la cocaina non è un’eccezione o un incidente di percorso, men che meno (come vuole la narrazione martirologica su Marco Pantani) un esito post festum della depressione dell’atleta sconfitto.
Detto altrimenti, il piano dell’industria farmaceutica “legale” e quello della produzione e distribuzione illegale finiscono col collassare l’uno sull’altro: proprio come, nell’economia finanziaria, i piani del capitale “legale” e “illegale”. Nessun moralismo, né alcuna concessione alle iperfetazioni zero zero zero; si tratta di prendere atto che il narcotraffico è (non la sostanza, ma) un segno del capitalismo finanziario: «l’economia criminale va assumendo le medesime caratteristiche di ogni altro segmento, si è finanziarizzata, aggredisce il comune per estrarre profitto, si avvale del mercato globale e della comunicazione, si caratterizza per il prevalere del capitalismo cognitivo. E proprio per questo non è separabile dal meccanismo capitalistico nel suo complesso viene meno il conflitto fra struttura criminale e stato perché l’organizzazione dell’economia criminale è parte dello stato. Ovvio che si tratta di un processo in corso, con mille contraddizioni. Ma è un processo avviato, senza ritorno» (Gianni Giovannelli, Triplo zero o triplo work?). Del quale meccanismo capitalistico è parte integrante rendere – meglio: costruire – l’essere umano (come) precario e indebitato. Davanti a questo quadro, l’immagine dell’atleta che pratica un artigianale doping fai-da-te è credibile quanto il self made man della narrazione liberale che, con suo spirito di iniziativa individuale e una spruzzata di calvinismo, costituirebbe la base del capitalismo.
Il secondo circolo è quello dei cooperanti al sistema: allenatori, preparatori atletici, dirigenti, addetti al “controllo”. Tra questi, un ruolo di rilievo giocano i giornalisti sportivi, ai quali è chiesto di dire il meno possibile, di fingere di ignorare le pubblicazioni scomode e/o inopportune, o se non può di seppellirle sotto l’insinuazione della mitomania. Nelle sempre istruttive cronache del Tour de France, è più facile trovare aspre critiche ai ristoratori francesi che servono lo champagne al calice e non portando la bottiglia in tavola, piuttosto che dubbi su certi fisici smagriti e anoressicizzanti che procedono alle stesse velocità di Armstrong.
C’è poi il circolo dei giovani atleti – le uova sbattute contro il muro di cui scrive Fattori – indotti all’uso di supporti chimici già alle prime armi, un po’ come in Matrix, dove Neo diventa campione di arti marziali non mediante anni di pratica, ma col semplice caricamento di un programma.
Infine, un circolo ancora più ampio, che motiva gli allarmanti dati sulla diffusione di sostanze dopanti tra la popolazione: quello dell’amatore della domenica, che prende l’EPO per fare la pedalata con gli amici. Quella che un tempo era una scampagnata domenicale, in bici ma con la pancetta, magari fino alla trattoria dove rinfrancarsi con un piatto di tagliatelle o una parmigiana e una buona bottiglia di vino, oggi è una vera e propria gara, con tempi da monitorare, bici e abbigliamento firmati: con la maglia, la bandana, il santino (e l’EPO nel sangue) del Pirata. Così come alla corsetta tonificante – il buon vecchio footing – si sostituisce la corsa monitorata dal contapassi, con le frequenze scandite da un programma ascoltato con l’auricolare che isola dal contesto urbano e aumenta l’individualizzazione del corridore, e l’imprescindibile merchandising di scarpe, maglietta, bottiglietta di bevanda energetica, e via dicendo.
Quella che era a tutti gli effetti una “vacanza”, una sottrazione della vita dal tempo del lavoro dove tutto è misurato e controllato per essere tradotto in valore di scambio, una sospensione della vita quotidiana nel tempo della festa, diventa anch’esso tempo misurato, scomposto in unità discrete e numerabili, competizione, classifica dei primi e degli ultimi: la “società del controllo”, nella quale il tempo di vita coincide col tempo di lavoro 24/7, e dove il controllore non è il bieco figuro alle nostre spalle col cronometro in mano, ma è dentro di noi.
Un corpo precario e messo a valore
 Gli anni del doping di massa coincidono con gli anni «del successo editoriale dei manuali che insegnano a prendersi cura del corpo e a sopravvivere allo stress. […] La vita è diventata il centro degli interessi del potere. Il corpo – controllato, monitorato, palestrato, in salute e immortale per legge, rispondente ai dettami dell’estetica dominante – diventa parte integrante dei meccanismi produttivi. Esattamente come, dall’altro lato, la conoscenza, i sentimenti, l’esperienza accumulata dalla vita extra lavorativa diventano sempre più chiaramente capaci di produrre valore aggiunto» (Cristina Morini, Per amore o per forza. Femminilizzazione del lavoro e biopolitiche del corpo). Di questo corpo precarizzato e messo a valore, il “modello antropogenetico emergente” è quello della produzione dell’uomo attraverso l’uomo: «un modello in cui i fattori di crescita sono di fatto imputabili direttamente all’attività umana», e nel quale è «la capacità di innovazione, di “produzione di forme di vita”, e quindi di creazione di valore aggiunto, che definisce la natura dell’attività umana».
Gli anni del doping di massa coincidono con gli anni «del successo editoriale dei manuali che insegnano a prendersi cura del corpo e a sopravvivere allo stress. […] La vita è diventata il centro degli interessi del potere. Il corpo – controllato, monitorato, palestrato, in salute e immortale per legge, rispondente ai dettami dell’estetica dominante – diventa parte integrante dei meccanismi produttivi. Esattamente come, dall’altro lato, la conoscenza, i sentimenti, l’esperienza accumulata dalla vita extra lavorativa diventano sempre più chiaramente capaci di produrre valore aggiunto» (Cristina Morini, Per amore o per forza. Femminilizzazione del lavoro e biopolitiche del corpo). Di questo corpo precarizzato e messo a valore, il “modello antropogenetico emergente” è quello della produzione dell’uomo attraverso l’uomo: «un modello in cui i fattori di crescita sono di fatto imputabili direttamente all’attività umana», e nel quale è «la capacità di innovazione, di “produzione di forme di vita”, e quindi di creazione di valore aggiunto, che definisce la natura dell’attività umana».
Il lato oscuro di questo modello è la creazione di un corpo precarizzato, cioè reso precario nelle condizioni di lavoro e di esistenza, e autopercepito come precario perché in posizione incerta rispetto alle gerarchie di una vita, e in relazione instabile con i modelli emergenti – in primo luogo, “l’imperativo della magrezza”: «Una tirannia instaurata praticamente grazie a una serie di tecniche di trasformazione del corpo, organizzate secondo una logica di mercato e promosse, anche qui, dalla cultura del consumo: dieta, esercizio fisico, prodotti cosmetici e farmaceutici, liposuzioni. […] Viene bandita ogni eccessiva “morbidezza” che fuoriesca dai “contorni”, il corpo-macchina deve liberarsene se vuole avere possibilità sociali e personali. Ignoti e potenzialmente infiniti spazi di mercato si aprono per consentire ai corpi-macchina di mantenere tali promesse».
Avere un corpo compatibile con gli standard di tonicità e levigatezza, capace di prestazioni aerobiche scandite da un preciso monitoraggio, fasciato da logo riconoscibili, appare la condizione necessaria per aspirare all’inserimento nel precarizzato mercato del lavoro e nelle altrettanto incerte e precarie relazioni sociali dominate dalle aspettative estetiche cui il soggetto precario è chiamato a conformarsi.
È di tutto questo che si dovrebbe parlare, quando si parla del rapporto fra sport e doping: quantomeno, per chi ne ha abbastanza delle gnagnere su una perduta purezza del passato, e vorrebbe senz’altro passare alla critica dello stato di cose presente.
In questo e nel successivo paragrafo faccio riferimento in buona parte al mio precedente Il martirologio del santo Marco Pantani (2014). ↩