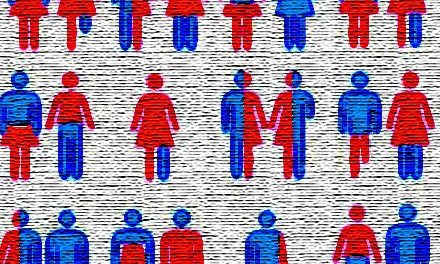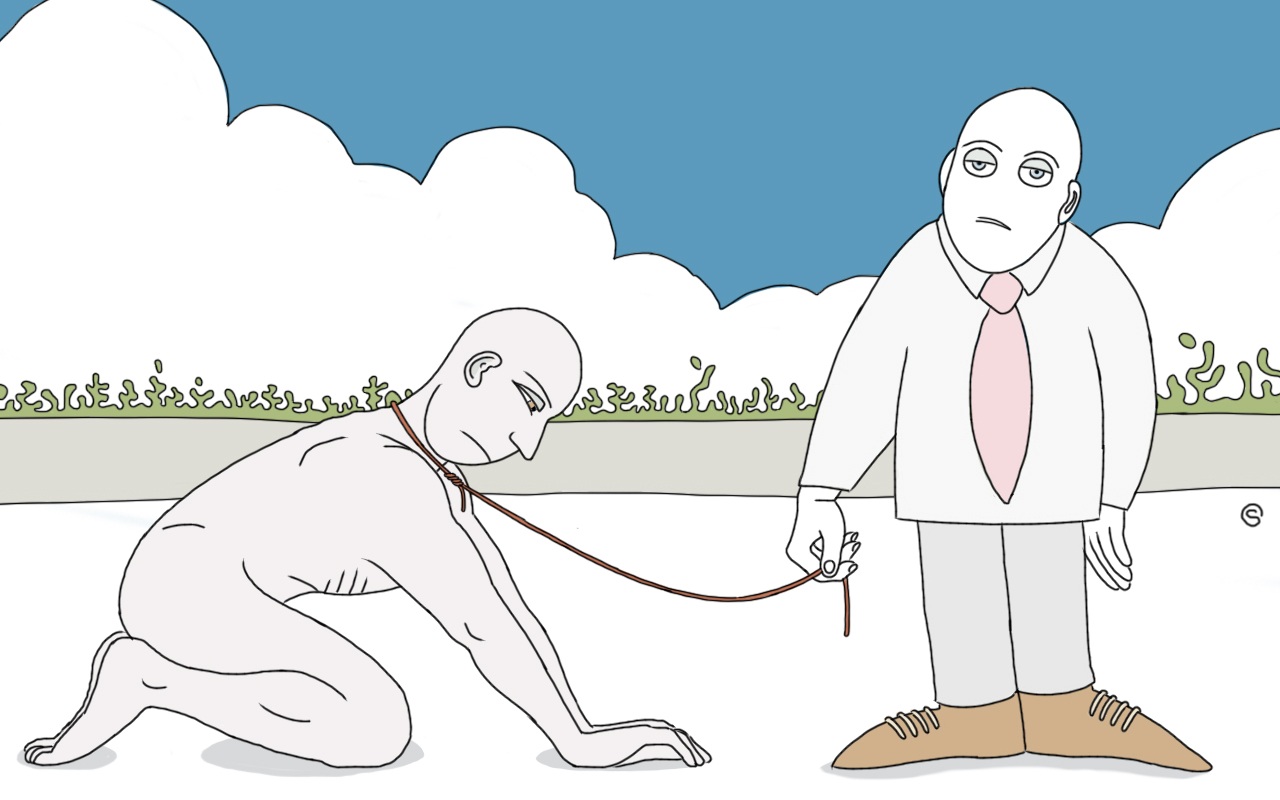Di MARCO BASCETTA
Vi è una diffusa tendenza a considerare la pandemia come occasione imperdibile per affermare il proprio punto di vista ideologico, la giustezza delle proprie analisi e diagnosi sociali. Converrebbe tuttavia mantenere una certa prudenza nell’attribuire al Covid 19 questa o quella potenzialità rigeneratrice, laddove tutti gli indizi testimoniano di una restaurazione delle condizioni precedenti. Vi è dunque da dubitare che, come recita il titolo di un articolo di Laura Pennacchi uscito sul manifesto lo scorso venerdì, “con la pandemia, il lavoro si riprende il centro della scena”.
SUL SUPERAMENTO della recessione provocata dalla crisi sanitaria (la cui evoluzione resta comunque un’incognita), sul come, sul quando e sul quanto regna una totale incertezza. Cosicché l’ora della “piena e buona occupazione” con tutti i suoi corollari etici e antropologici non sembra in procinto di scoccare. Quello che empiricamente si è potuto constatare fino ad oggi è che la qualità del lavoro si è sempre rivelata inversamente proporzionale alla sua estensione. Circostanza che non costituisce problema solo per chi pensi che anche al lavoro più sfruttato e ingrato spetti l’onore di conferire identità. Se ci si sforzasse poi di indicare, a partire dalla rivoluzione industriale, dove e quando si sia data una fase di “piena e buona occupazione” ci si troverebbe in gravi difficoltà.
L’Urss degli anni 30? La Germania del riarmo? (non dimentichiamo che la guerra è stata da sempre spacciata per lavoro socialmente utile, Iraq e l’Afghanistan compresi) La fabbrica di Valletta o quella dell’operaio-massa? L’epopea dell’acciaio di cui ammiriamo oggi le rovine ambientali? Le miniere da Grosseto a Marcinelle? Insomma il lavoro andrebbe considerato in rapporto alla sua ruvida storia reale (anche quella attuale della logistica e del lavoro migrante) che non è certo quella della celebrata Ivrea di Olivetti. Cosicché almeno la riduzione della sua durata e l’automazione delle sue forme più usuranti dovrebbe essere accolta con favore da chiunque tenga in qualche conto la lezione di Marx. Quanto alla sinistra, invece, che dovrebbe raccogliere la bandiera della buona occupazione, si sta spendendo da anni nell’indebolirla e precarizzarla in nome della sua presunta salvaguardia condizionata dalla sacralità del rapporto tra costi e benefici.
IL LAVORO NON È stato oggetto di alcun “oscuramento teorico”, come sostiene Pennacchi, semmai di una ricerca che andava inseguendolo nelle sue metamorfosi, nella sua dispersione attraverso l’intero tessuto sociale, nella sua produttività senza riconoscimenti né retribuzioni. Prendiamo l’esempio della digitalizzazione spinta all’estremo dall’obbligo di distanziamento sociale che sta incrementando oltremisura le già immense ricchezze del capitalismo delle piattaforme. Una delle sue principali caratteristiche è il trasformare un certo numero di operazioni e faticose procedure in lavoro gratuito a carico degli utenti e a spese dell’occupazione (ricordate l’uso capitalistico delle macchine?).
Nonché di portare all’estremo lo sfruttamento dei lavoratori della logistica, fino alla brutale repressione delle lotte in corso in questo decisivo comparto. Il blocco imposto dall’epidemia non ha colpito tanto la manifattura, disposta a rischiare grosso e sappiamo con quali conseguenze, per non perdere quote di mercato e competitività, quanto i settori di attività legati alla vita relazionale di una società. Sia quelli fortemente commerciali indirizzati al turismo di massa e al tempo libero pagante, sia quelli a minore o nessuna redditività come la riproduzione sociale in tutte le sue articolazioni: la cura, l’educazione, le produzioni culturali, lo studio, la gestione di spazi collettivi, l’informazione e l’autoformazione.
L’INTERO VASTO mondo di quelle attività “informali” che nessuno certifica come “lavoro”, nessuno retribuisce e tantomeno “ristora” ma che costituiscono, a volerle osservare con attenzione e riconoscerne il peso, la forma attuale della “piena occupazione” (tutt’altro che “plebea”) cui manca reddito, non “lavoro”. Su quest’ultimo e il suo rapporto con la natura umana si discute da secoli e per secoli si continuerà a discutere. Ma nel mondo in cui viviamo a certificarne la realtà, il riconoscimento sociale e il diritto a una retribuzione non vi è altro che lo stato o il mercato: la coercizione più o meno blanda, la giungla dei rapporti contrattuali e la legge della domanda e dell’offerta. Possiamo naturalmente aggiungere il “volontariato”, vale dire quella estesa conversione di lavoro retribuito in lavoro gratuito in cambio di “identità” e fumose promesse con conseguenti benefici per il bilancio dello stato e i profitti delle aziende.
A QUESTO SCHEMA la pandemia non ha portato alcun cambiamento, nemmeno riguardo alla cruciale questione della proprietà intellettuale. Tra sblocco dei licenziamenti, per la gioia dei liberisti, e grandi opere, per quella degli statalisti, tra privatizzazioni “ristoratrici” degli spazi pubblici e strapotere dei giganti della rete, la ripresa si annuncia tutta sotto il segno dell’accumulazione.
In questo quadro la sequenza che pone esclusivamente l’ampliamento del lavoro salariato come premessa per le lotte del lavoro salariato medesimo in vista della sua propria emancipazione rischia di incidere ben poco sull’assetto sociale esistente e soprattutto sulla possibilità di trasformarlo.