di SANDRO CHIGNOLA.
Pubblichiamo la versione italiana dell’intervento di Sandro Chignola al Colloque International “Foucault(s) 1984-2014” (Paris, 19-21 mai 2014), in occasione dell’uscita del suo Foucault oltre Foucault. Una politica della filosofia (Derive Approdi, Roma, pp. 208).
Il mio intervento sarà molto breve come mi è stato richiesto. Intendo mettere a tema – e mi scuso se posso farlo solo in modo molto diretto e brusco – una serie di questioni che riguardano Foucault, la sua filosofia, il rapporto che essa intrattiene con le scienze sociali.
Procedo per punti. Il primo: io credo si debba lavorare l’archivio dei testi foucaultiani con molta attenzione ed evitando un doppio rischio. Da un lato quello di fare di Foucault un Autore: un rischio che è evidentemente radicato nella nuova ondata degli studi foucaultiani e che viene sospinto dalla incessante pubblicazione di testi, corsi, materiali ed inediti che vengono offerti all’interpretazione degli studiosi. Operazione importante, certo, quest’ultima – non intendo affatto negarlo – e che ha permesso, in particolare in Italia, di sottrarre Foucault all’oblio cui era stato frettolosamente consegnato già sul finire degli anni ‘70. Ma operazione che, almeno a mio avviso, può però, per una paradossale eterogenesi dei fini, concludersi con il «monumentalizzare» Foucault riducendolo ad un semplice capitolo di una storia della filosofia rinsaldata nel suo accademicismo.
Dall’altro, e mi sembra un rischio altrettanto importante, quello di ab-usare della filosofia di Foucault, estrapolandone stili e formule per farne un uso altro: non improprio, perché un suo proprio non c’è, ma forzato rispetto alla scelta foucaultiana di fare comunque filosofia senza abbandonare o decretare l’inutilità di quest’ultima a favore di altri campi di indagine o di altre discipline. Mi riferisco, ovviamente, al modo nel quale Foucault viene talvolta usato, e, beninteso, seguendo indicazioni da lui stesso date in alcune occasioni, nel campo delle scienze sociali ed umane.
Evitare entrambi questi rischi è possibile a mio modo di vedere. Ed è possibile farlo ripensando, esattamente come ebbe a farlo in prima persona Foucault, la stessa filosofia, la consistenza e l’autonomia dei suoi archivi, i limiti entro i quali essa ha finito con l’autoperimetrarsi in quanto sapere universitario, per mettere alla prova questi stessi limiti e per provare a superarli. Si tratta di attivare, sull’onda di una ricerca la cui coerenza non ci offre soltanto o principalmente una «cassetta di attrezzi» da impiegare a piacimento, un movimento di andata e ritorno tra l’interno della filosofia – le sue serie autoriali, il suo canone, i suoi stili, le teleologie in base alle quali la storia della filosofia ingrana e riproduce il suo senso – ed il suo esterno; un esterno fatto di processi, pratiche, conflitti, sui quali si misurano, qualora la filosofia sappia raccoglierne la sfida, il suo passo e la sua capacità di tenuta.
Foucault, in questa prospettiva, può essere studiato come filosofo e contemporaneamente come destabilizzatore radicale dello statuto della filosofia come sapere. Egli ci offre un esempio, uno dei più radicali, di quella che chiamo una politica della filosofia. Una politica della filosofia in grado di spezzare l’inerzia di una tradizione che, tra l’altro, direttamente mi coinvolge, quella della filosofia politica in particolare, e la separazione tra prassi e teoria sulla quale essa ha storicamente avviato e ripodotto il proprio statuto di moderna istituzione del sapere. Con Foucault il filosofare cessa di coniugarsi in terza persona, come avviene quando il recit della filosofia sgrana i passaggi di una pretesa impersonalità della ragione e il discorso, interrotto ogni rapporto con il reale, si carica di un’universalità che non gli appartiene. Quando Foucault parla di «giornalismo» filosofico è esattamente a questo movimento di andata e di ritorno che fa riferimento, io credo. Un’andata e un ritorno che decentra la filosofia rispetto alle sue pretese di comprensione della realtà, che la installa, piuttosto, all’interno della realtà stessa come procedura di veridizione posizionata, che dissolve l’illusione di universalità della sua parola, ma che conserva della filosofia, pur degerarchizzandone ruolo e funzione rispetto all’albero dei saperi, specificità e competenza di parola.
Solo la filosofia, infatti, e cioè quella pratica di interrogazione e di inchiesta in grado di assumere come problema il movimento stesso del pensiero nel momento preciso in cui esso si attua, può assumere il presente come un divenire e il pensiero stesso come un’attività. Solo la filosofia può assegnare entrambi, presente e pensiero, ad un’immanente produttività senza soggetto. Tanto sul lato degli «oggetti» del pensiero – concetti, categorie, saperi: nulla permane immobile o trascendentale rispetto alla prassi, ma della prassi, ed in particolare di quello che potrebbe essere definito lo «schematismo» del conflitto, tutto si determina come un effetto -; quanto sul lato del «soggetto» che pensa, che dai processi che lo attraversano risulta costituito e rispetto ai quali può agire come una localizzazione o come una forza.
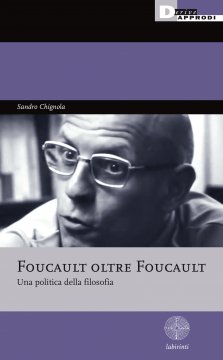 Credo che si tratti di una questione decisiva. O, perlomeno, quella attorno alla quale scelgo di far ruotare il mio intervento.
Credo che si tratti di una questione decisiva. O, perlomeno, quella attorno alla quale scelgo di far ruotare il mio intervento.
Primo passaggio: c’è un momento specifico in cui la filosofia (e solo la filosofia, probabilmente) si pone il problema di questo movimento. Si tratta, è noto, dell’arco dell’illuminismo radicale che si dispiega tra Kant e Nietzsche. Foucault vi torna costantemente negli anni del suo insegnamento al Collège de France. Tra Kant e Nietzsche il pensiero si trova integralmente assegnato al presente, risemantizzato come una diagnostica e ripensato come un’attitudine. E cioè, come un’etica. Destabilizzare la filosofia significa, esattamente in questo senso, rimontare la cesura che storicamente ha slegato il pensiero dalla prassi e pensato quest’ultima come esterna e come dipendente dalla funzione orientativa della quale il primo si riserva il monopolio. Il campo delle scienze sociali – ed in particolare: della sociologia – viene ritagliandosi nel quadro di una scienza di realtà che pensa processi e fenomeni come posti immediatamente di fronte al soggetto che se li rappresenta e si legittima, rispetto alla filosofia – si tratta della storia del suo processo di istituzionalizzazione –, in quanto sapere capace di uno sguardo molto più preciso ed acuto su di un concreto che l’astrattezza di quest’ultima non sarebbe in grado di sostenere. Con Kant e con Nietzsche, Foucault assume, di contro, non solo il fatto che la verità è di questo mondo, riassorbendo senza resto lo stesso soggetto che pensa nell’immanenza di processi che le scienze sociali trattano invece come una pura esteriorità, ma che la verità stessa sia la posta in gioco di una prassi che si offre come condizione e come chance di soggettivazione.
Secondo passaggio: ho parlato di una politica foucaultiana della filosofia. Mi riferisco non già, o non solo, al senso oggettivo del genitivo e cioè al modo nel quale la filosofia è stata inquadrata ed istituzionalizzata rispetto alla gerarchia dei saperi, processo del quale è facile fare la critica critica, ma al modo nel quale la filosofia può caricarsi di un compito direttamente politico una volta si accrediti, innanzitutto rispetto a sé stessa, come pratica e come pratica situata. Dire, come lo fa Foucault, che la verità è di questo mondo significa fondamentalmente dire che un «fuori» rispetto ai giochi di potere non c’è e che la filosofia è un sapere a sua volta «potente» perché il solo capace di farsi carico di un effetto di verità prima di tutto sul lato del soggetto. La filosofia è una pratica di soggettivazione e, proprio per questo, un’etica e una politica. Più precisamente, un’etica del lavoro intellettuale e una politica della verità. Credo sia questa la questione al centro delle ricerche dell’ultimo Foucault. «Coraggio della verità» è la formula per mezzo della quale egli nomina quella radicale responsabilità di sé della quale chi pensa, scrive o insegna in un’«epoca senza Dio e senza profeti» deve farsi carico problematizzando lo statuto dei saperi e il proprio stesso «mestiere» di altrimenti «piccolo profeta privilegiato e pagato dallo Stato». Le citazioni le traggo dalla conferenza del 1919 di Max Weber (Wissenschaft als Beruf), un autore che io ritengo stia alla base delle ricerche foucaultiane sul governo di sé. E non credo sia un caso che l’uomo «davvero musicale in senso religioso» in essa richiamato, colui che si dimostri «in grado di affrontare virilmente» (männliche erträgen) il destino di vivere il tempo svuotato dall’Entzauberung capitalistica, evochi in qualche modo l’accordo dorico del Lachete platonico (188d): quell’accordo tra «parole e azioni» su cui si armonizza «la vita stessa» di chi abbia il coraggio di sostenere la prova della filosofia.
Terzo passaggio: viene con ciò prolungata una semplice retorica dell’impegno intellettuale? Non credo. Quando Foucault tematizza il proprio ruolo di «intellettuale specifico» egli problematizza radicalmente lo statuto della parola. Lo fa, mi sembra, non solo nella direzione del semplice rifiuto dell’impossibile posizione di sorvolo necessaria a difendere ruolo dell’intellettuale come portavoce, o come rappresentante, dell’universale, ma lo fa nel senso di una nuova e differente nozione della critica. Di nuovo: un movimento di andata e ritorno tra intero ed esterno della filosofia. Lavorare ad un’«ontologia del presente» significa per Foucault visibilizzare le linee di fuga che lo attraversano. Significa, in particolare alla fine degli anni ’70, assumere ad indicatore della mobilità del presente le trasformazioni che marcano i nuovi assetti istituzionali che la politica si dà in risposta a processi di soggettivazione che rifiutano la rappresentanza, i partiti, l’idea stessa della conquista del potere. L’introduzione nell’analitica del potere foucaultiana del termine «governamentalità» mi sembra alludere esattamente a questo. E cioè: al movimento in base al quale, in risposta a resistenze «biopolitiche» nelle quali ne va della politicizzazione della quotidianità, dei corpi, del desiderio, il potere decostituzionalizza e desovranizza i propri dispositivi e affronta il «governato» come soggetto inassimilabile per mezzo delle classiche formule identitarie della rappresentanza politica. Foucault torna molte volte sul punto all’inizio degli anni ’80. La teoria politica moderna è ossessionata dal potere. E lavora – da Hobbes a Kant – ad esorcizzare il dominio identificando suddito e sovrano. L’idea moderna di democrazia rappresentativa – si tratta di cose, ovviamente, molto note – porta a compimento questo progetto a livello costituzionale.
Quando Foucault recupera il tema e il lessico del «governo», e lo fa rimontando la cesura definita dalla modernità definendo lo Stato una semplice «peripezia» di quest’ultimo (Sicurezza, territorio, popolazione, p. 254), non solo riallaccia la lunga durata che diventa decisiva anche nelle ricerche sull’ermeneutica e sul governo del sé, ma sgancia governante e governato dal patto di solidarietà identitaria che li lega nel moderno concetto di popolo. I movimenti sociali che egli ha di fronte e ai quali spesso si accompagna, totalmente esterni alla filosofia, ma, ancora di più, alla filosofia dello Stato, della sovranità e della rappresentanza, denotano un processo destituente e installano il «governato» (l’abitante di un territorio assunto come un ecosistema, un corpo indisciplinabile e sessuato, un desiderio selvaggio di libertà di cui si alimentano esodanti processi di soggettivazione irriducibili alle identità o alle fedeltà di partito) di fronte a chi governa come fuoco di un ellisse che nessun «potere» potrà più sciogliere per mezzo di una fictio come quella che le moderne categorie del politico realizzano nel concetto di «popolo sovrano». La figura chiave del rapporto di governo è quella descritta da una polarità, da una tensione, da un due, non dall’unità cui, ad esempio in Hobbes, la rappresentanza riconduce un’altrimenti dispersa moltitudine. La figura, cioè, che mette l’uno di fronte all’altro chi governa e chi è governato senza che essi possano cambiare di posto. Sottolineo questo perché mi sembra che Foucault utilizzi il termine «governamentalità» non solo per alimentare un’altra genealogia della politica, differente da quella sterilizzata dal moderno dispositivo giuridico-sovranista di neutralizzazione del conflitto, e che coincide con la governamentalizzazione del potere che molti teorici neoconservatori, proprio negli anni ’70, auspicano per rispondere alla crisi della democrazia, ma anche per rinnovare completamente l’uso filosofico della nozione di critica.
Ciò che qui entra in questione è la «parrhesia del governato», come Foucault ebbe a precisare proprio nel 1984 (Une esthétique de l’existence, entretien avec A. Fontana, «Le Monde», 15-16 juillet 1984 – Dits et ècrits II, n. 357, pp. 1549-1554). Dentro e fuori della filosofia, dicevo. Parrhesia è un termine del lessico filosofico e teologico, come tutti sanno. Ma Foucault la recupera e studia, io credo, in vista di un duplice compito. Da un lato, sotto il segno di Weber, per mettere in rilievo quella potenza di soggettivazione che la filosofia conserva se capace di sottrarsi ai riti e alle liturgie del lavoro salariato all’Università o nelle istituzioni di ricerca. La filosofia come prova di coerenza; la filosofia presa sul serio come compito, come impegno quotidiano e come verifica della coerenza tra parole e azioni di colui o di colei che prende la parola davanti a un pubblico e di fronte al potere.
Dall’altro, la parrhesia – in questo caso come pratica collettiva, moltitudinaria, resistente – per denotare la presa di parola che impone al governo di rendere ragione di ciò che fa, senza l’obbligo di un realismo politico di cui solo chi governa deve dimostrarsi capace, anche affrontando dissidenze e forme della disobbedienza che non possano essere immediatamente recuperate con il filtro della rappresentanza, del realismo politico (“allora sii tu a dirmi cosa devo fare”) o sanzionate attivando il codice binario legale/illegale. Non è compito del governato, governare. Ed è la consapevolezza di questa trasformazione della politica, risultato di un’ontologia dell’attualità che Foucault prosegue sino all’ultimo, ciò che retroagisce sulla formulazione non solo di un’analitica del potere integralmente sganciata dal dispositivo di sovranità, ma su di una politica della filosofia in cui il coraggio della verità si fa assunzione di responsabilità della prassi, coinvolgimento diretto, inchiesta, genealogia funzionale all’effetto sul presente che si abita. In questo senso, la critica muta drasticamente funzione. Essa non viene più esercitata a partire da un universale, ma dal concreto di una situazione alla quale chi pensa è vincolato e che viene soggettivata mobilitandola ad un presa di parola collettiva. Credo sia in questo senso che Foucault pensa una filosofia “fuori di sé”, integralmente storica, perché strutturata come una genealogia dell’attualità, ed interamente politica, perché è la politica il campo al cui interno solo può determinarsi una veridizione.

Una politica della filosofia è, in questo senso, una politica della soggettivazione. Accennavo in precedenza ad un gesto che rimonta la scissione tra Stato e società sulla quale si alimenta il ciclo delle scienze sociali. Mi sembra evidente che con essa viene rimontata la stessa scissione tra teoria e prassi sulla quale si edifica il moderno sistema dei saperi della politica. Ciò che torna qui in questione è la nozione antica di praxis come rete di relazioni etiche, politiche, comunicative dentro le quali la vita umana viene valorizzata – se si assume la classica definizione aristotelica dell’uomo come vivente politico e dotato di facoltà di parola – come sostrato di una potenza di azione e di inter-azione specificamente connotata in termini linguistici, affettivi e cognitivi. Per gli stoici l’uomo è uno koinonikon zoon, un essere naturalmente aperto ad una dinamica, mi si passi il termine, “costituente” di relazioni tendenzialmente estendibili al cosmo.
Per inciso vale forse la pena di far notare come per gli stoici, il contenuto di una proposizione, ciò che essa significa, non sia mai il riferimento ad un oggetto (definito o concettualizzato, caso degli universali del pensiero, rinvio alle Forme), ma il rapporto in cui si esprime un’attività o un’azione. Un albero, per riprendere un esempio spesso citato, non «è» verde. In questo caso il giudizio deriverebbe, infatti, dall’applicazione di categorie o concetti in cui si predica l’essere. L’«albero verdeggia»: espressione coniugativa che esprime, per mezzo di un lekton incorporeo, un modo dell’essere nell’immanenza della sua attività. Esattamente come nel caso dell’albero, l’uomo non è un animale koinōnikon, secondo una logica dell’attribuzione, ma un animale che kōinōnei, che, in forza di una spinta che lo attiva dal basso della propria systasis, il comune lo fa, lo estende, lo istituzionalizza, lo giuridifica, secondo una prospettiva moltiplicatoria e attiva, che assume gli umani – uomini, donne, operai e schiavi – come uguali, spinti alla socializzazione di sé dall’impulso che li incita a ricercare il giovevole, e come filosofi naturali tendenziali nel processo della cosmopoli universale.
Quando Foucault torna ai Greci, mi sembra, egli lo fa non solo spinto dalla genealogia della governamentalità, ma anche per riattingere uno strato del discorso in cui la vita tout court è pensata e praticata politicamente e la moderna scissione tra cittadino e suddito, tra subjectum e subjectus, tra pubblico e privato non si ancora è prodotta e non ha corso. Quando Max Weber nella parte della Sociologia della religione dedicata all’Etica protestante e allo spirito del capitalismo, un testo al quale Foucault in alcuni casi si riferisce esplicitamente, scrive: «Mentre nel cattolicesimo la redazione di un diario religioso nel quale le colpe, le tentazioni ed i progressi fatti nella grazia, serviva alla compiutezza della confessione e forniva al “directeur de l’âme” la base per la sua autoritaria direzione del Cristiano o, per lo più della Cristiana, il Cristiano Riformato si tastava da se stesso il polso» («Aber während es im Katholizismus dem Zweck der Vollständigkeit der Beichte diente oder dem »directeur de l’âme« die Unterlage zu seiner autoritären Leitung des Christen bzw. (meist) der Christin bot, “fühlte sich” der reformierte Christ mit seiner Hilfe selbst “den Puls”»), è come se offrisse all’interpretazione di Foucault le due differenti opzioni in base alle quali pensare il tema del governo e le pratiche di soggettivazione: quella che concerne l’obbedienza, e dunque il soggetto governato, e quella che riguarda invece le forme di ascesi intramondana come pratiche di veridizione e di costituzione di sé. Quando Foucault, in particolare nel corso su L’Herméneutique du sujet, fa riferimento all’«askêsis» stoica come pratica di veridizione – «l’askêsis n’est pas une manière de soumettre le sujet à la loi; l’ascèse est une manière de lier le sujet à la vérité», egli scrive (L’Herméneutique du sujet, p. 330) – ha tendenzialmente decentrato la propria analisi delle tecnologie di sé funzionali alla definizione di un regime di obbedienza – le pratiche giuridico-confessionali di publicatio sui e di exagóreusis del monachesimo cristiano – al lessico medico-terapeutico del weberiano «tastarsi il polso». Ad un’askêsis intramondana, cioè, che usa gli esercizi spirituali (meditazione, scrittura, esercizi rammemorativi) come pratiche di verifica costante del grado di padronanza e di autogoverno che costituiscono il soggetto decentrandone l’autoriflessione dal paradigma dell’autocoscienza. L’«askêsis» – non una rinuncia, ma un principio di intensificazione della soggettività – è un insieme di pratiche per mezzo delle quali l’individuo può acquisire ed assimilare la verità, trasformandola in un principio di azione permanente. È in questo modo che la verità si fa «praxis», etica («l’alêtheia devient ethos», scrive Foucault nel testo del seminario tenuto all’Università del Vermont nel 1982 [Dits et ècrits II, n. 363, p. 1613]).
Quella forma di ascesi tutta interna al mondo – «hê biotikê», la chiama Marco Aurelio – alla quale egli riconduce una quota significativa della genealogia del soggetto nell’antichità non mutila l’esperienza, né comporta abdicazioni, «elle ne réduit pas: elle équipe, elle dote». Coincide con una preparazione alla vita e agli eventi che la costituiscono. Mi sembra un dato significativo. Non per amore di filologia: lo ricordavo in apertura, non mi interessa studiare Foucault come un Autore. Mi sembra tuttavia estremamente interessante questo movimento di andata e ritorno dalla filosofia alla filosofia passando per un «fuori» che è fatto tanto di processi storici e sociali all’interno dei quali soltanto si rilancia un’etica intellettuale della «problematizzazione», quanto di archivi e testi, non disciplinarmente filosofici, questo il caso di Weber, che impongono alla filosofia una soglia da attraversare per poter istruire il proprio campo e destabilizzare il quadro della propria autoreferenzialità. Uno stile di ricerca e di scrittura, indubbiamente. Una soggettivazione della pratica filosofica, ancora. Un’etica del «governo di sé», infine, in quella vicissitudine che la filosofia si scopre essere, una volta irrevocabilmente presa nel vortice del mondo.
Sul libro di Sandro Chignola “Foucault oltre Foucault. Una politica della filosofia” segnaliamo la recensione di Girolamo De Michele → “Dell’utilità di leggere Michel Foucault”, pubblicata su “carmilla”.

















