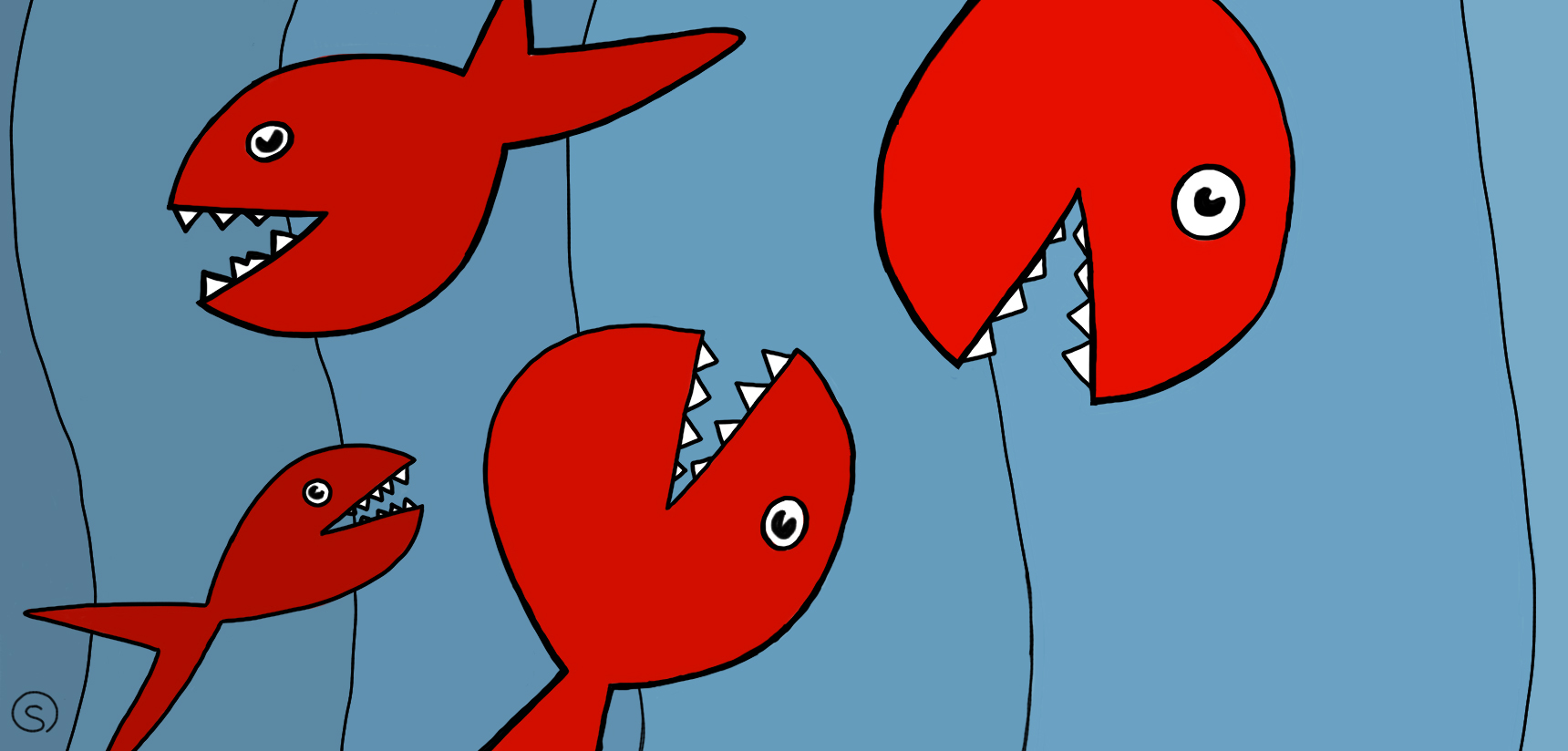di MIGUEL MELLINO e GIUSEPPE ORLANDINI.
Migrazioni e cinema “embedded”
La rappresentazione delle migrazioni nel cinema italiano continua a restare piuttosto problematica. Ultimo esempio di questa lunga narrazione fatta da “ripetizioni senza differenza”, per parafrasare la nota espressione di Deleuze, è Fuocoammare di Gianfranco Rosi, vincitore dell’Orso d’Oro e del Premio Giuria di Amnesty International alla Berlinale. E non è un caso che abbia vinto proprio a Berlino, dato l’ordine del discorso emergenziale imposto dalla cosiddetta “crisi dei rifugiati” che continua a dominare l’attuale congiuntura politica europea. Il film-documentario di Rosi è stato accolto con favore non solo da buona parte dell’opinione pubblica sensibile all’argomento, ma anche in ambiti più o meno specializzati nella ricerca teorica e pratica sul fenomeno migratorio. Tuttavia appare davvero difficile non vedere la narrazione di Fuocoammare come qualcosa di diverso da quel lungo “festival di vittimologia”, “buoni sentimenti” e “paternalismi umanitari” attraverso cui il cinema italiano codifica sin dagli anni ’80 l’esperienza migratoria e il rapporto tra la società italiana e questo fenomeno.
Umanitarismo e cinema “embedded”
Diciamo subito che il film di Rosi (costruito come sguardo documentaristico sul proprio oggetto) ci appare in perfetta sintonia con quel regime discorsivo istituzionale attraverso cui si è cercato di riplasmare, almeno in un primo momento, il management europeo e italiano delle migrazioni dall’estate scorsa in poi. Si tratta di una nuova enunciazione del “discorso umanitario”, emersa come risposta di governo sia all’imponente serie di affondamenti di navi di migranti “illegalizzati” nel Mediterraneo, sia alla “crisi” di gestione delle politiche migratorie della UE innescata nello stesso territorio europeo dal movimento di migliaia di “richiedenti asilo” in fuga dalla Siria e da altre zone di guerra. È chiaro però che questa nuova costruzione umanitaria della crisi deve essere tuttora considerata come un elemento del tutto interno e necessario al regime europeo di controllo (militare, poliziesco e carcerario) dei confini e delle migrazioni. Sappiamo che dagli anni novanta in poi il “discorso umanitario” (nelle sue molteplici traduzioni nel business dell’accoglienza) e il “filo spinato” (in tutte le sue dimensioni materiali e simboliche) sono parti di un unico dispositivo di governo delle migrazioni, la mano sinistra e la mano destra dello Stato, per dirla con Bourdieu.
 Il “grado zero” di questo nuovo “momento umanitario” può essere ben rappresentato dal noto pianto di Angela Merkel, l’estate scorsa, di fronte alla grande diffusione mediatica della foto di Aylan (il bambino siriano morto annegato), e dalla momentanea apertura della Germania e di altri paesi europei alle richieste di asilo da parte dei migranti in fuga e a rivedere in senso contingente la convenzione di Dublino. È a partire da quel momento che il regime di rappresentazione istituzionale/mediatico si è sempre più contraddistinto da ciò che possiamo chiamare il “discorso del riscatto”, ovvero dalla “codificazione” dei migranti sempre più come “rifugiati” (favorendo una ulteriore stigmatizzazione dei migranti economici, completamente esclusi dal discorso), ma soprattutto come “vittime” o “corpi” da “salvare”, da “aiutare” e da “proteggere” perché “sofferenti” e “bisognosi” della nostra “compassione” per una loro “ri-umanizzazione”. È qui necessario sottolineare che questo “discorso salvifico” è cominciato a capovolgersi nel suo “rovescio costitutivo” nell’arco di tempo che va dalla strage del 13 Novembre a Parigi ai misteriosi fatti della notte di capodanno a Colonia e alla loro codificazione razzista prodotta dai media e ulteriormente rafforzata dalle posizioni assunte da molti governi europei. Da qui in poi, abbiamo assistito sempre di più alla costruzione del migrante-rifugiato come nemico pubblico e/o soggetto pericoloso, questa volta nelle vesti del predatore del welfare, del cittadino “binazionale” virtualmente sleale, del potenziale stupratore o terrorista islamico, dello straniero culturalmente inassimilabile.
Il “grado zero” di questo nuovo “momento umanitario” può essere ben rappresentato dal noto pianto di Angela Merkel, l’estate scorsa, di fronte alla grande diffusione mediatica della foto di Aylan (il bambino siriano morto annegato), e dalla momentanea apertura della Germania e di altri paesi europei alle richieste di asilo da parte dei migranti in fuga e a rivedere in senso contingente la convenzione di Dublino. È a partire da quel momento che il regime di rappresentazione istituzionale/mediatico si è sempre più contraddistinto da ciò che possiamo chiamare il “discorso del riscatto”, ovvero dalla “codificazione” dei migranti sempre più come “rifugiati” (favorendo una ulteriore stigmatizzazione dei migranti economici, completamente esclusi dal discorso), ma soprattutto come “vittime” o “corpi” da “salvare”, da “aiutare” e da “proteggere” perché “sofferenti” e “bisognosi” della nostra “compassione” per una loro “ri-umanizzazione”. È qui necessario sottolineare che questo “discorso salvifico” è cominciato a capovolgersi nel suo “rovescio costitutivo” nell’arco di tempo che va dalla strage del 13 Novembre a Parigi ai misteriosi fatti della notte di capodanno a Colonia e alla loro codificazione razzista prodotta dai media e ulteriormente rafforzata dalle posizioni assunte da molti governi europei. Da qui in poi, abbiamo assistito sempre di più alla costruzione del migrante-rifugiato come nemico pubblico e/o soggetto pericoloso, questa volta nelle vesti del predatore del welfare, del cittadino “binazionale” virtualmente sleale, del potenziale stupratore o terrorista islamico, dello straniero culturalmente inassimilabile.
La rappresentazione dell’esperienza migratoria di Fuocoammare ci appare come un ingranaggio interno a questo processo di significazione, ovvero essa acquista (il suo) senso solo come frammento di questo “discorso umanitario” e delle sue corrispettive “strutture del sentire”, le cui “capacità interpellanti” (di mobilitazione soggettiva), peraltro, affondano le radici in un persistente inconscio coloniale europeo; si pensi qui alla codificazione degli sbarchi proposta dal film, la cui “messa in scena” appare chiaramente del tutto internaalla logica vittimizzante e de-soggettivante dell’attuale ragione umanitaria di governo fondata sulla sofferenza e la compassione. Nel clima di umanità melensa, di stucchevoli buoni sentimenti e di semplicità provinciale quasi verginale attraverso cui viene costruita la Lampedusa del film, i migranti appaiono altrettanto “umani”, buoni e semplici dei lampedusani, per non dire innocui – abbiamo qui in mente la scena della partita di calcio giocata dai migranti all’interno di un presunto Centro di Identificazione – , soprattutto perché vittime inermi di forme “inenarrabili” di violenze. Da questo punto di vista, il film si consegna a un godimento necropolitico quasi morboso del migrante-vittima-oggetto–cadavere – nella maggior parte dei casi rigorosamente neri – assai radicato in un certo tipo di immaginario (mediatico-culturale-politico) collettivo incentrato su un nuovo “delirio manicheo”: da una parte la coscienza morale, gli “emancipatori” (coloro in grado di sancire attivamente il riscatto), dall’altra i nuovi schiavi, i “sommersi” da rappresentare (s-oggetti ancora nella sala d’attesa della storia).
Particolarmente grottesche – poiché pervase da un infantilizzazione parrocchiale e coloniale – appaiono le riprese in cui i migranti vengono sollecitati (e messi in quel luogo di enunciazione) dalla cinepresa a “raccontare” e “cantare” a suon di rap le violenze subite. Non solo si attiva qui il solito dispositivo narrativo-pastorale (e razzista) del tipo «vieni raccontami la tua sofferenza, Io la diffonderò e sarò la tua voce e coscienza», ma il racconto stesso “estorto” ai migranti non fa che rafforzare uno dei principali enunciati dell’ordine del discorso umanitario: le violenze ci vengono “narrate” come qualcosa di lontano e scisso da noi (dall’Europa e dalle sue responsabilità), hanno a che fare con la Libia, il Sudan, la Siria, l’Africa, l’ISIS, ovvero con nomi che finiscono per apparire come gli “unici” significanti cattivi del film, e che non fanno che iscriversi ulteriormente in quell’immaginario orientalista e coloniale che da sempre connota quei territori come oscuri, incivili, afflitti da violenze endemiche e “tribali”. Come il discorso umanitario dei nostri giorni, il film costruisce i “rifugiati” come l’effetto di una catastrofe naturale, come il prodotto di un processo del tutto esterno al soggetto enunciante (europeo). Ma cerchiamo di essere chiari: non che il “canto” del proprio sfruttamento o delle proprie miserie è di per sé privo di forza o di autonomia soggettiva, la storia dei soggetti oppressi (schiavi, indigeni, proletariato industriale, neri, banlieusard ecc.) ci dice proprio il contrario; il problema qui è la cornice di significazione “paternalistica” in cui questa “presa di parola” viene inserita, che non fa che addomesticare ogni istinto ribelle. E poco importa qui il “taglio documentaristico” del film, ovvero se i migranti, ciò che fanno e dicono, così come gli sbarchi, rappresentano la registrazione di situazioni “reali”: si tratta sempre di una rappresentazione soggettiva. Per questo, non ci sembra esagerato definire Fuocoammare come un’altra rappresentazione “embedded” del fenomeno migratorio: la sua soggettiva – la “posizione del soggetto enunciante” – non è molto diversa da quella del Ministero degli Interni, della Marina Militare e delle Misericordie, “istituzioni” che peraltro vengono “ringraziate” per la collaborazione nei titoli di coda del film. Narrare il rapporto di Lampedusa con i migranti a partire dalla presunta umanità del personale istituzionale preposto dallo Stato ad affrontare gli “sbarchi” e “l’emergenza” creata dalle politiche migratorie europee appare qui non solo come un’altra variante del “nazionalismo metodologico” nella rappresentazione delle migrazioni, ma soprattutto una strategia discorsiva assai discutibile in un momento in cui è sempre più chiaro che il “sistema dell’accoglienza” è semplicemente un gigantesco “business umanitario” finalizzato sia allo sfruttamento spudorato dei migranti (vedi Mafia-capitale), sia alla produzione di forza lavoro “servile” (vedi provvedimenti come la costrizione al pagamento dei servizi e dei ticket sanitari da parte dei “rifugiati”, la confisca dei loro beni, il ritiro dei benefits ecc.). Detto in modo semplice: crediamo che il punto non stia nell’umanità o meno dei soccorritori, ma nella disumanità delle istituzioni che rappresentano, tutti pilastri dell’attuale regime di controllo, illegalizzazione e sfruttamento delle migrazioni.
Lampedusa tra banalità del bene e italiani brava gente
Il panorama non cambia se rivolgiamo l’attenzione allo sguardo che il film ci offre su Lampedusa. La rappresentazione dei lampedusani è costruita entro la cornice discorsiva di una “banalità del bene” già vista. Anche qui, poco importa se i personaggi del film sono “veri”, abitanti dell’isola e personale appartenente alle forze dell’ordine che recitano loro stessi e la loro vita quotidiana. Ogni personaggio del film – i due bambini, le casalinghe rigorosamente “orientalizzate” o “sicilianizzate”, il medico, i carabinieri, i lavoratori, i pescatori, il conduttore del programma radio ecc. – svolge la sua vita quotidiana facendo il “bene”, mostrando il suo “umile” e “faticoso” apporto al “bene comune” all’interno di una comunità locale codificata come qualcosa di molto vicino allo stato di natura ipotizzato da Rousseau sul buon selvaggio. Lo sguardo “folklorizzante-esotizzante” del film anche qui va a colpo sicuro, nel senso che funge da specchio per un certo tipo di godimento nazionale identitario, improntato a un’autorappresentazione della “regionalità o località” come forma di vita di per sé buona, semplice e soprattutto genuina (sintomatica è qui la scena in cui ci viene mostrata la mamma del bambino-protagonista mentre cucina la pasta con i calamari).
In questo contesto, risulta particolarmente stucchevole il discorso-sermone del medico dell’isola sulla sofferenza dei migranti, sui loro bisogni e sul suo impegno verso di loro. Ancora una volta, come per il resto dei personaggi, ciò che conta qui non è la loro “veridicità” o meno, poiché ciò che arriva a noi non è la loro realtà grezza di tutti i giorni vissuta in prima persona (che può essere anche di grande valore e dignità) ma la codificazione discorsiva di quella realtà prodotta da questa particolare narrazione – non il medico reale, dunque, bensì il medico di Fuocoammare. Ciò che ci interessa qui non è tanto la realtà che mostra il film quanto il suo modo di rappresentarla; non Lampedusa, ma la Lampedusa di Rosi. È chiaro, dunque, che quanto diciamo non riguarda la vita reale dei personaggi, ma la “politica della rappresentazione” su cui il film costruisce e ci trasmette quella loro esperienza.
 Questa “politica della rappresentazione” concede molto all’immaginario nazionale-coloniale degli “italiani brava gente”: la narrazione di Rosi è infatti priva di contraddizioni (di cattiverie, di ambivalenze). Non vi è, per esempio, alcuna traccia di razzismo popolare o istituzionale, come se questi fenomeni non facessero parte del vissuto quotidiano dell’isola. La cosa potrebbe avere anche un suo lato di verità, ma ci chiediamo: a cosa serve questa auto-rappresentazione? O meglio: c’è ancora bisogno di produrre questo tipo di narrazione “pastorale” e “conciliante” in una società in cui, non solo le violenze e le aggressioni razziste sono all’ordine del giorno, ma che al tempo stesso fatica molto di più di altre società europee ad assumere il razzismo – in quanto eredità del proprio passato coloniale – come un dispositivo costitutivo, per dirla qui con Foucault, dello stesso processo di produzione della nazione e della sua popolazione?
Questa “politica della rappresentazione” concede molto all’immaginario nazionale-coloniale degli “italiani brava gente”: la narrazione di Rosi è infatti priva di contraddizioni (di cattiverie, di ambivalenze). Non vi è, per esempio, alcuna traccia di razzismo popolare o istituzionale, come se questi fenomeni non facessero parte del vissuto quotidiano dell’isola. La cosa potrebbe avere anche un suo lato di verità, ma ci chiediamo: a cosa serve questa auto-rappresentazione? O meglio: c’è ancora bisogno di produrre questo tipo di narrazione “pastorale” e “conciliante” in una società in cui, non solo le violenze e le aggressioni razziste sono all’ordine del giorno, ma che al tempo stesso fatica molto di più di altre società europee ad assumere il razzismo – in quanto eredità del proprio passato coloniale – come un dispositivo costitutivo, per dirla qui con Foucault, dello stesso processo di produzione della nazione e della sua popolazione?
Forse l’obiettivo era narrare l’isola da un punto di vista diverso da quello del regime di rappresentazione mediatico dominante incentrato su Lampedusa come “isola-prigione a cielo aperto”, teatro di uno scontro razzista permanente tra abitanti dell’isola e migranti. Tuttavia, ci sembra che contrapporre l’immagine di un’”isola paradiso” altrettanto a “senso a unico”, per riprendere qui la frase di Benjamin, di quell’altra rappresentazione demonizzante, non solo resta dentro i codici della stessa “semplificazione manichea”, ma finisce per rendere grotteschi e inverosimili anche quei frammenti di rappresentazione che appaiono più credibili e certamente desiderabili. Come insegna il lavoro di Edward Said, le rappresentazioni a senso unico finiscono sempre per orientalizzare-essenzializzare gli oggetti del loro discorso. Se si voleva narrare la vita nell’isola a partire da diverse “storie” o “punti di vista” (come il film sembra proporre), per ridare credibilità, complessità ed eterogeneità alla narrazione, questi diversi punti di vista devono entrare in collisione-contraddizione fra di loro; se si narrano diverse situazioni che in realtà raccontano la stessa cosa, non si guadagna affatto in complessità o veridicità, ma si cade nella “macchietta”: buoni-buonissimi, cattivi-cattivissimi.
La costruzione umanitaria e l’incrostazione coloniale si dispiega poi anche attraverso una sorta di empatizzazione paradossale e gerarchica. La pietà che il medico e l’intero docufilm suscitano resta confinata in un buonismo verticale e autoassolutorio: non c’è traccia di colpevoli, il sentimento di misericordia è calato dall’alto (come lo spirito santo) e non vi è il benché minimo segno di un coinvolgimento comune dei soggetti. Questo distacco si esprime anche nella mancanza di un rapporto tra la narrazione sui lampedusani e quella sui migranti. Non c’è alcuna presenza reciproca nelle rispettive rappresentazioni, alcun riferimento all’insieme di relazioni ed effetti ambivalenti e complessi che il flusso degli sbarchi porta sull’isola, se non attraverso il frame compassionevole (quando alla radio giunge notizia dell’ennesima tragedia inmare e la donna di casa esprime dolore).Qualcosa che appare persino nella scelta di una sorta di montaggio alterno, come si trattasse di un dialogo “muto” tra due (s)oggetti-film.
Probabilmente ciò definisce una precisa volontà dell’autore, che viene a saldarsi con l’allegoria dell’occhio pigro diagnosticato al bambino. È chiaro che tale scelta narrativa mira a stimolare un’identificazione affettiva con l’altro, un suo riconoscimento; e tuttavia rappresentare i migranti come meri corpi sui quali intervenire con umanità e clemenza senza fare i conti, se non con l’insieme, almeno con alcuni dei dispositivi di disumanizzazione e sfruttamento che questi soggetti vivono, oltre che alimentare il proprio ego di buoni sentimenti, finisce per rispecchiare la pigrizia (malafede, direbbe Sartre) dello sguardo del regista, del cinema italiano e delle giurie internazionali rispetto al tema delle migrazioni. Una pigrizia interessata (malafede) e (post)coloniale.
Un cinema contro la soggettività migrante
Fuocoammare, dunque, non fa che confermare qualcosa di già noto: nel momento di scegliere come rappresentare al cinema i migranti, in Italia la prima scelta è sempre il racconto paternalistico e vittimizzante. È così che altre realtà (se così si vuole chiamarle) costitutive dell’esperienza e della soggettività migrante in Italia – fughe e rivolte nei Centri d’accoglienza, insorgenze spontanee come quelle di Rosarno e Castel Volturno, partecipazione a “scioperi sociali”, lotte contro lo sfruttamento delle cooperative nel settore della logistica, rifiuto a farsi prendere le impronte digitali o a farsi deportare dove decidono le autorità, reazioni al razzismo istituzionale e popolare, produzione di spazi sociali meticci, ecc. – restano per lo più o fuori dall’occhio cinematografico italiano o raccontate in chiave “salvifica” e attraverso una scelta estetica “realista” piuttosto ingenua. Non che un’estetica “realista” o documentaristica sia di per sé semplificatoria o banalizzante: anzi, film come quelli dei fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne (La promesse, Rosetta, Il matrimonio di Lorna), di J. Audiard (Il Profeta, Dheepan), di A. Kechiche (La schivata), di F. Akin (La sposa turca) o del Kassovitz de L’odio, tanto per citare alcuni, ci dicono il contrario. Il problema è che spesso il cinema sulle migrazioni in Italia è raccontato da un “realismo” così privo di ambizioni estetico-formali che si finisce per essenzializzare ulteriormente il fenomeno, per degradarlo a un genere minore (di mera cronaca) oramai privo di originalità, scontato e saturo di retorica. I film si susseguono e nulla di nuovo accade. Si sente sempre di più il bisogno di narrazioni cinematografiche che sappiano riconsegnare i fenomeni della migrazione e del razzismo in tutta la loro complessità e ambivalenza; senza racconti umanitari a senso unico, utili solo alla buona coscienza del narratore e dell’audience cui si rivolge, e soprattutto che abbiano il coraggio di evitare ogni “ambizione pedagogica” (per stare nuovamente al vecchio Bourdieu critico del sistema scolastico) o “pillola moralistico-educativa”. Di film sulle migrazioni “da fare vedere nelle scuole”, per così dire, francamente non se ne può più. L’incapacità di produrre narrazioni più politicamente scorrette, in grado di rompere (anziché rafforzare o celebrare) quei soliti cliché che attraversano l’immaginario nazionale-coloniale su questi argomenti, appare sintomatico di tutti i limiti sia dello stato dell’antirazzismo in Italia, sia dei suoi modi di pensare il rapporto tra il sé e gli altri. Forse un buon primo passo per interrogare e andare oltre questi limiti è cominciare a pensare un cinema sulle migrazioni che sia in grado di assumere come punto di partenza la necessità di una decolonizzazione del proprio sguardo, vale a dire la problematizzazione costante sia delle proprie concezioni-proiezioni sull’oggetto della rappresentazione, sia del proprio rapporto con esso. Anche qui, come altrove, non esiste dunque una “questione migrante” da rappresentare, ma una “questione nazionale” con cui fare i conti.