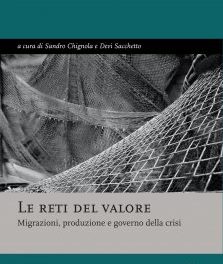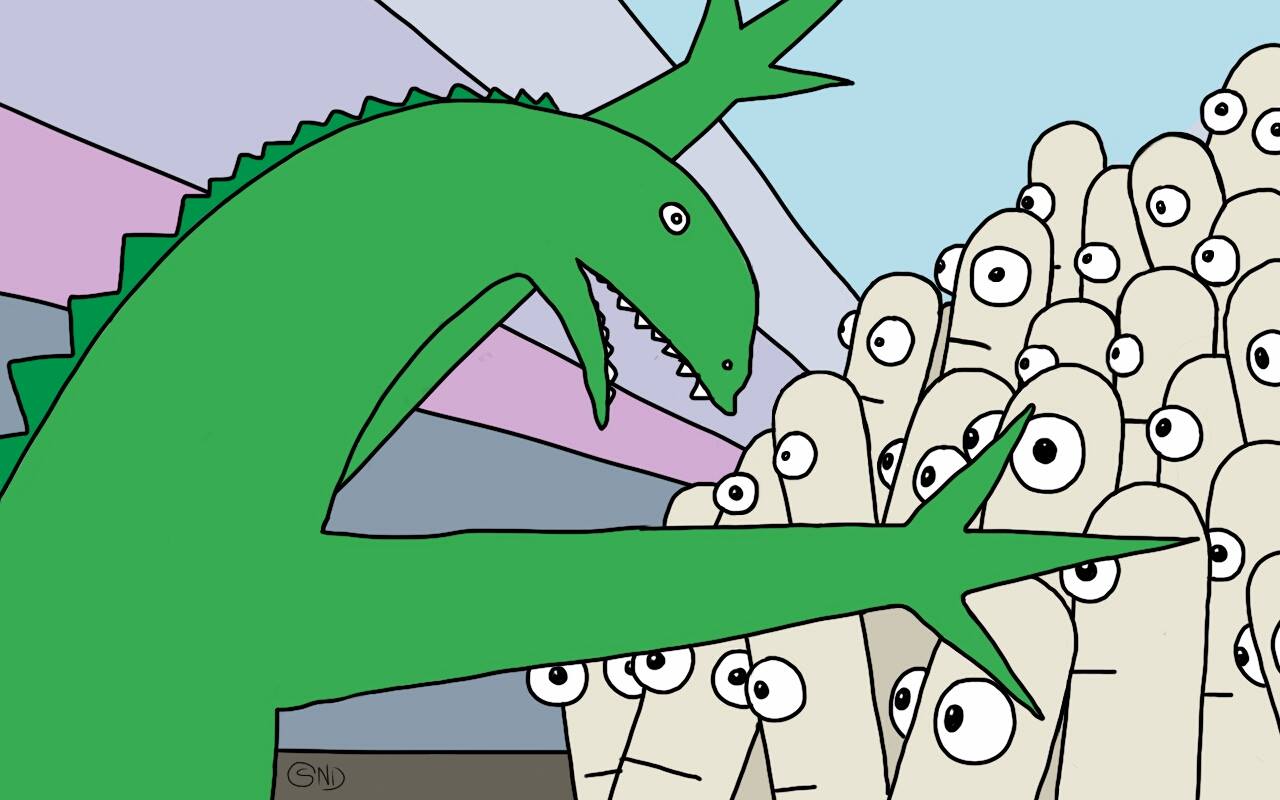di MARTINA TAZZIOLI.
Mercoledì 20 aprile, sei del mattino, Mitilene: tre squadre di polizia fanno irruzione nelle tende del NoBorder Kitchen situato su una spiaggia a poche centinaia dalla cittadina, arrestano i 350 pakistani presenti al campo e li trasferiscono all’hotspot di Moria, che dal 19 marzo, giorno successivo all’accordo UE-Turchia, è divenuto ufficialmente una “closed facility”, come lo definisce UNHCR, ovvero un centro detentivo di prima espulsione. Il NoBorder Kitchen camp era stato aperto da alcuni attivisti inglesi e greci lo scorso novembre come spazio sicuro per coloro che decidevano di non registrarsi all’hotspot. Per capire cosa questo sgombero del campo NoBorder racconta delle trasformazioni dell’isola-frontiera è necessario ricostruire gli eventi avvenuti a Lesbo, sia quelli visibilizzati dai media sia quelli rimasti solo negli archivi delle autorità greche e delle agenzie europee preposte al governo delle migrazioni. Una ricostruzione che comporta di inseguire la temporalità concitata che ha caratterizzato lo spazio-frontiera di Lesbo negli ultimi nove mesi, quando gli arrivi hanno cominciato ad aumentare in modo sostanziale, e che poi ha subito un’ulteriore da settembre, data della trasformazione del centro di detenzione di Moria in hotspot. Una frontiera, quella di Lesbo, che ha cominciato a subire trasformazioni a un ritmo repentino, nelle geografie detentive e nelle funzioni di filtro, contenimento e identificazione dell’isola. Da “transit point” a velocità differenziali, a seconda delle nazionalità delle persone che lo attraversavano, a isola-prigione con molti hotspots, oltre a quello ufficiale di Moria: il mutamento nelle forme di cattura sulle vite dei migranti a Lesbo è una delle conseguenze principali e maggiormente visibili dell’accordo UE-Turchia e del riassestamento delle politiche europee di contenimento degli attraversamenti dei migranti nel Mediterraneo.
Fino al 18 marzo scorso l’hotspot funzionava essenzialmente come centro di prima identificazione e non come spazio detentivo, e la pratica di identificazione era la condizione per ottenere il lascia-passare di sei mesi – per i siriani – o di un mese – le altre nazionalità –, reimbarcarsi sul traghetto per Atene e proseguire il viaggio verso la Macedonia. In realtà, un trattamento differenziale è stato messo in atto già a novembre scorso nei confronti di cittadini algerini, tunisini e marocchini, dichiarati soggetti ad arresto immediato; anche se questo di fatto non avveniva per mancanza di strutture detentive sufficientemente capienti, e dunque le persone in questione restavano piuttosto non identificate ma prigioniere, non nell’ hotspot, ma sull’isola di Lesbo. A fine febbraio, quando le negoziazioni tra UE e Turchia hanno cominciato a riprendere dopo un periodo di stallo di due mesi in cui il premier turco Erdogan aveva minacciato di inviare migranti come “bombe umane” sulle coste greche, Lesbo cominciava a divenire isola-prigione anche per altri “alcuni”. Questi “alcuni” erano le persone di nazionalità pakistana, anch’essi soggetti a detenzione immediata in base a una direttiva verbale del governo greco, simile a quella emanata per cittadini di paesi del “Nord Africa”, e che stabiliva inoltre che nessun permesso per lasciare l’isola con il traghetto poteva essere loro rilasciato. Tuttavia, gli arresti sono stati in realtà marginali, mentre il modo in cui veniva gestita l’illegalizzazione dei migranti di nazionalità pakistana era attraverso una doppia trappola: quella dell’asilo e quella spaziale. Infatti, per coloro che decidevano di registrarsi a Moria per chiedere asilo, scattava il mandato di arresto nell’ hotspot, che per i pakistani funzionava dunque già come centro detentivo. Tutti gli altri, rimanevano “liberamente” prigionieri a Lesbo, ovvero bloccati dai confini geografici dell’isola in quanto privi del permesso di procedere con il traghetto per Atene. Il NoBorder Kitchen camp era dunque uno spazio-rifugio, più che di transito, per le nazionalità in quel momento illegalizzate dal sistema hotspot e prodotte come scarti in eccesso, inassimilabili dal meccanismo della relocation; più banalmente, pakistani e nord-africani dovevano essere bloccati fin dal primo ingresso in Europa visto il blocco selettivo che in quel momento avveniva al confine greco-macedone di Idomeni, dove solo siriani, afghani e iracheni in piccoli numeri venivano fatti passare. Perché i pakistani? La domanda la pongo al responsabile UNHCR sull’isola, che con la sua risposta rimarca la politica dei numeri che sempre sottende il governo delle migrazioni: “perché dopo le nazionalità considerate più qualificate per la protezione internazionale rispetto ad altre – ovvero siriani, afghani e iracheni – i pakistani qui a Lesbo rappresentano il gruppo più numeroso”.
Tra il 18 marzo e il 19 sera, raccontano gli operatori di Medici senza Frontiere, l’hotspot è stato prima parzialmente “svuotato” e poi è diventato un centro di prima espulsione: per fare “spazio” ai nuovi arrivi, il 19 mattina i migranti ancora dentro all’hotspot e arrivati precedentemente alla firma degli accordi sono stati fatti partire in traghetto con un permesso temporaneo, verso Atene. Da quel momento, i cancelli di Moria si sono chiusi, e chi arrivava all’hotspot da quel giorno si trovava in mano un foglio di detenzione, non nominativo, che recita in poche righe: “dal 20 marzo è entrato in vigore l’accordo UE-Turchia, è altamente probabile che resterai detenuto nell’hotspot di Moria fino a che non ci saranno decisioni sul tuo caso. Puoi comunque fare ricorso contro il provvedimento di espulsione in Turchia previsto dall’accordo e chiedere asilo”. Il 4 aprile ha avuto luogo la prima deportazione in Turchia, coordinata da Frontex, con traghetti di linea turchi. Insieme a questa riorganizzazione delle funzioni dell’isola-frontiera di Lesbo all’interno del regime europeo di controllo dei confini, anche in mare, negli ultimi due mesi, si sono verificati importanti riassestamenti spaziali, anch’essi effetto dell’accordo UE-Turchia. Fino a inizio 2016 la maggioranza delle imbarcazioni dei migranti arrivava nel nord dell’isola, dove il tratto di mare che separa Grecia e Turchia è molto più breve rispetto alla zona sud di Lesbo; e le imbarcazioni arrivavano prevalentemente in modo autonomo, fino sulle spiagge, oppure venivano soccorse in mare dalle molte organizzazioni giunte sull’isola lo scorso autunno con l’obiettivo di effettuare operazioni di “search and rescue”. Oltre alla nota missione di Medici senza Frontiere, che operava con vare imbarcazioni anche nel Mediterraneo centrale, ben altre sette organizzazioni erano presenti sull’isola a questo scopo, tra cui Sea-Watch, anch’essa operativa in estate tra Lampedusa e la Libia. La guardia costiera greca in quel periodo interveniva solo sporadicamente, ed era piuttosto in coordinamento con le navi di Frontex che queste imbarcazioni non-governative agivano. Quando le autorità turche hanno iniziato a febbraio a pattugliare e intercettare imbarcazioni in quel tratto di mare, la rotta degli attraversamenti si è allungata e sposata a sud, e al contempo la guardia costiera greca, in stretta collaborazione con Frontex, ha iniziato a salvare/intercettare tutte le imbarcazioni di migranti presenti in acque greche, conducendole nel porto di Mytilene, a sud dell’isola. Da li, poi il trasferimento immediato nell’hotspot di Moria. Il salvataggio diventava dunque il primo atto della catena di contenimento che cominciava a essere rodata nel mese precedente all’accordo: dal mare all’hotspot centralizzando sempre più le pratiche di soccorso e di trasferimento, mentre gli attori dell’umanitario si trovavano sempre più marginalizzati.
Di fatti, a differenza di quanto avviene a Lampedusa e nel sistema hotspot italiano, il governo degli arrivi via mare a Lesbo è stato caratterizzato dall’intervento di organizzazioni e singoli che nel giro di pochi mesi, a partire dall’estate 2015, hanno messo in atto la logistica dell’accoglienza, in un momento in cui le autorità greche tendevano piuttosto ad agire il meno possibile, in mare come dopo lo sbarco. La moltiplicazione delle organizzazioni non-governative, più di cento attualmente e la proliferazione del “turismo dell’umanitario” – associazioni di volontariato provenienti da vari paesi europei che incoraggiano a trascorrere un periodo sull’isola per contribuire all’assistenza dei migranti -sono state indubbiamente parte delle trasformazioni dello spazio-frontiera di Lesbo negli ultimi sei mesi. Tuttavia, il cambio di marcia dopo l’accordo vede piuttosto molte di queste associazioni senza più spazio di manovra, soprattutto rispetto ai soccorsi in mare, e altre invece del tutto cooptate nel sistema detentivo dell’hotspot. Tornando alla scena del salvataggio in mare, oltre alla centralizzazione dei soccorsi da parte della guardia costiera greca e di Frontex, questa è caratterizzata dalla presenza di nuovi attori, ovvero le imbarcazioni dell’operazione NATO lanciata l’11 febbraio scorso per “supportare Grecia e Turchia nel governo della crisi dei rifugiati nell’Egeo”. Otto sono le navi NATO che pattugliano quotidianamente il tratto di mare tra Grecia e Turchia all’altezza dell’isola di Chios e di Lesbo, con il doppio compito, ufficialmente dichiarato, di localizzare le imbarcazioni dei migranti comunicando la posizione alle guardie costiere greche e turche, e di effettuare un lavoro di intelligence in mare e raccolta informazioni che vengono successivamente condivise con Frontex. In realtà, spiega un comandante della guardia costiera greca, la presenza della NATO serve a controllare che la Turchia rispetti i termini dell’accordo con l’UE e blocchi e respinga le imbarcazioni intercettate. Difatti, se i numeri parlano di un aumento esponenziale dei push-back effettuati dalle autorità turche1 e la media degli arrivi giornalieri a Lesbo è calata drasticamente da 1400 a 76, questo trend potrebbe bloccarsi nel momento in cui la NATO arrestasse la missione e la Turchia decidesse di alzare la posta nuovamente, chiedendo all’UE ulteriori finanziamenti come condizione per funzionare da pre-frontiera dell’Europa. Per il momento, con i blocchi in mare effettuati dalle navi turche, Lesbo da spazio-frontiera di arrivi si è trasformata in isola-prigione, e di conseguenza la macchina del governo delle migrazioni si è spostata dal momento dell’approdo al centro dell’isola, dove è situato l’hotspot.
Isola-prigione e centro di prima espulsione non significa tuttavia “presa” omogenea sulle vite dei migranti, né centralizzazione spaziale delle pratiche detentive. Osservando attentamente dalla rete dell’hotspot di Moria, e cercando di ricostruire a partire dalle informazioni frammentarie che alcune delle organizzazioni all’interno del centro timidamente rivelano, la spazialità dell’hotspot rivela meccanismi di segregazione differenziale. Le “gabbie” concentriche di Moria, e i limiti di circolazione spaziale differenti per le persone detenute – chi sta nella rete più interna non può accedere alla zona più ampia dove si trova la rete esterna – corrispondono al livello di “pericolosità” dei soggetti detenuti e alla loro grado di “deportabilità”. I criteri in base a cui singoli migranti vengono detenuti nelle barriere più interne dell’hotspot, sono ancora poco definiti ma al momento a trovarsi nelle gabbie più interne sono coloro che sono stati dichiarati da EASO – l’agenzia europea dell’asilo che valuta nell’hotspot di Lesbo le domande di asilo – “not eligible for protection” e che dunque verranno teoricamente deportati in Turchia. Insieme a loro, vi sono coloro che sono stati etichettati come soggetti “pericolosi” dalla polizia greca o che sono stati coinvolti in proteste e tentativi di fuga. Ma la differenziazione spaziale delle modalità di controllo e governo dei migranti sull’isola prosegue oltre le reti del centro detentivo di Moria. Di fatti, la macchina hotspot funziona a Lesbo, segregando spazialmente, all’interno del centro, secondo gradi differenti di “deportabilità”; e al contempo agisce lasciando all’esterno delle reti dell’hotspot i temporaneamente non-deportabili, ovvero le persone che UNHCR ha valutato essere “soggetti vulnerabili” e dunque da governare differentemente. Il campo a libero accesso di Kara Tapé gestito da UNHCR, a pochi chilometri da Moria, ospita 765 “soggetti vulnerabili”. Le persone che abitano il campo teoricamente possono circolare liberamente sull’isola ma in realtà sono costantemente soggetti ad arresto da parte della polizia greca perché senza documento ufficiale che certifichi la loro libertà temporanea e condizionata – allo stato di vulnerabilità. Guardando alle statistiche della “popolazione” del campo salta subito agli occhi che famiglie e soggetti vulnerabili sono quasi esclusivamente di nazionalità siriana, oltre a qualche afghano e palestinese. Vulnerabilità e nazionalità, con la seconda che di fatto definisce quali soggetti possono essere definiti attraverso la prima, sono condizioni che determinano insieme chi e come il sistema hotspot agisce sulle vite dei migranti fuori dalle reti di filo spinato. A questi campi, vanno ad aggiungersi i tre transit camps installati da Medici senza Frontiere, International Red Cross e UNHCR nel nord dell’isola, fino a quando i migranti sbarcavano in quell’area, e che serviva da centro di primo soccorso in cui i migranti sostavano alcune ore prima di essere trasferiti nell’hotspot. Infine, nei pressi di Metilene il centro gestito dall’associazione greca “Pikpa” ospita da qualche mese anch’esso soggetti vulnerabili o con disabilità.
La moltiplicazione degli hotspots sull’isola, se con hotspot intendiamo centri di identificazione e selezione, è stata accelerata dopo l’implementazione dell’accordo UE-Turchia, dato che la prevista detenzione per tutti i neo-arrivati, non sarebbe stata gestibile all’interno di Moria. Inoltre, come in molti altri spazi-frontiera, il governo delle migrazioni opera attraverso tecniche di differenziazione e l’apertura di canali escludenti, quelli dell’asilo, che funzionano precisamente basandosi sulla produzione di una maggioranza soggetti non-qualificati per la protezione. Pertanto, con le nuove regole e procedure di gestione degli arrivi e delle presenze dei migranti Lesbo e la trasformazione dell’isola in un centro di prima espulsione, alla riorganizzazione spaziale si è accompagnata una ridefinizione dei meccanismi di differenziazione e selezione: dopo il 18 marzo potenzialmente tutti deportabili, con alcune nazionalità e “soggetti pericolosi” più deportabili di altri, per non essere rimandati in Turchia, i migranti a Lesbo devono sperare di essere diagnosticati come “vulnerabili” o provare a inceppare la macchina delle espulsioni facendo domanda di asilo. Di fatti, in quel caso viene temporaneamente sospeso il provvedimento di espulsione fino all’esito della domanda; strategia che la grande maggioranza dei detenuti di Moria ha adottato, con un aumento delle domande in due settimane del 40%. Inceppamento che ha significato anche un arresto temporaneo delle deportazioni programmate, e che finora sono state effettuate il 4 e l’8 aprile attraverso traghetti di linea turchi noleggiati da Frontex e con a bordo personale Frontex. Per rispondere a questa mossa anti-espulsione messa in atto dai migranti, EASO ha stabilito di accelerare i tempi di valutazione delle domande, che adesso sono fissati a 15 giorni, ricorso incluso. Al momento sull’isola pochi arrivano e nessuno parte: Lesbo è un’isola-prigione in cui le stesse politiche europee di selezione ed espulsione, oltre a 4000 migranti (quasi tutti adesso richiedenti asilo), si trovano in questo momento bloccate e il sistema hotspot inceppato.
21 aprile, sette di sera: le organizzazioni presenti al campo cominciano a defluire come ogni sera, e resta solo la polizia greca a sorvegliare la zona. Insieme ai poliziotti, una decina di banchetti di locali che durante il giorno vendono panini e bibite ai lavoratori del centro o a chi come me guarda da fuori le gabbie dell’hotspot. Banchetti che la sera si trasformano in punti vendita per i migranti: dalla rete i detenuti di Moria fanno passare monete e dall’alto i venditori gettano pacchetti di sigarette, bottiglie di Coca-Cola o tende da campeggio a trenta euro per chi nell’hotspot è rimasto escluso dai posti letto. Nel frattempo, dall’interno delle gabbie concentriche di Moria arriva un messaggio whatsapp, da uno dei 350 pakistani arrestati il 20 mattina durante lo sgombero del NoBorder Kitchen: “stanotte ci hanno trasferito nella zona B, l’area più interna dell’hotspot. Non ci lasciano chiedere asilo. Il responsabile di EASO è venuto dicendo, tranquilli, abbiamo una soluzione per voi, sarete ricollocati in Turchia”.
Nell’ultimo mese, secondo i numeri forniti dalla guardia costiera turca, vi sono state più di 3000 intercettazioni. ↩