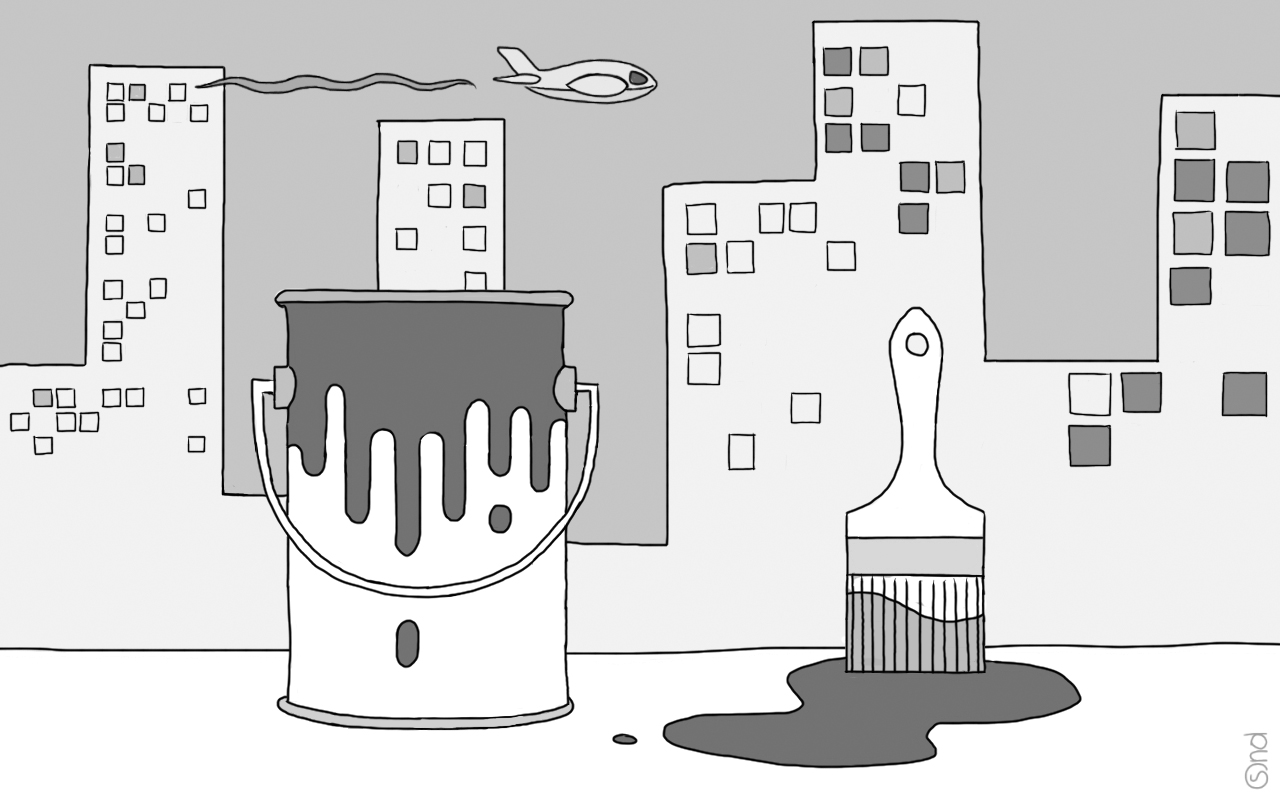Di MARCO BASCETTA
Ci sono molte buone ragioni (in primo luogo quella demografica) per estendere ai sedicenni il diritto di voto e abbassare l’età che consente di essere eletti. Ma il generale interesse per questo tema è indizio di una concezione ipernormativa della vita democratica.
Per sintetizzare all’estremo si tratta dell’idea che i cittadini di una democrazia siano prima di tutto se non quasi esclusivamente «elettori». In conseguenza i partiti intendono la propria vicinanza (ascolto, interlocuzione) ai soggetti della vita sociale come un passaggio verso la conquista del consenso elettorale e del potere, almeno così si dice, di interpretarne al meglio gli interessi e i bisogni. Questo spazio dell’«interpretazione» è occupato dalla democrazia parlamentare senza vincolo di mandato, con il compito di mettere in forma la genericità o la ruvida immediatezza delle istanze popolari, da un lato, e di contrastare la gestione autocratica e verticista delle forze politiche, dall’altro.
Per entrambe queste ragioni la democrazia parlamentare è avversata dai cosiddetti populismi che la accusano di autoreferenzialità, coniando il termine, del tutto inadeguato a definire le compagnie di ventura della politica contemporanea, di «casta». Se pure peccando gravemente di autoreferenzialità, il sistema parlamentare ha comunque fatto finora da argine a possibili derive autoritarie.
Ma, da un altro punto di vista, la virtù principale della democrazia parlamentare è che con lo stabilire l’autonomia degli eletti dagli elettori contempla implicitamente anche quella degli elettori dagli eletti. Gli elettori, infatti, possono ben entrare in rotta di collisione con le decisioni adottate da coloro che hanno eletto e cioè con decreti e leggi varate dal parlamento. E’ ovvio che questa circostanza non può essere digerita da chi nutre una concezione ultralegalistica della vita politica, la quale rimanda ogni conflittualità alla prossima scadenza elettorale, identificando appunto il cittadino con l’elettore. Si tratta beninteso di una semplificazione. L’architettura democratica non si riduce certo al puro e semplice dispositivo elettorale, ma nel discorso pubblico attuale e nell’agire concreto delle forze politiche, tutto finisce in fondo per esservi subordinato.
Lo scarto e la tensione tra governanti e governati (interpretato il più delle volte dagli idolatri della rappresentanza come fattore negativo di crisi) è invece lo spazio decisivo della lotta democratica, uno spazio che include anche i moltissimi che non depositano alcuna scheda nelle urne, ma non cessano per questo di essere soggettività sociali attive.
Almeno fino a quando non avremo conseguito l’«estinzione dello Stato», questo correttivo conflittuale resta l’unico principio di estensione generale della democrazia. Tutte le simulazioni più o meno ingannevoli di «democrazia diretta» non hanno invece altro risultato che quello di restringerla. L’idea, sostenuta su queste pagine da Montanari e Pallante che vede nell’«identificazione tra eletti ed elettori» il «fine ultimo della rappresentanza» è gravida di pericoli.
Se vogliamo evidenziare il baricentro di quella concezione autoritaria che va oggi sotto il nome di populismo, questo consiste esattamente nel perseguire la negazione dello scarto tra governanti e governati in un arco di posizioni che dall’istituzione del vincolo di mandato va fino alla riproposizione del modello patriarcale se non al Fuehrerprinzip. E cioè al rapporto immediato ed empatico tra il «popolo» e i suoi governanti. Finzione certificata da nulla altro che dal consenso elettorale, se non dall’ossessione oracolare dei sondaggi. Il nazionalismo è prima di tutto la menzogna che sta alla base di questo dispositivo fusionale. La propaganda della Lega ce ne offre quotidianamente numerose testimonianze, soppiantando la classica versione borghese della rappresentanza (anche nella variante aziendale del berlusconismo): quella dei cittadini dediti ai propri lucrosi affari che eleggono un amministratore cui delegare l’onere della gestione pubblica, da confermare o licenziare a fine mandato (nell’ormai bisecolare versione di Benjamin Constant).
Tuttavia lo scarto tra governanti e governati, per non finire colmato dalla finzione demagogica di una qualche forma postmoderna di fascismo, deve essere agito su un terreno che non è quello della competizione elettorale. In tutto il mondo i governi considerati progressisti (e per considerare tale quello che ci ritroviamo serve parecchia fantasia) hanno subito profonde involuzioni, e conseguenti sconfitte, non appena questo scarto e questa tensione venivano meno, o il timore di perdere il controllo dei processi sociali e degli equilibri politici da parte del potere costituito spingeva alla chiusura se non alla repressione. In tre ambiti principali, le lotte per il clima, il movimento delle donne e la questione dei migranti la tensione conflittuale è ben visibile. Ma diversi altri fronti possono aprirsi in tempi brevi. Senza per questo temere di favorire una destra che geneticamente non contempla alcuno scarto tra governanti e governati e che combina l’estrema violenza delle sue soluzioni alla cosiddetta «parola degli italiani».
Questo articolo è stato pubblicato su il manifesto il 6 ottobre 2019.