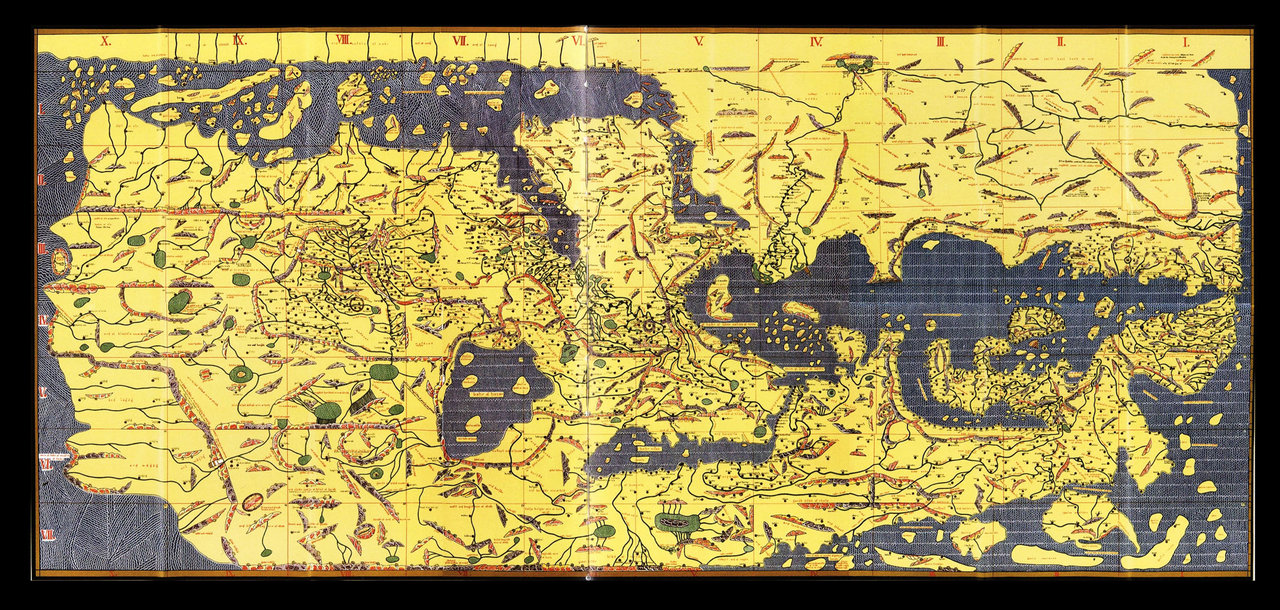di MARCO ASSENNATO.
La discussione sulle elezioni francesi sembra – tranne qualche rarissimo tentativo critico: né entusiasta né liquidatorio – bloccata. Per stare ai più autorevoli rappresentanti di questa opzione secca direi: da una parte chi, con Rossana Rossanda, vede nella vittoria di Hollande una svolta (segnata, dice Rossanda da tre punti, ovvero una trattativa per la revisione del Fiscal Compact, il primato all’occupazione giovanile e il voto amministrativo agli immigrati); dall’altra chi, come Joseph Halevi ritiene si debba uscire dall’effetto ipnotico esercitato dalla vittoria delle sinistre in Francia, per sottolinearne i deficit di proposta socialista, con particolare attenzione alle politiche di budget. Sul sito di Uninomade, invece, Toni Negri nelle scorse settimane proponeva, a mio avviso correttamente, un approccio critico e aperto e chiamava alla necessita di riaprire la discussione direi laicamente. Invito che mi pare oltremodo necessario, innazitutto per tiraci fuori da una lettura tutta chiusa sulla sfera della rappresentanza e del governo – perdipiù nazionali seppur d’una nazione importante – e cercare di sviluppare qualche linea di tendenza. Ragionerei dunque così: dando per acquisiti gli elementi di fondo che sono stati proposti – ovvero: l’attenzione alla composizione di classe post-fordista e cognitiva del voto, localizzata nelle metropoli; l’individuazione dei tratti salienti del programma europeo rinnovato in termini socialisti incarnato da Hollande; il ritardo clamoroso di Hollande, come e persino peggio di Melanchon, rispetto alle richieste, ai claims che vengono dai nuovi soggetti sociali; l’attenzione desta sull’exploit del Front National di Marine Le Pen. E a partire da queste prime linee provare a sviluppare collettivamente l’analisi.
La divaricazione tra capitalismo e democrazia. La stampa francese riserva molto spazio alla ritrovata sobrietà della più alta carica dello Stato, al capovolgimento del carattere da droite decomplexée della presidenza Sarkozy: temi non necessariamente secondari se è vero che nella produzione del discorso politico si muove sempre un tentativo di costruzione di immaginario che produce effetti concreti, e, nel caso specifico della campagna presidenziale gli accenti del presidente uscente si erano fatti vieppiù preoccupanti, violenti, identitari e aggressivi. Oggi respiriamo meglio, si direbbe. D’accordo. E poi? E poi a me pare che vi sia un unico punto chiaro per il nuovo presidente e per i socialisti francesi in generale: la divaricazione tra via tecnocratica e via democratica. Ovvero l’idea che o si trova una soluzione politica alla crisi o salta il quadro democratico intero, ivi compreso il rischio reale d’una uscita xenofoba e neonazi. Voglio dire che l’interruzione delle linee egemoniche neoliberiste sta appunto sul livello biopolitico, coninvolge la meccanica istituzionale e gli spazi di partecipazione democratica, non è, insomma, solo un affare di bilancio. Questo i socialisti francesi lo sanno e non per caso. In primo luogo perché è un sapere prodotto dalle mobilitazioni: se è vero che i movimenti europei trovano nella divaricazione tra capitalismo e democrazia il loro primo punto di convergenza, come ribadito tra l’altro nella bella nota di Sandro Mezzadra su Blockupy Frankfurt. Su questo piano si mette in evidenza la non-indifferenza anche per i movimenti sociali dei risultati elettorali. Scegliere l’avversario può anche significare conquistare linee di agibilità democratica altrimenti difficili. Ed in secondo luogo perché, per dirla in una battuta, Papandreou e la Grecia insegnano: o la democrazia o l’austerità. Uscire da questa tenaglia, prima che sia troppo tardi, costituisce la sfida di Hollande. Ma, a partire da qui, iniziano le questioni.
Europeana: una questione di metodo. Si può leggere il caso francese fuori dal quadro europeo? Seppur riconoscendo, come fa Hollande che la Francia è un paese aperto sul mondo – e come potrebbe essere altrimenti? E quale paese oramai non lo è? – a che vale insistere sul carattere nazionale in questa specifica contingenza? È forse nazionale la crisi? Può un paese, per quanto centrale – o una coppia di paesi, mettiamo la Francia e la Germania ove la Merkel pare destinata a una cocente sconfitta elettorale – determinare uno spostamento apprezzabile delle strategie della governance europea? Mi pare ovvio che no. Ma allora anche la lettura che portiamo sul quadro della rappresentanza dovrebbe essere almeno, diaciamo così, comparatistica: tenere insieme la Francia con la crisi olandese, le elezioni parziali tedesche in Nord Reno Westfalia con le amministrative italiane e con quanto accade in Grecia. Da questo punto di vista il risultato di Parigi appare immerso in una trama di fatti tutt’altro che rassicuranti. E del resto però il peana del socialismo europeo può esser cantato solo su scala continentale. E ancora, lo stesso vale per i movimenti, che pure stanno provando a muovere i primi passi almeno a partire dalle giornate francofortesi. Come ha giustamente notato Mezzadra, infatti, la riapertura di un’iniziativa di movimento in Germania può essere essenziale dal punto di vista delle lotte in Europa. E non tanto o non solo perché riattiva una dinamica di mobilitazione in quel determinato paese, quanto piuttosto perché individua uno dei centri d’uno spazio d’azione che non può che essere continentale. Si manifesta a Francoforte perché Atene, Roma, Parigi, Londra, Madrid e gli altri nodi metropolitani intendano.
Goodbye New Labour. Il problema di fondo però mi pare un altro: la rottura del tempo lungo delle linee egemoniche neoliberiste è asserita ma non articolata dai partiti socialisti europei. Il fallimento del neoliberismo non trascina con sé soltanto Sarkozy e le destre europee (a proposito: che ne è del centro-destra italiano?) ma tira in giù anche quelle sinistre che sullo stesso canovaccio hanno cantato messa almeno dal dopo-Tatcher secondo l’ipotesi blairiana del New Labour. Ora: questo rischio è sentito, dichiarato persino – buona novità – ma i socialisti europei pagano adesso almeno venticinque anni di ubriacatura neoliberista. Voglio dire: pensano ancora in quel modo lì, seppure vedono che non funziona più. Non si recuperano decenni di costruzione ideologica in qualche mese. Insomma mi pare che la questione stia in questi termini: siamo un passo oltre la fine di un ciclo politico il quale, nella sinistra europea, è stato egemonizzato dalla dottrina New Labour di Tony Blair, e a destra dal puro discorso neoliberista. Canto e controcanto d’un medesimo spartito. Ma l’uscita è incerta. A Londra Ed Miliband ha vinto il congresso del Labour insistendo sulla necessità di rompere con il paradigma blairiano – ancora una buona notizia – eppure pare incerto sui passi successivi. Non trova una risposta progressiva. E a guardare il documento strategico del Partito Socialista Europeo per il 2010-2014 (PES Strategy for 2010-2014. A mandate for a change) non mi pare ci siano significativi passi in avanti. La parola d’ordine ècrescita, certo sostenibile e socialmente giusta, al fine di difendere il lavoro e il livello di vita dei cittadini europei. Il good bye New Labour pare ripiegare su una strategia difensiva. Ma da lungo tempo abbiamo imparato che l’unica difesa possibile è l’attacco: che tra capitale e democrazia vince chi ha l’iniziativa. Per dirla con un vecchio classico, ciò accade perché la forza delle due parti è inversamente proporzionale, se l’una cresce e si sviluppa l’altra sta ferma e quindi indietreggia.
La destra neocon oltre l’individualismo. Siamo a un passaggio di paradigma. Lo si vede bene se si guarda l’Europa dal suo punto più avanzato, che non è certo la Francia, né la Germania, ma il Regno Unito. Parlare di Parigi guardando Londra? Sì, se vale l’indicazione di metodo. L’inghilterra e, più in particolare la destra inglese. Qui la primitiva narrazione tatcheriana del neoliberismo, individualista e distruttiva, è sostituita – questa sembra a grandi linee l’unica opzione in campo – dalla nuova narrazione, del Primo Ministro neocon David Cameron. Come è noto, la signora Tatcher amava ripetere che “la società non esiste”, esistono solo individui singoli presi nelle maglie del sistema economico-finanziario. L’impresa aveva in tal senso una responsabilità sociale, perchè è l’unico strumento di mediazione efficente tra le persone. Ora questo racconto s’è infranto sulla crisi. Ma ad esso ne viene sostiuito un secondo, prodotto da una dinamica di restringimento e intensificazione su tre livelli. Lo Stato si ritira, restringe la sua ampiezza fino ad annullarla, dai territori del Welfare e dei diritti, e concentra la sua intensità sulle funzioni repressive, poliziesche e militari (sia dentro che fuori dai confini) – così esso abbandona ogni punto di contatto con i cittadini che non abbia carattere di controllo securitario; le strutture economico-finanziarie ritirano il loro impegno sulla responsabilità sociale e intensificano la speculazione finanziaria in vista di profitti immediati e virtuali; e la società? essa diventa, nel racconto neoconservatore The Big Society. Esiste eccome, altro che individui! Ad essa vengono demandati, a titolo ovviamente gratuito e volontario, tutti quei compiti dai quali il Welfares’è tirato indietro: dall’assistenza, alla solidarietà, ai servizi, ai diritti in una utopica quanto irrealizzabile e premoderna visone eco-anarchica. Questa ipotesi è socialmente insostenibile – bastino le notti infuocate di Tottenham a segnare il limite.
Per una politica affermativa. L’urgenza che le sinistre in Europa, Hollande compreso, rischiano clamorosamente di mancare sta tutta nella possibilità di una politica affermativa. Ossia nella possibilità di far leva sul corpo concreto della società europea per assumere interamente lo spazio della crisi come orizzonte della costituzione di un nuovo piano politico. Dalla crisi alla liberazione, si direbbe. Nulla di difensivo e neppure alcunché di compatibile con rilanci veterokeynesiani: e ciò ben al di là della pur corretta osservazione di Christian Marazzi sulla diversa velocità tra tempi della finanza e tempi della politica economica. Sono le soggettività sociali e la struttura economica reale a surclassare ogni ipotesi di rilancio keynesiano. E neppure possiamo accomodarci in moralismi o nostalgie conservatrici, come ipotizzato dai vari profeti della decrescita (sui quali vale pienamente la battuta di Marazzi che ci ricorda che in decrescita siamo già ma è tutt’altro che felice). Il punto è davvero: come si coniugano politiche produttive, di crescita, di redistribuzione della ricchezza e riappropriazione del comune? Su quali assi pensare un Welfare comune che sostituisca quello statalista-socialdemocratico, certo nobile ma che ha compito il proprio ciclo storico nel secolo scorso? Su questi nodi, socialisti e neocon (francesi e non) hanno ormai da proporre solo ideologia. Allora varrebbe forse la pena innanzitutto di riprendere un vecchio costume operaista: partire certo dalla composizione di classe del nuovo proletariato cognitivo ma per sviluppare una critica dell’ideologia della socialdemocrazia (in crisi) e unapratica di questa stessa critica. Dalla soggettività, alla decostruzione del discorso ideologico, al conflitto. A partire dalla pur positiva esperienza francese. Non vedo altro modo per riaprire la partita europea ed evitare il precipizio della destra xenofoba e nazionalista.