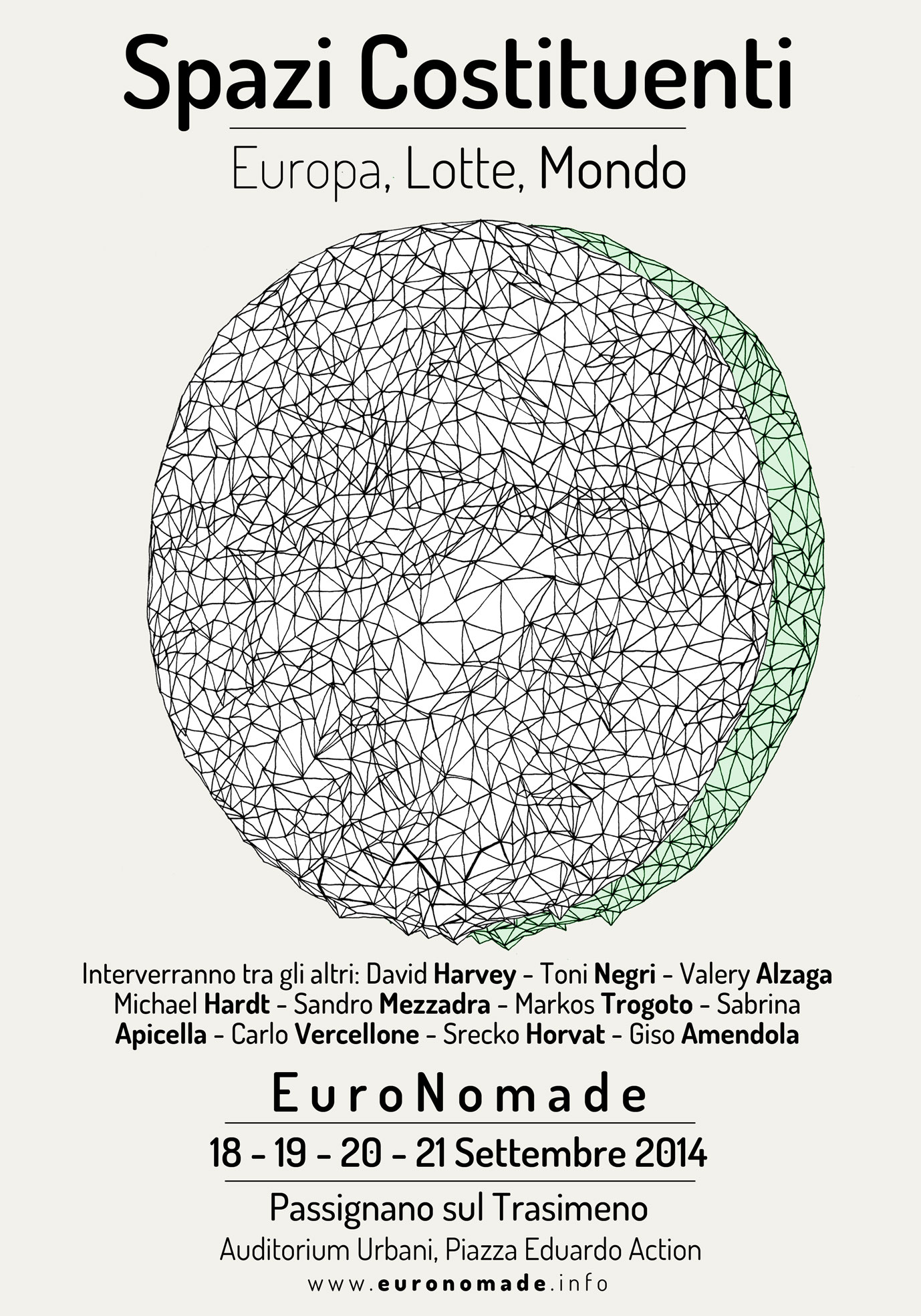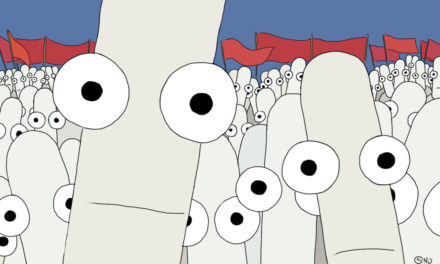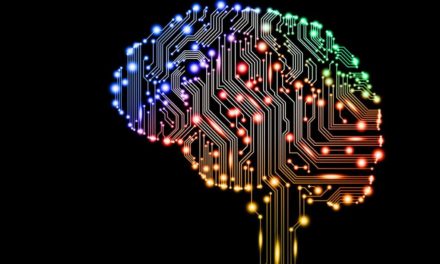Di BIAGIO QUATTROCCHI
Tra agosto e settembre del 1973 scoppiò il colera a Napoli. L’epidemia si allargò ad altri centri del sud. Solo a Napoli, si contarono circa mille ricoveri e un imprecisato numero di vittime: dalle 12 alle 24. Oggi diremmo che il batterio fu tutto sommato assai meno pericoloso del virus del Covid-19. Inevitabilmente il vibrione colpì prima alla testa poi allo stomaco, riportando alla mente collettiva i drammi dell’antico male, che si credeva definitivamente superato a colpi di sviluppo economico, come quando l’epidemia, l’ultima volta nel 1837 devastò la città (quando Giacomo Leopardi fugge trovando riparo a Torre del Greco).
Se il Covid-19 viaggia lungo i flussi globali della produzione, inseguendo il reticolato delle catene produttive, il colera si afferma come la malattia della “rivoluzione commerciale”. Dalla metà dell’Ottocento il vibrione prese di mira principalmente le città portuali, lungo le rotte che dalle Indie passavano per l’Europa e l’Italia. Fu definita come la «malattia della plebe» perché attaccava i sobborghi delle città-porto, aree densamente popolate e in media prive delle infrastrutture sociali fondamentali.
Anche in quella occasione, dall’Asia meridionale il vibrione aveva raggiunto il nord Africa nel 1971, per poi diffondersi con due anni di ritardo a Napoli. Quando si manifestarono i primi casi di gastroenterite, nella città si disse inizialmente che il batterio fosse arrivato a bordo delle barche dei marinai che commerciavano il corallo con Torre del Greco, poi si attribuì a una partita di cozze infettata.
Nonostante i macro-fenomeni legati ai flussi di scambio sovra-nazionali – come nel caso del wet market cinese di Wuhan ai tempi dell’attuale pandemia – anche a Napoli, prevalse invece lo stigma del sottosviluppo.
Quell’onta che non ha mai definitivamente abbandonato la più grande città proletaria d’Italia. Le istituzioni locali non esitarono a coprire decenni di malgoverno, corruzione, clientelismo, mancanza di progettualità, ingaggiando la retorica della ricerca affannosa dei veri colpevoli. Prese avvio una consistente azione di repressione delle reti di economia informale, che da sempre hanno innervato il tessuto economico e sociale della città. Furono smantellati migliaia di cozzicari, venditori ambulanti della «cara còzzeca», come scrisse Eduardo De Filippo in una poesia che ricorda con ironia e amarezza quella storia. Centinaia di persone persero la loro principale fonte di sussistenza, cominciando a lottare per una vita dignitosa.
Nello stesso periodo andavano esplicitandosi i primi effetti della ristrutturazione capitalistica. Napoli, al tempo, arrecava ancora i segni dell’industrialismo a tappe forzate del Mezzogiorno. Le statistiche la davano come la quarta città industriale d’Italia, anche se la maggioranza della forza lavoro era occupata nel terziario povero della città. Le prime ad andare in crisi furono le fabbriche del calzaturiero e la produzione dei guanti. Nel 1975, secondo alcune stime, il 12,5% del totale dei disoccupati italiani viveva a Napoli, così come oltre il 20% della disoccupazione giovanile.
Fu proprio in quell’anno che il rigagnolo delle lotte dei proletari espulsi dall’economia informale si ingrossò, incontrando le sollevazioni operaie, la loro tradizione, la loro prassi organizzativa.
I poveri dell’informale partecipavano ai presidi fuori le fabbriche a rischio chiusura. Gli operai aderivano ai blocchi proletari spontanei diffusi in città. Fu in quel contesto, proprio in quell’anno, che a vicolo Cinquesanti, nel centralissimo quartiere San Lorenzo, nacque il primo comitato di lotta dei «disoccupati organizzati». La prima lista: quella di Banchi Nuovi.
Disoccupati ma politicamente organizzati. Suonò come un’eresia. Uno scherzo della storia. Un’anomalia plebea da arrestare, perché pretendeva di minare la dogmatica certezza fondata nell’antinomia occupato-disoccupato: «classe operaia» come espressione di forza, «esercito industriale di riserva» come segno di debolezza. Le chiusure iniziali vennero proprio dalle organizzazioni della sinistra tradizionale: dal Pci, dalla Cgil e da tutti coloro che pensavano che la coscienza di classe fosse inseparabile dal fumo delle ciminiere.
Blocchi stradali, cortei, occupazioni delle sedi del collocamento e delle istituzioni locali: fu lo spartito di questo primo ciclo di lotte. Il nascente movimento dei «disoccupati organizzati», a dispetto della sua articolata composizione interna, risultava in questa prima fase egemonizzato dai tratti del movimento operaio e sindacale. La richiesta fondamentale era il lavoro, un lavoro stabile. Un riflesso di questo approccio si vedeva nelle forme di lotta come «lo sciopero alla rovescia», con i disoccupati che entravano nei posti e si mettevano a lavorare.
Accanto alla rivendicazione di lavoro, quella del controllo dal basso delle liste di collocamento, intesa come rifiuto e opposizione al sistema clientelare su cui reggevano le istituzioni locali preposte all’incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Qualcosa stava nuovamente per cambiare. La figura dell’«operaio massa» entrava in crisi, come riflesso della riorganizzazione della produzione nei centri manifatturieri del nord. Di conseguenza, si stava aprendo nuova pagina della «questione meridionale». Un nuovo rapporto tra nord e sud legato ai problemi economici e politici dello sviluppo.
Presto se ne intuirono i segnali anche all’interno del movimento dei disoccupati. Ci volle, tuttavia, un nuovo shock esterno, un nuovo evento «naturale e drammatico», per creare le condizioni necessarie all’affermazione di un secondo ciclo di lotta, che spostò il baricentro delle rivendicazioni dal lavoro al welfare. Nel novembre del 1980 l’Irpinia fu l’epicentro di un terremoto devastante. Il movimento tellurico non produsse solo migliaia di vittime e sfollati. Insieme ai palazzi crollò un intero modello di sviluppo. Quello precedentemente governato dagli istituti della programmazione economica e diretto centralmente dalla Cassa del Mezzogiorno.
Quando in Campania e a Napoli arrivarono ingenti quantità di risorse per la ricostruzione, il governo si mostrò preoccupato a riordinare il funzionamento del mercato del lavoro.
L’intento era quello di riorganizzare la relazione tra domanda e offerta di forza lavoro, adeguata alla formazione del nuovo modello di sviluppo post-terremoto. Fu varata una riforma del collocamento ispirata al solito eccezionalismo: «misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell’occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata». La riforma fu voluta dalla Democrazia Cristiana, apprezzata però dal Pci e dalla Cgil. Prevedeva che le organizzazioni sindacali svolgessero una funzione di controllo sulle istituzioni di collocamento, diventando parte del governo della forza lavoro.
Lo scopo principale era quello di favorire l’afflusso di manodopera nelle aziende e nei settori della ricostruzione, nonché quello di favorire lo spostamento di popolazione nei nuovi poli di sviluppo, fuori dalla città di Napoli, disegnando la nuova geografia dell’economia produttiva regionale. A comprendere la razionalità dell’intervento furono gli autori della rivista “Metropoli”, Paolo Virno e Lucio Castellano, che scrissero: «Tramite essa [la riforma del collocamento ndr] si vuole portare alla luce un pezzetto di classe operaia “sommersa”, riconoscendole un ruolo nel nuovo assetto di potere. E al tempo stesso si vuole rendere disponibile, fuori dalle precedenti rigidità e vischiosità, molta più forza lavoro di quanta non si sia disposti a concentrare nei nuovi cantieri.
Questa disponibilità verrebbe regolata e amministrata centralmente, senza permettere più che il controllo sull’assistenza sfugga a chi l’elargisce, così da produrre meccanismi di separazione e di autodeterminazione. I nuovi fondi e la riforma del collocamento tenderanno sempre più a far coincidere assistenza e lavoro fittizio. Ecco: lavoro come assistenza, assistenza come controllo. In questo corto circuito, le nuove regole del gioco».
Il presidente americano Nixon, nell’agosto 1969, aveva annunciato la nascita del workfare statunitense, ma siamo ancora molto lontani dalle sperimentazioni europee anni Novanta. Dentro questo lunghissimo periodo, Napoli diventa inconsapevolmente uno dei tanti laboratori istituzionali.
Il “nuovo collocamento” post-terremoto, con i primi dispositivi di “condizionalità” al lavoro, è uno dei vari antenati del contemporaneo workfare. Verrebbe da ribadire: altro che sottosviluppo, inteso come non ancora o come ritardo assoluto!
Il cambio di paradigma fu intuito dai «disoccupati organizzati». Dopo il 1977 nel movimento si affacciarono giovani cresciuti in una congiuntura con alti tassi di disoccupazione, senza la cultura operaia del vecchio gruppo dirigente. Alla rivendicazione unica del lavoro, contrapposero quella del «salario garantito». Che non equivaleva alla richiesta di occupazione garantita (come talvolta è stata scorrettamente interpretata), quanto piuttosto alla nozione marxiana di «salario di sussistenza», questa volta, però, sganciato dalla prestazione lavorativa: «se il lavoro non c’è, ci dovete dare i soldi», dicevano. E aggiungevano: «i partiti vedono la ricostruzione allo stesso modo che la riforma del collocamento, […] cioè come il problema dell’espulsione del proletariato dal centro storico. E legano le due questioni, dove dicono che c’è il lavoro, la vogliono portarci le case e fare i ghetti».
Nasce, insieme alle rivendicazioni femministe sul «salario domestico», una delle prime rivendicazioni italiane intorno al reddito di base incondizionato. Prima del lavoro, dello spostamento coercitivo di forza lavoro da una branca all’altra dell’economia, da una città all’altra, c’è il diritto alla riproduzione sociale e la libertà dei soggetti di autodeterminarsi. Questa era la loro scoperta. Questa è quella che abbiamo dovuto rifare anche noi, l’ultima volta nella pandemia.
La storia sulle origini dei «disoccupati organizzati» forse può risultarci utile. Non solo perché mostra, ancora una volta, la relazione interna tra le epidemie, la loro espansione geografica e le diverse fasi dello sviluppo capitalistico. Chiarisce il rischio legato all’uso politico degli “eventi naturali”: la pandemia oggi, il colera e il terremoto ieri. Più di ogni altra cosa, come indicano i movimenti, va messa a tema la realtà della pandemia come «prima crisi capitalistica nell’antropocene», per dirla con le parole di Adam Tooze. Se è così, dunque, il diritto alle istituzioni di cura e di riproduzione sociale, la richiesta di un reddito di base incondizionato, va sempre di più ricollocata al centro della critica dell’attuale modello di sviluppo e alla necessità di una lotta per la riconversione ecologica.
Questo articolo è stato pubblicato su DinamoPress il 29 maggio 2020