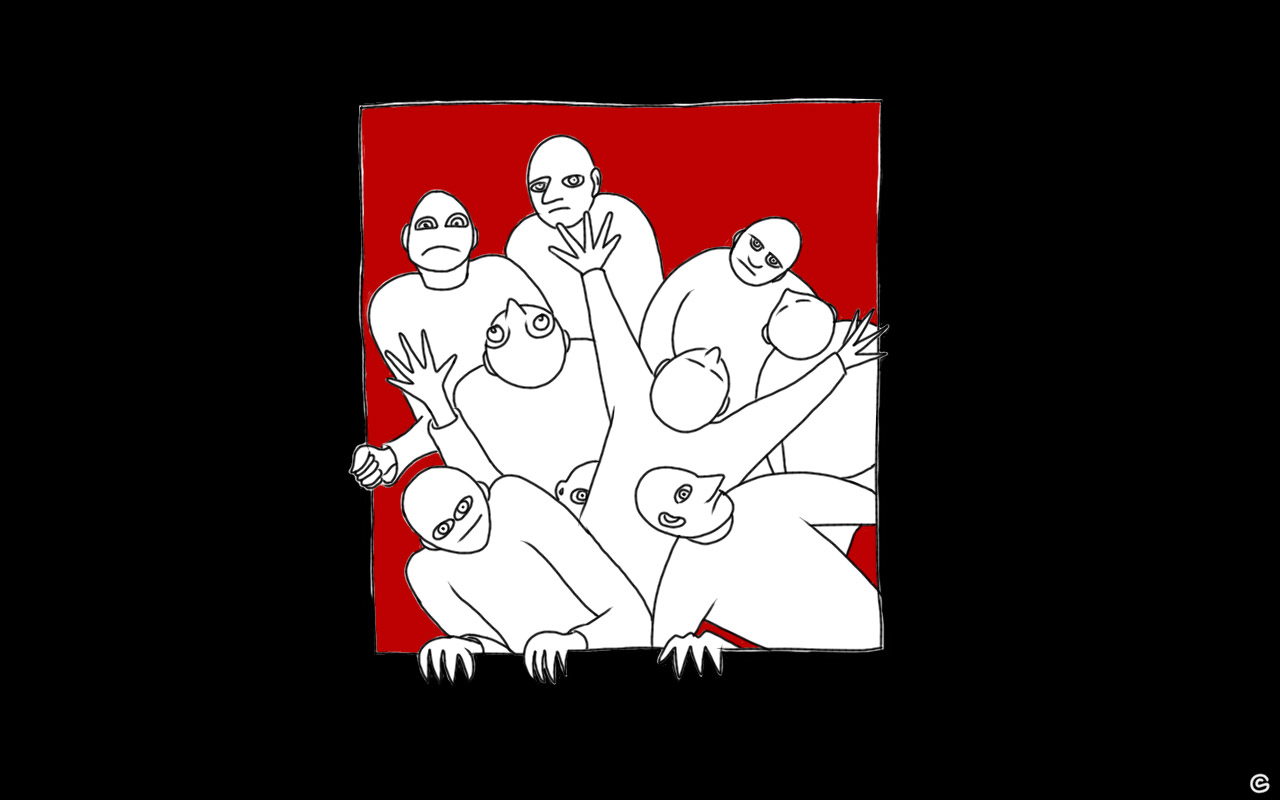Di MARCO BASCETTA
L’allargamento ad est dell’Unione europea si accompagnava a due comode illusioni. La prima, che le fallite democrazie popolari, dopo lo sgretolamento del campo sovietico, non potessero che seguire per filo e per segno il modello democratico dell’Europa occidentale postbellica. In fondo la popolazione di quei paesi era stata martellata per anni da una propaganda che magnificava la società occidentale, i suoi stili di vita e le sue istituzioni politiche. E poi, al tramonto del mondo bipolare a cosa altro ci si sarebbe potuti ispirare?
La seconda credenza suggeriva che i paesi ex socialisti sarebbero stati talmente dipendenti dai capitali e dalle delocalizzazioni industriali di provenienza occidentale (e soprattutto tedesca) da mostrarsi obbedienti e perfino zelanti non solo nell’adeguarsi alle dure leggi delle prestazioni di mercato ma anche nell’imitare le forme politiche in uso presso le potenze economiche del Vecchio continente. In fin dei conti il dogma ideologico dell’indissolubile legame tra economia di mercato e stato di diritto era ancora in pieno vigore. Senza contare il fatto che il disciplinamento dei lavoratori nei paesi dell’est, i bassi salari e la debolissima forza contrattuale dei sindacati non dispiacevano certo all’industria occidentale, quella automobilistica tedesca in primo luogo, che in quelle regioni aveva delocalizzato non piccola parte delle sue produzioni. L’Europa non era certo scesa indignata in campo quando nel 2018 il parlamento di Budapest aveva varato una legge sugli straordinari che le opposizioni ungheresi avevano definito «schiavista». E ancora durante la cosiddetta «crisi dei migranti» il governo bavarese stravedeva per Orbàn.
Nemmeno le leggi omofobe e la guerra contro il genere e la libertà delle donne condotta senza quartiere in Ungheria e in Polonia (che ha avviato fra l’altro la procedura di uscita dalla Convenzione internazionale del 2012 contro la violenza domestica e sulle donne) sembrava aver indotto l’Unione europea a dar decisamente battaglia. Lo stato di diritto è diventato in fondo abbastanza minimalista da lasciar correre non poche restrizioni delle libertà individuali e collettive. Senza contare che non tutti, Italia compresa, hanno le carte in regola (Genova 2001 ed ergastolo ostativo).
Queste interessate illusioni, fondate su una omogeneità che sarebbe stata garantita dal potere dei capitali, non facevano i conti con il nazionalismo da sempre latente e infine montante nei paesi del dissolto blocco orientale. Né con il fatto che del loro passato socialista, oltre ad una tendenza sotterranea vero il partito unico, avevano conservato sotto forma di circoli oligarchici l’«istituzione» della nomenklatura e il suo potere di corruzione. Ampiamente esercitato nell’accaparramento dei fondi europei e nella loro redistribuzione clientelare. Peraltro tenuta molto meno sotto osservazione di quella imputata alle mafie mediterranee.
L’architettura dell’Unione rimasta colpevolmente in ostaggio delle sovranità nazionali non dispone così di alcuno strumento per potersi difendere dal ricatto e dal sabotaggio di governi che intendano trasformare in senso autoritario i rispettivi sistemi politici continuando ad avvalersi delle risorse erogate dall’Europa. Fino a quando l’approvazione del bilancio europeo o di misure eccezionali come il Recovery Fund continueranno a richiedere un voto unanime il problema resterà sostanzialmente insolubile. Ed ogni condanna o appello ai «valori fondativi» dell’Unione europea, lettera morta. I trattati si rivelano così più che garanzia di regole generali e condivise, scudo dell’arbitrio politico sovranista e possibile strumento di sabotaggio e di paralisi dell’Unione. Che debbano essere modificati, se non del tutto superati nella loro natura di accordo tra governi, è sempre più evidente. Ma non è un processo compatibile con i tempi drammaticamente stretti dell’emergenza pandemica.
Non mancano tuttavia, sebbene ancora una volta sul piano degli accordi intergovernativi, possibilità di aggirare il veto di Budapest e Varsavia, stanziando fondi comuni che non passino attraverso il bilancio dell’Unione, ed escludano così Ungheria e Polonia da ogni beneficio. Non sono poche le voci che cominciano a invocare una simile soluzione di ripiego. Quel che resta incerto è se questo scontro contribuirà a rafforzare il nazionalismo ungherese e polacco o sospingerà l’opinione pubblica di quei paesi a prendere radicalmente le distanze dalla pericolosa avventura intrapresa dai partiti che li governano. Fino ad oggi è stato permesso ai governi «illiberali» dell’est di salvare capra e cavoli (involuzione autoritaria e comoda collocazione europea) facilitando loro così il mantenimento del consenso, ma si tratta di un equilibrismo sempre più difficile da mantenere. E che il contesto esasperato della pandemia rende ormai pressoché intollerabile.
Questo articolo è stato pubblicato su il manifesto il 18 novembre 2020.