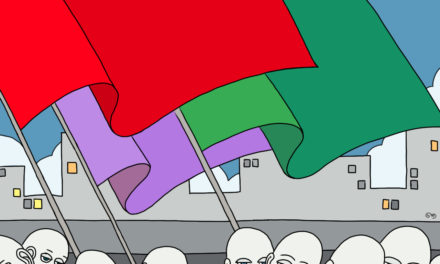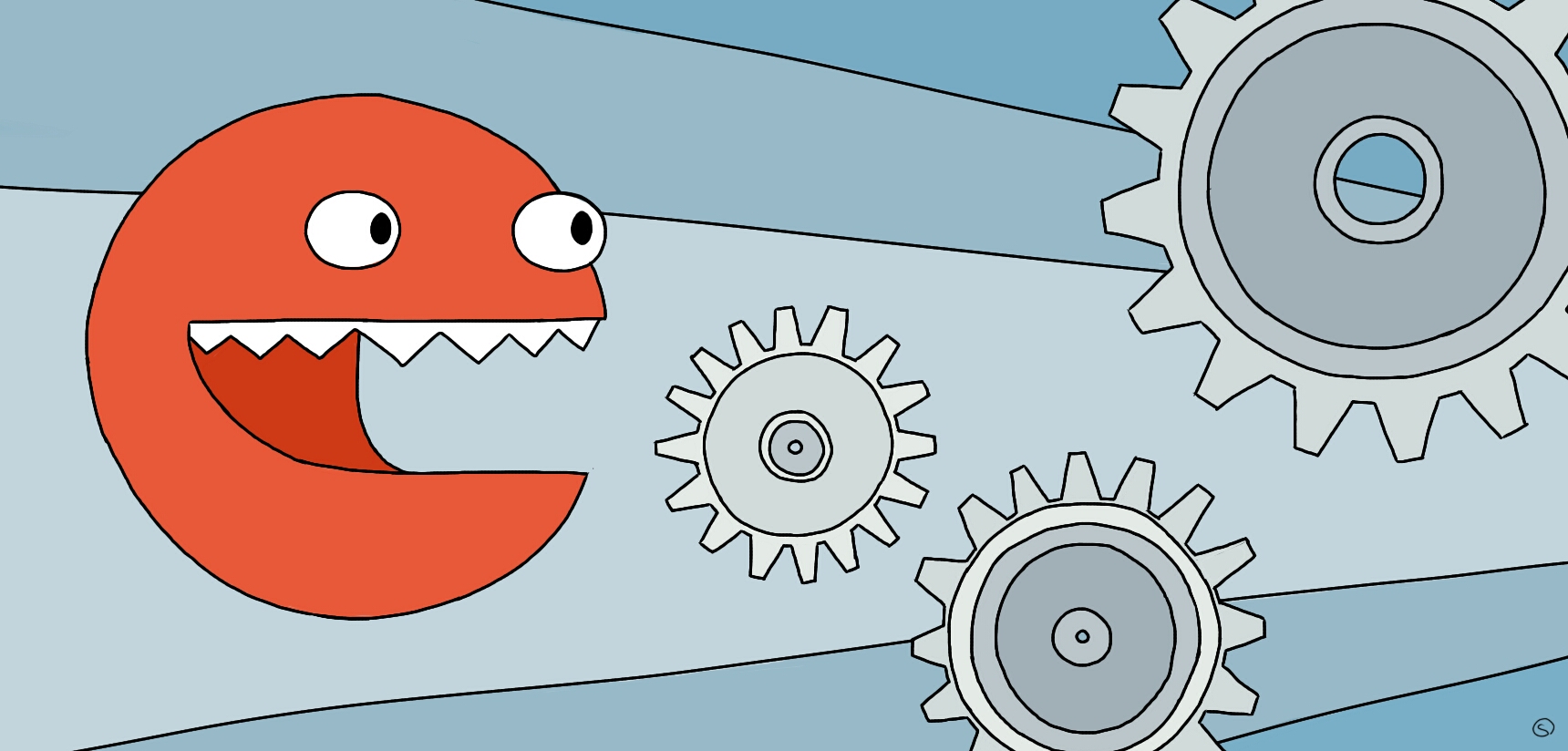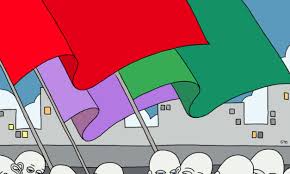di BENEDETTO VECCHI.
Capitalismo delle piattaforme è una espressione generica per qualificare una realtà dai confini incerti. Da una parte è applicata per cogliere le specificità di modelli produttivi dentro la Rete, sia che si parli di Amazon che di Netflix, Google, Facebook, Istagram, Twitter. Allo stesso tempo è stata usate per segnalare le ambiguità insite nella sharing economy, cioè a quell’insieme di servizi di intermediazione tra offerta e domanda di alcuni beni e servizi come Uber, Airbnb e i tanti altri siti per acquistare biglietti aerei, affittare case, macchine. Se l’economia della condivisione veniva annunciata come un possibile approdo postcapitalista nella produzione della ricchezza post-capitalista, attraverso la diffusione virale di esperienze autogestite, mutualistiche, il platform capitalism segnala che tale possibilità è una variante di una tecnoutopia da archiviare rapidamente, un sogno cioè di inveterati libertari colpiti da una sindrome di Peter pan che impedisce a loro di crescere. E’ questo, infatti, il mantra ripetuto da cultori dell’innovazione capitalistica come l’ex consulente economico di Hillary Clinton Alec Ross che nel saggio Il nostro futuro (Feltrinelli) tesse l’elogio delle criptomonete o di imprese come Google per la loro capacità di “mettere a valore” la cooperazione sociale, elargendo sprezzanti giudizi su quanti vedono nello sviluppo “partecipato” di piattaforme digitali una concreta possibilità di sfuggire a un futuro certo di lavori sottopagati e esposti al ricatto della precarietà. Due punti di vista speculari, giustapposti solo nel prospettare la possibile coesistenza di un settore economico non mercantile e uno vincolato, e per questo egemone, al regime del lavoro salariato. Il mutualismo, l’autogestione rimangono la prospettiva imprescindibile di ogni opzione organizzativa del lavoro vivo, ma non esauriscono la trasformazione dei rapporti di forza nella società. Ciò che emerge dalla grande crisi del 2008 è la copresenza di una economia informale e un regime di accumulazione dove le piattaforme digitali svolgono un ruolo centrale nello sviluppo capitalistico. E’ questa copresenza, dove il primo elemento, è sottoposto continuamente ai processi di cattura e di innovazione sociale del capitalismo della piattaforme che va interrotta, sottoposta a critica. Non farlo, determinerebbe la crescita del rischio di una paralisi di una prassi teorica, quindi politica, del pensiero critico. Si pone dunque di capire in cosa si caratterizza il capitalismo delle piattaforme. Irrinunciabile e preliminare è una analisi, riflessione sul lavoro vivo.
Un mondo di lavoretti
Importanti quotidiani e magazine – dal Guardian al Financial Times, dall’Economist al Foreign affairs – dedicano da tempo ampio spazio alla cosiddetta Gig-economy. Lo fanno per evidenziare la fortune di imprese come Uber, ma anche per sottolineare l’ascesa di un neotaylorismo digitale, individuando nelle mobilitazioni dei bikers che consegnano pasti, pizze a Londra (Deliveroo) o a Torino (Foodora), nonché le prime proteste dei tassisti di Uber come una risposta a un regime del lavoro dove la gestione automatizzata della prestazione lavorativa – tempi di consegna, tassonomia rigida dei comportamenti leciti durante il lavoro – sembrano far tornare in auge l’antica e per molti decaduta organizzazione scientifica del lavoro, con la sua rigida separazione tra progettazione e esecuzione. Soltanto che in questo caso tempi e ritmi del lavoro sono definiti da un’immateriale algoritmo o da una app contro i quali è vana ogni ogni forma di resistenza e conflitto.
Le cronache delle mobilitazioni londinesi segnalano invece che l’attitudine hacker tesa alla riappropriazione del sapere tecnico-scientifico può condurre a forma di aggregazione inedite. Usare la app per ordinare una pizza e discutere con il biker di turno sulle sue condizioni di lavoro, sul salario che percepisce e di come fare affinché alcuni diritti sociali siano conquistati può far sorridere, ma nel capitalismo delle piattaforme il conflitto va agito with any mean necessary. Il tema di come organizzare questa pulviscolo di uomini e donne è centrale. Per il momento emerge emerge una mappa dei componenti di questa “folla-lavoro” all’interno di una produzione di merci diffusa la cui descrizione ricorda spesso i romanzi di Victor Hugo o la desolante moltitudine di poveri che scandiva il romanzo sociale di fine Ottocento. Povertà, assenza di diritti, invisibilità politica: elementi che stridono con la ricchezza – di relazioni sociali, di innovazione – espressa della cooperazione sociale. Non c’è infatti nessun ritorno al passato: le attuali trasformazioni del modo di produzione non possono essere letta come la lenta formazione della classe operaia nell’Inghilterra vittoriana. Siamo in presenza di una composizione proteiforme del lavoro vivo, dove accanto a figure dequalificate convivono i professional dell’innovazione, tutte comunque accomunate da una dimensione metropolitana anche se, come attesta, ad esempio un capitolo del saggio di Ned Rossiter dedicato all’industria dello smaltimento e del riciclo dei componenti elettronici, possono essere situate ai margini dei flussi metropolitani (Software, infrastructure, labor: a media theory of logistical nightmare, Routledge) . La pubblicistica corrente evoca spesso la comparsa dei millenials , i nativi digitali acculturati e cresciuti dentro la Rete, ma anche di migranti con una elevata scolarizzazione. Al di là della formazione in loro possesso, la dimensione metropolitana del lavoro vivo allude a processi di socializzazione niente affatto “poveri”. Semmai sono evidenti la propensione all’innovazione, a un rapporto disincanta con l’etica del lavoro e della professione che vengono proposte come le forche caudine da oltrepassare per accedere al regno dell’individuo proprietario o per fare proprie le retoriche del capitale intellettuale da spendere sul mercato del lavoro. La cooperazione sociale produttiva è infedele, esercita il diritto alla fuga dal regime del lavoro salariato, anche se le forme di produzione della soggettività definiscono un campo di esperienze lavorative questo si povero, dove la produzione di plusavalore assoluto e plusvalore relativo sono dispositivi messi in opera contemporaneamente. Da qui il paradosso di un cooperazione sociale produttiva ricca e rapporti sociali di produzione che echeggiano rapporti servili e di assoggettamento rigidi, all’interno delle quali le piattaforme digitali sono anche elementi preposti alla produzione di soggettività docili.
Sul lavoro vivo nel capitalismo delle piattaforme molto c’è quindi molto da indagare. Alcuni elementi di base sono tuttavia chiari. Quando si parla di platform capitalism ci si riferisce spesso a lavoratori “indipendenti” che percepiscono un salario da working poor. Nella descrizioni delle loro prestazioni lavorative torna ossessivamente il tema che i ritmi lavorativi sono dati dagli algoritmi. Il comando è cioè impersonale, astratto. E’ questa impersonalità del comando che conduce alcuni studiosi che parlano proprio di neotaylorismo, invitando a consegnare agli archivi delle visioni sbagliate le tesi sulla relativa autonomia della cooperazione sociale produttiva che caratterizzava il postfordismo. A questo proposito è interessante l’analisi svolta da Nick Srnicek e Alex Williams nel in Inventing the Future. Postcapitalism and a World Without Work (Verso), dove questa inedita riedizione del taylorismo viene considerata componente di una lunga transizione a un mondo dove il lavoro è un residuo destinato ad esaurirsi nella produzione della ricchezza a causa di intensi processi di automazione tanto del lavoro manuale che di quello cognitivo. Il taylorismo digitale, viene argomentato, sarebbe dunque propedeutico nella transizione avviata da una “rivoluzione delle nuove macchine” che provocherà la fine del lavoro. Anche i bikers o i magazzinieri di Amazon, così come gli addetti alle consegne delle merci acquistate on line sono destinati a lasciare il posto a un sistema integrato di minirobot, droni e automobili senza autisti. Agli umani il compito di cedere “spontaneamente” i propri dati personali alle piattaforme digitali che li metteranno a valore attraverso un sofisticato sistema di software sviluppato a partire dalle ricerche sulla intelligenza artificiale e la neuroplasticità del cervello.
In questa distopia è recentemente entrata in campo la provocatoria proposta di una restituzione della ricchezza espropriata attraverso un sistema di tassazione finalizzato all’erogazione di sussidi di disoccupazione o di redditi minimi per sopravvivere in questo claustrofobico regno della necessità. Jaron Lanier, funambolico guru della realtà virtuale e imprenditore di successo, sostiene da tempo che imprese come Google, Amazon. Apple devono restituire una parte dei profitti per scongiurare il crollo del capitalismo e il montante populismo fatto proprio da operai e white collars messi fuori dal mercato del lavoro (La dignità ai tempi di Internet, Il Saggiatore). Insomma, una riduzione del danno che lascia inalterato il regime di accumulazione.
Altrettanto significativo è l’uso che i media mainstream fanno del neotaylorismo digitale, come emerge da un lungo reportage sul Financial Times dedicato ai conflitti londinesi dei bikers di Deliveroo1. In un susseguirsi di interviste volanti e annotazioni sul ritorno del lavoro servile, dove il comando è comunicato attraverso post e messaggi allo smartphone, il giornalista evoca gli algoritmi che presiedono il sofisticato software che gestisce la piattaforma digitale.
Gli algoritmi del postumano
Gli algoritmi sono una successioni di operazioni che vengono svolte, oppure non, in base al rispetto di alcune condizioni. Il termine algoritmo, nel caso del capitalismo delle piattaforme, ha pochi echi con la sua definizione storica, che risale ai tempi della Persia. La successione di operazioni elementari per risolvere un problema, il diagramma di flusso di semplici operazioni matematiche deve fare i conti con una macchina preposta alla soluzione in base alla definizione dei passi obbligati per risolvere un problema. Una delle regole di base è l’assenza di ambiguità. Per quanto riguarda la raccolta e l’elaborazione di dati questo significa la rimozione degli aspetti aleatori della comunicazione umana, suscettibili di fraintendimenti e di una costante opera di interpretazione. In un algoritmo ciò non è pensabile: dunque va rimosso qualsiasi elemento che possa rallentare l’elaborazione che è l’azione indispensabile per raggiungere l’obiettivo prefissato. Gli elementi imponderabili, l’inatteso che tanto appassiona la filosofia politica dell’indicibile, sono delegati alla cooperazione produttiva e sociale. Come è facile intuire la definizione dell’obiettivo è definito unilateralmente dalle imprese. Questo è tanto più rilevante quando si parla del potere dell’algoritmo di definire il ritmo del lavoro e della prestazione all’interno di una continua ridefinizione delle gerarchie e del salario. Il tema tanto discusso della Gig-economy, cioè di quella forma produttiva che vede come elemento centrale un esercito di lavoratori dequalificati, sottopagati, talvolta premiati ma spesso penalizzati dalle routine previste dall’algoritmo rende facile considerare gli algoritmi anche essi capitale fisso.
E’ quindi scontato che nel linguaggio informatico ad algoritmo viene preferita l’espressione flow-chart ad algoritmi. Il flusso al quale viene fatto riferimento sono informazioni, confronti, condizioni che possono determinare una procedura invece che un’altra. L’input viene dato ovviamente dalla piattaforma digitale, ma il feed back è prerogativa del lavoratore. Non c’è dunque l’one best way da seguire, ma solo tempi contratti di esecuzione, che vengono delegati nella loto organizzazione e gestione al singolo biker.
Già questo sconsiglia di usare il termine taylorismo, dato che nell’organizzazione scientifica del lavoro il decalogo delle mansioni e dei movimenti da compiere nel lavoro era stabilito precisamente. Anche nel capitalismo delle piattaforme di Foodora e di Deliveroo, l’esecuzione del lavoro è delegata interamente alla cooperazione produttiva. Dunque, la gestione di imprevisti, colli di bottiglia, sono parte integrante della prestazione lavorativa, mentre i tempi di esecuzione registrati sono usati per stabilire un sistema meritocratico e di calcolo del salario erogato. La Gig economy, più che far tornare in vita il taylorismo, da una forma compiuta al lavoro servile, dove le relazioni vis-à-vis sono circoscritte al rapporto tra il singolo e le piattaforme digitali.
Sarebbe però insensato limitare l’analisi del lavoro vivo alla crowd work (folla-lavoro) dei bikers di Deliveroo o dei tassisti di Uber. Nel capitalismo delle piattaforma entrano infatti in campo gli sviluppatori del software, i gestori della rete informativa, gli analisti di dati. Sono figure lavorative che determinano il buon funzionamento della piattaforma digitale e la raccolta di dati, quest’ultimo elemento fondamentale per costruire le mappe metropolitane indispensabili per ottimizzare la performance di impresa. Parlare di capitalismo delle piattaforme significa dunque immaginare i bacini di forza-lavoro che vengono progettati e governati dall’impresa. In questo casi gli algoritmi, anche se è più opportuno parlare di flusso del codice informatico, vanno considerati come capitale fisso al pari del silicio, i cavi, l’hardware delle piattaforme digitali. Questo significa un’articolazione della distinzione tra capitale fisso e capitale variabile, perché evidenziano il progressivo superamento della dicotomia tra materiale e immateriale che tanto ha fatto discutere negli ultimi decenni.
Gli spettri dell’immateriale
L’immateriale software è quindi anch’esso capitale fisso, cioè lavoro vivo oggettivato. Da qui la riconfigurazione del rapporto tra uomo e macchina, che non va visto come una relazione duale, bensì come l’emergere di una realtà postumana, dove l’animale umano non è più distinto dalla macchina. Se non fosse troppo irriverente, anche la mente umana talvolta è capitale fisso nella produzione della ricchezza. A mo di digressione, va segnalato anche il ruolo svolto dalla proprietà intellettuale.
In passato c’erano leggi e norme statali che l’assegnavano alle imprese e non certo all’autore di un programma informatico o di un brevetto. Poi è subentrato il fatto che ad essere sottoposti alla proprietà intellettuale fossero principi attivi delle piante, il genoma umano. E la critica del software libero ha fatto breccia anche nei movimenti sociali nel Sud del mondo (uso questa espressione per semplificare) e il discorso della condivisione e della libera circolazione del sapere e della conoscenza è diventato un discorso propriamente politico. La risposta è stato l’open source. Nel capitalismo delle piattaforme, assistiamo a un regime misto tra proprietà intellettuale e software open. Emblematico è il fatto che gran parte del software sia sia open source che proprietario. Oppure che il software sia open e i brevetti sugli algoritmi siamo proprietari. Questo consente alle imprese l’accesso a innovazioni prodotte al di fuori dalle imprese. Il carattere estrattivo del capitalismo ha qui una semplificazione, perché l’appropriazione non riguarda materie prima e terra, bensì sapere e conoscenza.
Per quanto riguarda il lavoro vivo nel platform capitalism, la proprietà intellettuale ha indossato le vesti del segreto industriale. La progettazione organizzativa, i flussi di informazioni, l’architettura della rete informativa che presiedono le piattaforme digitali sono un know how che deve rimanere segreto e i lavoratori coinvolti non possono divulgarlo, pena sanzioni amministrative o denunce penali. Questo serve a vincolare i lavoratori qualificati – i professional – all’impresa, dissuadendo loro dalla infedeltà e mobilità. Anche in questo caso, la proprietà intellettuale è piegata alla governance dei bacini della forza-lavoro. L’uscita dalla società salariale (espressione usata da Robert Castel) coincide infatti con la proliferazione di diverse tipologie contrattuali. Puoi essere freelancer, a tempo determinato, indeterminato, puoi essere intermittente con i voucher senza soluzione di continuità. Questo significa anche che puoi essere inserito in segmenti del processo lavorativo tayloristici, come anche basati sulla logica del team e della riconfigurazione delle mansioni che prevedono gerarchie flessibili ove il controllo è dato dalle tante, infinite riunioni per aumentare la produttività (questo è evidente per il lavoro cognitivo); oppure puoi fare esperienza di lavoro servile automatizzato come i bikers di Deliveroo. Significative a questo proposito sono le esperienze di Amazon, Google, Foxconn, cioè di imprese che operano su scala globale, che tuttavia fanno leva su una cloud computing alimentata da piccole imprese di software, start up o da una flessibile “folla lavoro” tesa a produrre valore delle piattaforme, come testimonia la sofisticata fucina di Mechanical Turk in Amazon.
Il potere della gratuità
Un punto di vista forte, critico sulle piattaforme digitali sarebbe claudicante se non affrontasse il tema del gioco, meglio della dimensione ludica della partecipazione ai social network e alla guerriglia mediatica contro gli algoritmi di Facebook.
Certo, appropriarsi degli algoritmi vuol dire conoscerli e saperli usare, forzarli, metterli in crisi al fine di bloccare il flusso ordinato delle informazioni e dei contenuti veicolati dalle piattaforme digitali. Ma sono sempre tattiche e momenti di conflitto circoscritti, che hanno bisogno di discrezione per essere efficaci. Sono parte, ma non esauriscono la soluzione di come avviare processi di conflitto e di autorganizzazione. Il gioco è inoltre parte integrante dell’etica hacker che si è affiancata, senza dunque sostituirla interamente, a quella protestante nel garantire stabilità al capitalismo delle piattaforme. Sarebbe altresì interessante capire come il gioco, la gratuità entrano in relazione con la renaissance del confucianesimo in Cina o l’induismo in India. Gli stratosferici investimenti nella ricerca e sviluppo decisi da Pechino sono certo finalizzati al passaggio dal made in China al Design in China, ma altrettanto pressante è stato l’impegno del governo cinese nel promuovere i centri culturali su Confucio, all’interno della retorica della Società dell’armonia, dove l’etica hacker è piegata a una politica di potenza e dove l’attitudine ludica del lavoro lascia il posto al lavoro come mezzo per elevare lo spirito e per far crescere il conto in banca. Sta di fatto che l’etica del lavoro che emerge dal capitalismo delle piattaforme è si carica di jouissance, ma vincolata alla produzione di plusvalore relativo. E’ un doppio movimento tra oltrepassamento dei limiti posti dal regime di accumulazione e produzione normativa di un nuovo campo dove collocare i comportamenti collettivi e individuali operanti nel patto luciferino esistente nel capitalismo delle piattaforme tra gratuità delle app, cioè dell’accesso ai social network in cambio della cessione dei propri dati personali che fanno accrescere i Big data.
Da una parte, quindi, materia prima del capitalismo delle piattaforme sono anche dati, informazioni, contenuti prodotti nella comunicazione on line. E’ noto che i Big Data vengono assemblati, elaborati, spacchettati per campagne pubblicitarie personalizzate, ma anche per essere venduti a chi è interessato ad usarli per altri business. E’ questo l’altro versante dove la distinzione tra materiale e immateriale, tra virtuale e reale perde la sua capacità di indicare polarità nel modo di produzione. C’è immateriale, perché il materiale è indispensabile. L’energia, i server, i computer, la localizzazione dei data server definisce un rapporto dinamico tra imprese e potere politico. Possiamo dire, senza cadere in una indebita sovrapposizione, che avviene le stesse dinamiche attinenti gli spazi infrastrutturali e la scalarità interstatale che caratterizza la logistica nel rapporto con gli stati nazionali.
Prendiamo l’energia. Per gestire i Big Data ne serve molta: i computer devono operare a una certa temperatura e devono essere protetti. Da qui la necessità di collegamenti sicuri alle reti elettriche e l’uso congiunto di polizia “ufficiale” e vigilantes. In questo caso il tema della militarizzazione del territorio torna ad essere rilevante. Interessante è a questo proposito l’autonomia energetica perseguita da Google, attraverso l’uso del solare e del fotovoltaico. La società di Mountain View ha collocato i suoi data center statunitensi vicino a dighe gestiti da privati o ha acquistato lotti estesi di terreno per installarvi pannelli fotovoltaici. La retorica green di Sergej Brin e Larry Page ha fondamenti molti pragmatici, perché Google non vuol dipendere dagli Stati nazionali per avere energia elettrica. E anche per contenere i costi derivanti dalla quantità di energia necessaria e per le oscillazioni del petrolio, carbone e biocarburanti.
Attorno alla sicurezza, invece, il discorso è altresì articolato. A guardia dei data center ci sono vigilantes, polizia, anche se le procedure per il controllo del territorio sono spesso quelle definite dalle imprese. La polizia è un guardiano che risponde all’impresa. Un altro caso di frammentazione della sovranità.
Come è stato evidenziato nel saggio Confine come metodo di Sandro Mezzadra e Brett Neilson l’implosione della sovranità ha nei confini il suo contesto “naturale. Ma allo stesso tempo c’è un confine poco esplorato, anche se citato nel saggio sopracitato: è quello che presidia la separazione da economia informale e economia formale, e che è da considerare il contesto dove vengono definiti processi di soggettivazione, di sfruttamento e di governance del lavoro vivo nell’economia della Rete. Il capitalismo delle piattaforme è quindi il lato presentabile in società del capitalismo predatorio, di quella sempiterna accumulazione originaria che caratterizza il mondo contemporaneo.
In altri termini, parlare di capitalismo delle piattaforme significa parlare del capitalismo en general. Ognuna delle caratteristiche che emergono andrebbero messe in relazione con modelli organizzativi, mission diversificate, varianti nel rapporto con la dimensione statale, come acutamente sottolinea Giorgio Grappi nel saggio sulla Logistica (Ediesse). Facebook è infatti cosa diversa da Google, ma ha molto in comune con Twitter, così come Netflix ha poco a vedere con Istagram ma può essere equiparato a Amazon. Ma ognuna di queste imprese globali è cosa diversa dai produttori di software per gestire la logistica su scala mondiale. Gli elementi unificanti ce ne sono ed emergono solo se si parte dall’analisi del lavoro vivo, dai suoi conflitti, dai suoi processi di autovalorizzazione.