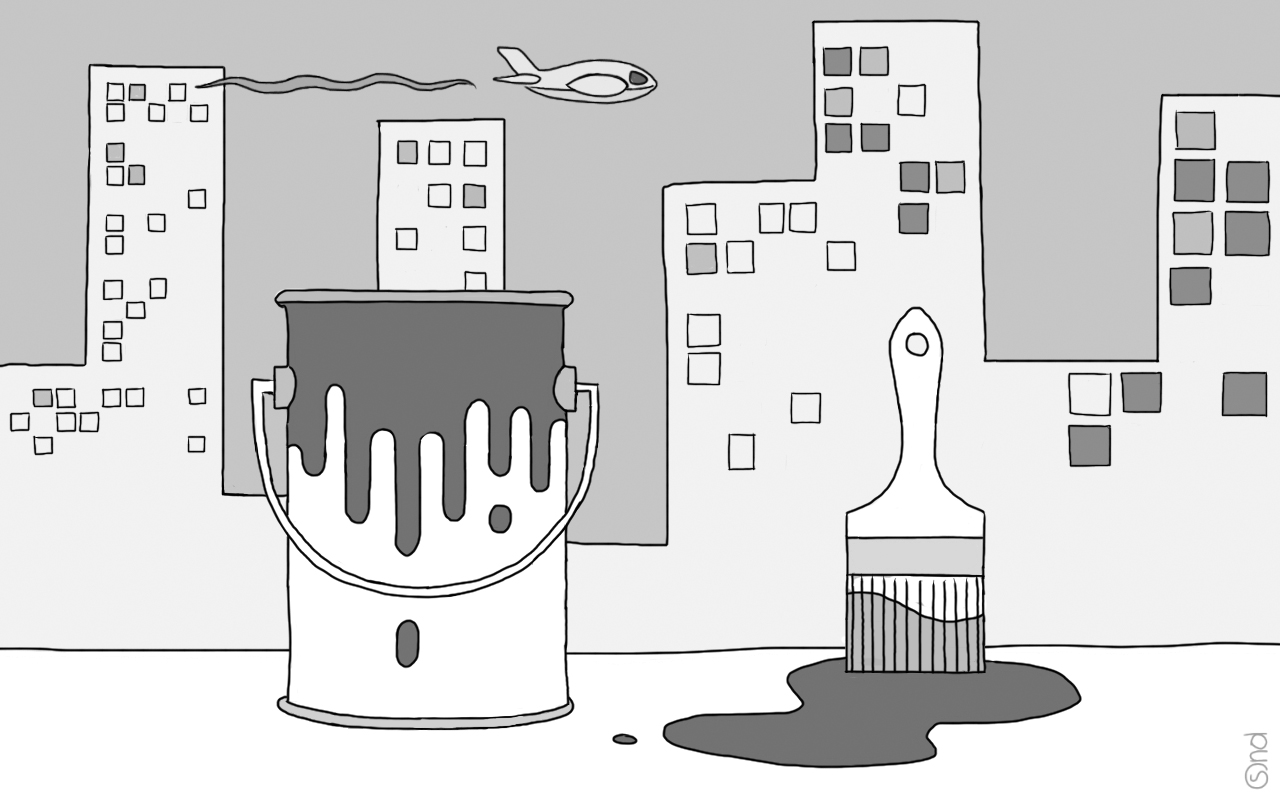Di DARIO FIORENTINO e XENIA CHIARAMONTE.
Che senso ha a quarant’anni da quel processo scrivere un libro ancora sul 7 aprile?
Noi abbiamo creduto che, benché la letteratura sul tema non manchi, sulla questione resti qualcosa di originale da dire. Prova ne sia il fatto che a distanza di quattro decenni non ci sia una lettura critica ma al contempo distaccata rispetto alle questioni più schiettamente politiche in gioco.
Con ciò non intendiamo affatto negare che queste fossero cruciali e che a tutt’oggi siano inevase, ma si tratta di un’analisi che lasciamo ad altri studiosi e altri tempi.
La nostra intenzione è quella di offrire uno sguardo sulle tecniche punitive del processo politico e, con questo fine, esplorare un laboratorio che crediamo di veder nascere paradigmaticamente col “caso 7 aprile”. Data l’età di chi scrive, la facoltà di distanziarsi da quei fatti è resa possibile, come forse possibile non è per i protagonisti del “caso”.
Per questo motivo ci siamo creduti in grado di affrontare una vicenda tanto decisiva quanto ancora “calda” della politica e, in particolare, della politica giudiziaria italiana. La nostra intenzione, allora, è quella di sostare sulla capacità del diritto di funzionare come tecnica “immunizzante” rispetto al conflitto sociale e non è, dunque, quella di rimpolpare la bibliografia apologetica sul “caso 7 aprile”, che sia partigiana per un verso o per un altro.
D’altronde recente letteratura in questo senso non manca: un caso esemplare è quello de Il terrorismo di destra e di sinistra (2018) la cui proposta è quella di porre “storici e magistrati a confronto” – alcuni fra i quali furono i principali protagonisti del “caso”. L’introduzione del libro è utile a connettere ieri e oggi, poiché ci avverte sin da subito che la minaccia anarchica nel passato così come nel presente è centrale nella considerazione che si deve avere del fenomeno terroristico. Il testo prende avvio e si fa sostenere dalle considerazioni di Theodore Roosevelt – Presidente degli Stati Uniti per il primo decennio del ‘900 – secondo cui la lotta al terrorismo e, in particolare, la distruzione della minaccia anarchica non hanno paragoni con nessun altro tipo di questione sociale per priorità[1].
Quello che a cavallo fra i due secoli e poi all’inizio del secolo scorso costituiva un pericolo centrale dei sovrani, pare aver lasciato una scia che giunge fino a noi: nel 2014, a Torino, in occasione della cerimonia di apertura dell’anno giudiziario, l’allora procuratore generale annuncia la stessa assoluta priorità da anteporre a ogni altra questione di politica del diritto penale, dicendo che:
“esiste un’area marginale ma non trascurabile di soggetti anarchici che, operando su un doppio livello, palese e occulto, costituiscono una minaccia per le regole costituzionali del paese puntando, attraverso atti di terrorismo, all’eversione del sistema democratico” (www.torino.repubblica.it, 25 gennaio 2014).
La discrasia fra fatti di reato e loro sussunzione giuridica appare sempre evidente nei processi politici, costituendone di solito una ricorrenza. Il “caso 7 aprile” non solo conferma questa costante tensione fra la percezione che si ha di atti potenzialmente “sovversivi” e l’interpretazione omogeneizzante e amplificante offerta dai giudici, ma può essere considerato il “capostipite” della storia giudiziaria repubblicana.
L’importanza del processo “7 aprile” risiede nel fatto che quest’esperienza giudiziaria possa essere considerata come un laboratorio nel quale, da un lato vengono riattivate pratiche che hanno connotato alcuni modelli storici ben rodati nel campo della repressione penale politica e, dall’altro, costituisce il campo di sperimentazione di nuove e originali tecniche in combinazione con le prime.
Nel corso quasi decennale dell’inchiesta del 7 aprile, si cristallizzeranno alcuni tratti innovatori del processo penale politico in Italia, i quali saranno suscettibili a loro volta d’essere replicati e sistematizzati per far fronte ad altre situazioni di emergenza che hanno colpito la società italiana negli anni a venire: mafia, cospirazioni massoniche, corruzione politica «ambientale», movimenti ambientalisti.
Da un punto di vista storico-giuridico, la vicenda ci permette di confrontarci, da diverse angolazioni, con ciò che dal dibattito tra storici e specialisti del processo penale è stato definito come “l’inconscio inquisitorio” del sistema punitivo italiano[2].
Divenendo il paradigma per antonomasia della risposta giudiziaria alla vasta fenomenologia della violenza politica in tutte le sue declinazioni, lo studio delle procedure di questa straordinaria vicenda può rappresentare il vettore privilegiato per comprendere almeno due ordini di problemi. In primo luogo: come si costruisce la figura dell’imputato-nemico contestando la sola attività politica di tipo ideologico e, a seguire, le ragioni storiche e tecniche di un’apparente ripetizione strutturale delle pratiche giudiziarie che concretizzano tale risposta istituzionale nel trattamento del problema della sovversione politica. E ciò, a ben vedere, all’interno di un contesto formalmente democratico e costituzionale e facendo coesistere moduli punitivi la cui origine e ragion d’essere appartiene a coordinate spazio-temporali assai diverse. I due punti dell’analisi sono strettamente intrecciati e la comprensione del primo dipende inevitabilmente dall’articolazione del secondo.
Da un punto di vista storico, la questione del “processo politico” si presta a un doppio livello di studio e di comparazione, sincronico e diacronico, tra mondi lontani e differenti. E già una ricognizione che semplificasse, per modelli, la fenomenologia plurisecolare della giustizia politica, permetterebbe di cogliere lo sviluppo e il riprodursi, nel tempo, di sottili mescolanze e coesistenze di analogie, differenze, sovrapposizioni di strategie e pratiche punitive risalenti a diversi contesti storici.
Ma, soprattutto, da un punto di vista tecnico e operativo lo studio di un processo politico di tal fatta permette di cogliere come si riattivi e riadatti, al contempo e puntualmente, quel meta-codice che distingue l’amico dal nemico, e come il giudice, condividendo eventualmente le opzioni ideologiche dei partiti al potere (anche se indipendente) possa riassumere il ruolo di mediazione patriarcale esercitata nella penombra della positivizzazione giuridica e della razionalizzazione e secolarizzazione formale del ceto cui appartiene, tornando a svolgere una funzione sacerdotale oltre che politica[3].
Ecco allora che il processo penale nella sua “versione” politica, grazie all’enfasi posta sull’istruttoria o sul dibattimento – condotti unilateralmente – non dirime una controversia, ma la conduce e la governa presentandosi come una terapia del presente minacciato dalla sovversione, verso cui ha l’ambizione e la pretesa di una riparazione.
In altre parole, ciò che preme sottolineare è che l’immunizzazione giuridica[4] che segue all’uso distorto del mezzo processuale, intesa come ragione di stato, permette al sistema del diritto di darsi una continuità operativa, di non bloccarsi innanzi a norme, principi e decisioni in contrasto con tutte le operazioni che possano assicurare l’illusione dell’ordine e della sicurezza.E, l’invenzione del nemico, è storicamente una finzione che funziona finzionando, permettendo cioè alla giustizia politica e all’inquisizione penale di diventare uno strumento come un altro dell’arsenale delle democrazie che vogliono estirpare “l’assolutamente aspro” di hegeliana memoria[5] o domare la foucaultiana “esteriorità selvaggia[6]”.
Il processo politico, dunque, non è soltanto operazione meramente giudiziaria, dal momento che, domando la materia sociale “in eccesso”, riduce quest’ultima a formato discorsivo compatibile coi gangli della struttura politica ed economica che intende difendere. Anche se “verità” è invenzione di un mentitore, come diceva Heinz Von Foerster, grande studioso di cibernetica, ciò non è rilevante nella dimensione di realtà creata dal processo politico, perché, per dirla con Foucault,
“è sempre possibile dire il vero nello spazio di una esteriorità selvaggia; ma non si è nel vero se non ottemperando alla regola di una polizia discorsiva che si deve riattivare in ciascuno dei suoi discorsi. La disciplina è un principio di controllo della produzione del discorso; essa fissa dei limiti col gioco d’una identità che ha la forma di una permanente riattualizzazione della regola. […] In ogni società la produzione del discorso è insieme controllata, selezionata, organizzata e distribuita tramite un certo numero di procedure che hanno la funzione di scongiurare i poteri e i pericoli, di padroneggiarne l’evento aleatorio, di schivarne la pesante, terribile materialità[7].”
Il discorso e le pratiche vivono in costante dialogo. Entrambi possono funzionare bene e congiuntamente ai fini della giustizia politica. Oggi lo vediamo nelle forme della criminalizzazione di movimenti sociali, non più eminentemente politici quanto a base popolare. La giustizia politica assume con lo Stato-globale delle sembianze nuove.
Questo libro è il tentativo di connettere le pratiche giudiziarie di alcuni decenni fa e, in particolare, le tecniche punitive offerte dal paradigmatico 7 aprile con quelle odierne. La struttura del testo, allora, parte da un saggio su questo “paradigma”, prosegue con un dossier sul processo – in modo tale da offrire alla lettrice e al lettore l’insieme di “prove” necessarie a corroborare la ricostruzione critica – e infine si conclude con un saggio che offre le tracce possibili dell’attuale modello antisovversivo.
Questa introduzione è stata ripresa dal blog di “Studi sulla questione criminale” dove è stata pubblicata il 3 aprile 2019.
Foto di Francesca Gabriele.
—
Note
[1] Il riferimento è all’introduzione di Fiuman: Il problema dello Stato tra verità storica e verità giudiziaria, in C. Fumian e A. Ventrone (a cura di), Il terrorismo di destra e di sinistra in Italia e in Europa. Storici e magistrati a confronto,Padova University Press, 2018
[2] Si riprende l’espressione dal titolo di uno studio a cura di L. Garlati, intitolato L’inconscio inquisitorio. L’eredità del Codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana,Giuffrè, 2010
[3] F. Di Donato, La rinascita dello stato. Dal conflitto magistratura-politica alla civilizzazione istituzionale europea, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 71-72 e 478, C. Costantini, La legge e il tempio. Storia comparata della giustizia inglese, Roma. Carocci, 2007
[4] Ci si riferisce nello specifico all’utilizzazione inflazionata del mezzo processuale penale il quale è stato utilizzato, a partire dalla fine degli anni 70, con frequenza sempre crescente, fino a coinvolgere migliaia di imputati accusati sulla base di contestazioni dal contenuto meramente ideologico. Sulle problematiche “giuridiche” di un tale impiego del processo penale in funzione politica e sulla relazione con il concetto di immunizzazione, si rinvia a D. Fiorentino, Conflittualità sociale e funzione immunizzante del diritto: qualche nota per una lettura sistemica della repressione penale politica nelle società complesse, in X. Chiaramonte e A. Senaldi, Violenza politica. Una ridefinizione del concetto oltre la depoliticizzazione, Ledizioni, 2018
[5] F.G. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, 1965, p. 195
[6] M. Foucault, L’ordine del discorso, Einaudi, 1966, p. 28
[7] Ivi,pp.28 e 9