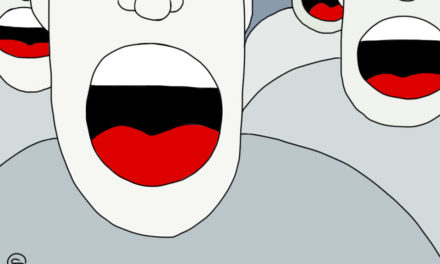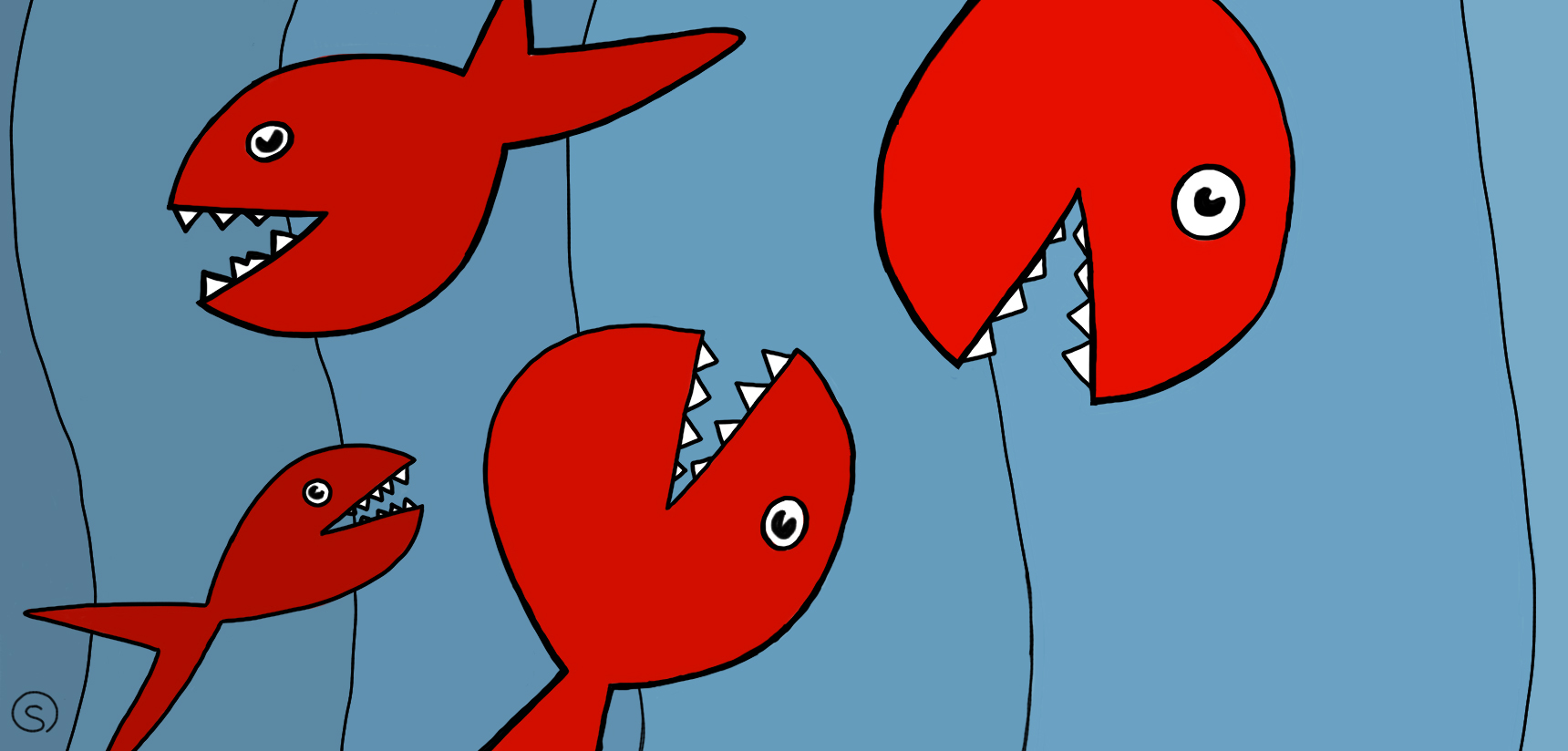di MAURILIO PIRONE. Alla fine è successo. Quella che poteva sembrare la trama di un episodio di Black Mirror è diventata invece l’elezione del 45esimo Presidente degli Stati Uniti. La domanda che da giorni tutti si pongono è come abbia fatto un evasore fiscale, corrotto, sessista, narcisista e xenofobo a vincere nonostante lo sfavore dei pronostici e del suo stesso partito.
Allo stesso tempo, si sprecano commenti e ipotesi sugli scenari che da qui si aprono per il futuro degli Usa e non solo. Difficile dirlo. Il temuto “cigno nero”, quell’evento inaspettato che stravolge i mercati, non è stato così catastrofico, tant’è che già dal giorno dopo le elezioni le Borse aprono senza affanni e le agenzie di rating confermano i loro giudizi sulla crescita americana. Diversa invece la reazione del mondo politico; per i democratici americani è stato un autentico shock, mentre in Europa al silenzio iniziale dei capi di governo si contrapponeva l’endorsement dei diversi leader delle destre populiste.
Non è semplice esprimere un giudizio non scontato sul valore e sugli effetti dell’elezione di Trump. D’altronde, perché dall’altra parte dell’Atlantico dovremmo esserne interessati? Su questo punto forse qualcosa possiamo dirlo perché probabilmente è questa una delle questioni più rilevanti. Non si tratta, solamente, di considerazioni di stampo geopolitico (come cambierà la politica americana, ad esempio, in Medio Oriente); le elezioni presidenziali degli Stati Uniti hanno piuttosto messo in luce uno spaccato della società americana che parla anche della nostra società, dei conflitti e delle pulsioni che la agitano.
Su una cosa concordano tanto i detrattori di Trump quanto i suoi sostenitori: fattore decisivo nella partita elettorale è stata la middle class bianca. Trump non ha ottenuto la maggioranza dei voti ma ha vinto perché ha saputo accaparrarsi non solo il sostegno di alcuni grandi elettori (il sistema elettorale americano si basa sugli Stati piuttosto che sul numero assoluto di preferenze) ma soprattutto quello della Rust Belt, la cintura della ruggine, epicentro dell’industria pesante – dove anche la working class aveva salari alti– e (un tempo) roccaforte dei Democratici. È qui che si concentra quella che Robert Reich ha definito in un post premonitore del 2015 la “classe ansiosa”, lo zoccolo duro su cui Trump ha costruito una minoranza organizzata che meglio ha sfruttato le regole del sistema elettorale americano. La classe ansiosa è quella classe media che ha visto la propria condizione di vita migliorare negli anni ‘70 e ‘80 e che ora ha paura di diventare povera; non solo, è quella che ha intravisto il benessere ma che ora lavora on-demand e si è indebitata.
Come ha evidenziato Valentina Fulginiti: “Trump ha prevalso tra le fasce dal reddito medio e alto, da cinquantamila dollari all’anno all’insù. Negli USA 50.000 dollari sono il salario annuale di un insegnante con anzianità di servizio o di un impiegato con un lavoro decente: non per forza dei nababbi, ma nemmeno parte della classe operaia. Per alcuni l’emergenza economica percepita non sta nell’effettiva povertà ma anche e soprattutto nell’ansia per un potere d’acquisto perduto, nella paura di scivolare più in basso e anche nella certezza di «aver perso il proprio legittimo posto in prima fila» – un posto che, non bisogna dimenticarlo, era garantito anche dal razzismo istituzionale e sistemico, dall’esclusione delle donne, dei marginali, del «diverso»”.
La classe ansiosa si sente preda di forze che non può controllare, siano esse le oscillazioni della Borsa o un attacco terroristico, e priva di protezione. Scriveva sempre Reich: “Government won’t protect their jobs from being outsourced to Asia or being taken by a worker here illegally. Government can’t even protect them from evil people with guns or bombs. Which is why the anxious class is arming itself, buying guns at a second rate”.
E questa classe ansiosa di uomini bianchi si è convinta che la propria condizione di precarietà sia dovuta a due fattori: la globalizzazione e l’immigrazione.
Nelle sue parole, l’establishment, l’élite politica e finanziaria che governa il paese (la stessa che Occupy Wall Street aveva definito l’1%) vive del loro lavoro, fa profitti sui loro sacrifici scaricando sulle tasse la bancarotta e usando la delocalizzazione delle attività produttive per pagare di meno il lavoro. La Clinton è stata identificata con questo potere opprimente che prende senza dare, che costringe senza garantire.
Se l’establishment quindi si muove sopra le loro teste e disperde il loro lavoro nella catena logistica globale, allo stesso tempo troverebbe il proprio consenso democratico in una massa di manovra – i migranti, i latinos, gli afroamericani – che invece è mantenuta dallo stato sociale pagato col loro lavoro. Il nemico dunque diventano le aziende americane che minacciano di spostarsi in Asia e i messicani che lavorano in nero, gli operai asiatici e gli afroamericani che pretendono una sanità pubblica per tutti. Poco importa se è stata proprio l’America a scegliere la delocalizzazione per imporre le proprie aziende a livello globale o se la crisi delle attuali politiche migratorie sia dovuta in parte ad anni di saccheggio liberista dei cosiddetti paesi in via di sviluppo.
Si può evidenziare la debolezza di un candidato come la Clinton, si può criticare – come stanno facendo i Democratici in questi giorni – il sistema elettorale americano che privilegia i collegi elettorali ai voti assoluti, ma non si può negare che Trump ha costruito la propria vittoria sulla capacità di coagulare il malessere di una parte della società americana – quella bianca, del ceto medio che teme o affronta l’impoverimento, patriarcale, rurale – in una lotta di classe da destra contro i migranti e i poveri.
Questa classe ansiosa che spera nell’uomo forte, l’outsider che possa proteggerli dal caos e che renda l’America (e gli americani) di nuovo grandi, non è forse la stessa che in Europa si sente impoverita da anni di austerità, che vede nell’UE solo una fonte di sacrifici e regolamenti, che pensa di doversi accaparrare le poche risorse rimaste prima che qualche migrante gliele sottragga? Non si tratta in entrambi i casi del prodotto delle trasformazioni del lavoro avvenute negli ultimi 20anni di liberismo sfrenato? Non sono forse il risultato dell’estensione della concorrenza dal mercato alla società, la sostituzione della lotta di classe con la lotta di tutti contro tutti? L’elezione di Trump, infatti, è stata letta da molti (a torto o a ragione, si vedrà col tempo) in continuità con il voto britannico sulla Brexit, come secondo atto di una rivolta della classe media che sente di aver perso i propri benefit e sceglie di votare contro più che a favore.
Il progetto liberale che ha governato la creazione di un grande mercato globale, il sogno logistico di un mondo fluido in cui merci e capitali potessero scorrere liberamente mentre un esercito di consumatori acquistano con un click, ha prodotto una crescita delle disuguaglianze, la distruzione di tutele sociali, uno scollamento profondo fra i rappresentanti e i rappresentati e oggi si scontra contro il risentimento delle classi medie e basse. Il nuovo disordine globale che le élite politiche ed economiche liberali contano di gestire in maniera flessibile all’interno del paradigma della crisi e dell’emergenza continua ha come corrispettivo l’ansia di sicurezza sociale di chi ha ancora qualcosa da perdere. Il “meno peggio” non è più una scelta garantita, il peggio sembra diventare più allettante se non altro per il desiderio di mandare a rotoli chi ha gestito finora il potere. Trump sembra dunque il cigno nero del liberismo, il cataclismo politico prodotto dalla pancia della stessa America che ha paura del declino e dell’impoverimento, imprenditore che incarna fino in fondo le conseguenze (sociali) delle politiche economiche che gli hanno permesso di essere quello che è, la speranza (illusoria) che solo un uomo forte e di successo possa sfidare alla pari i suoi simili che hanno consumato il sogno americano.
Cosa sarà l’America di Trump è presto per dirlo. Di sicuro non sarà un magnate newyorchese a mettere in crisi le fondamenta di un sistema capitalistico su cui si basa la sua stessa ricchezza. Né è possibile pensare una trasformazione autarchica di un paese che invece ha costruito il suo benessere sul ruolo predominante all’interno del mercato globale. Questa è solo propaganda elettorale che a fatto di Trump un significante vuoto da riempire con tutte le ansie e le paure dei bianchi americani della middle class. I rumors che trapelano sulla composizione della squadra di governo indicano però che la partita per il Ministero del Tesoro sia tutta interna a Wall Street. Così come pare che Trump sia intenzionato a mettere mano al Dodd Franck Act che limitava gli investimenti bancari in hedge funds. Gli altri punti su cui il suo team ha annunciato che lavorerà nei primi mesi sono la restrizione delle leggi sull’immigrazione, l’utilizzo dei combustibili fossili, la difesa del porto d’armi privato, il ritiro della riforma sanitaria di Obama.
Probabilmente l’elezione di un Presidente che ha fatto della retorica anti-immigrati uno dei suoi cavalli di battaglia acuirà le tensioni razziali che hanno caratterizzato la fine del mandato di Obama. Immaginiamoci cosa potrebbe dire Trump dopo fatti come quelli di Ferguson, lui che ha esaltato l’operato della polizia e che difende l’uso privato e indiscriminato delle armi. Il rischio è quello di una radicale razzializzazione del conflitto sociale. Ieri, nella prima intervista da neo-eletto Presidente, ha dichiarato che procederà all’espulsione di 2-3 milioni di migranti irregolari e alla costruzione del muro con il Messico.
Così come è probabile che l’onda lunga del cigno nero arrivi a investire anche i prossimi appuntamenti politici europei, ad esempio le presidenziali francesi. Non si tratta solo della terribile possibilità di avere una Marie Le Pen al governo, ma soprattutto quella di legittimare ulteriormente una lettura razzista e xenofoba delle disuguaglianze che ha, come contraltare, la chiusura di spazi progressisti di protesta e convergenza moltitudinaria delle diverse forme del lavoro contemporaneo.
Allo stesso tempo, l’esito del voto ha provocato lo scoppio di reiterate proteste in molte città americane al grido di “Not my President”. A partire dal 9, non c’è stato giorno senza cortei, manifestazioni e raduni contro l’elezione di Trump. Sembra dunque che invece di unire, come proclamato durante il suo discorso post-voto, Trump abbia spaccato l’America in due.