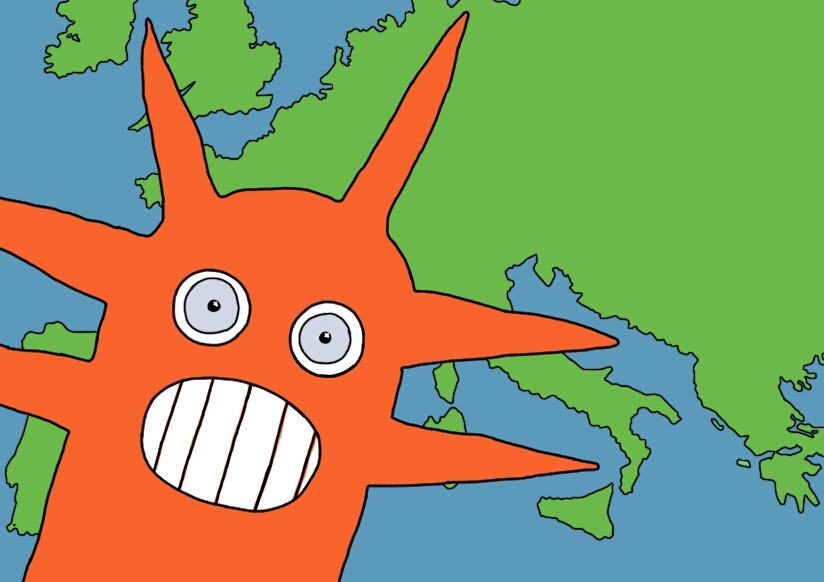di MARCO BASCETTA.
Nel più prossimo futuro dell’Unione europea, la questione delle autonomie, o delle indipendenze, sembra destinata a occupare una posizione centrale e decisamente complicata. Nel senso che non riguarderà più solamente il rapporto tra le regioni che rivendicano l’autonomia e lo stato nazionale da cui aspirano a separarsi, ma porrà problemi politici di carattere generale tali da investire l’assetto stesso dell’Unione. La quale, nei suoi trattati e nelle sue politiche, ha completamente eluso la questione, adottando implicitamente quella posizione che nel diritto internazionale è raccomandata come principio di «non ingerenza». Insomma, soprattutto dopo l’esito delle elezioni catalane e spagnole, le indipendenze non potranno più restare affare esclusivo dei catalani, dei baschi, degli scozzesi o dei corsi, ma lo diventano di tutti gli europei e dell’idea di democrazia che vorranno affermare.
Oligarchie regionali
Converrà, tuttavia, definire chiaramente una premessa. Chi non ama, come chi scrive, gli stati nazionali, non può certo vedere di buon occhio la loro moltiplicazione. Ciò che è accaduto dopo il 1989 non ha fatto che confermare questa decisa avversione. Dalla ex Jugoslavia allo sfaldamento dell’Unione sovietica abbiamo assistito al proliferare di piccole patrie a vocazione ultranazionalista, al dilagare di conflitti sanguinosi su base etnica o identitaria con frequente ricorso a quella che Hobsbawm e Range chiamarono «l’invenzione della tradizione». Gli interessi egemonici occidentali e quelli delle oligarchie regionali hanno in larga misura governato e manipolato questi processi sotto la bandiera, da sempre equivoca, dell’«autodeterminazione dei popoli». Un’espressione che ha sovente sovrapposto alla realtà sociale e culturale dei territori, alle aspirazioni delle classi subalterne, il tornaconto di un ceto dominante alla ricerca della maggiore espansione possibile della propria sfera di potere. Per fare un esempio d’attualità, Arturo Mas, già contestatissimo presidente della Catalogna, è una delle espressioni più evidenti di questa forma di usurpazione da parte delle oligarchie regionali. L’aspirazione all’indipendenza ha sempre cercato di occultare, di neutralizzare, il conflitto di classe che la attraversa annegandolo nella palude indistinta del nascente «interesse nazionale». È la ragione per cui è sempre saggio diffidarne. Seppure non si deve dimenticare che per i catalani o per i baschi la controparte è stata, per lunghi e dolorosi anni, il centralismo fascista della Spagna di Franco. Insomma, la rivendicazione di indipendenza non può essere mai valutata in termini astratti, ma deve sempre essere misurata con il suo contenuto reale di democrazia, con la qualità sociale che la sostanzia.
Se ai nostri confini orientali si è consumata una tragedia, e in Spagna si prepara una difficile partita politica, in Italia è stata messa in scena una farsa per babbei, quella dell’indipendenza dell’inesistente Padania. Falsa come gli spadoni e gli elmi cornuti, le cerimonie celtiche e la moneta padana di cui i leghisti straparlavano intorno al 2011 e che qualche amministratore locale si mise addirittura a stampare. Il razzismo no, quello era vero, e pronto a transitare armi e bagagli in una destra ultranazionalista che stravede per il Front National di Marine Le Pen e la sua demagogia antieuropeista. Come sempre gli esiti chiariscono le premesse, l’anatomia dell’uomo spiega quella della scimmia. E l’antieuropeismo della Lega rivela la virulenta vocazione nazionalista che ne attraversa tutta la storia accompagnandola infine dalle parti di Casa Pound.
Narrazioni identitarie
Il rapporto con l’Europa, questo è dunque il primo punto sul quale misurare la qualità politica delle autonomie. Gli indipendentisti catalani, baschi, galiziani, corsi o scozzesi non sono antieuropei. Semmai guardano all’Unione come a una chance. Il partito nazionale scozzese ha esplicitamente dichiarato che l’eventuale uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea, il cosiddetto Brexit, rappresenterebbe un motivo in più per separarsi non dall’Europa ma dal Regno Unito. Per molti il commiato dallo stato nazionale si accompagna dunque a un desiderio di piena integrazione nell’Unione europea. Ma anche su questo punto bisogna fare attenzione: il filoeuropeismo può avere un carattere del tutto strumentale. Il riconoscimento da parte di una Europa sostanzialmente fondata sugli stati nazionali e sulla salvaguardia delle loro prerogative può funzionare da puro e semplice principio di legittimazione di nuove sovranità nazionali tracotanti e pronte a puntare i piedi come l’Ungheria di Victor Orban. Un certificato in bianco di nuova sovranità.
È quello che è accaduto nelle cosiddette «democrazie postcomuniste». Da quelle parti l’affiliazione europea è servita a coprire le peggiori nefandezze nazionaliste, le più bieche narrazioni identitarie delle piccole e grandi patrie. Funzionando, inoltre, da freno permanente ai processi di integrazione politica nel vecchio continente. Il modo in cui questi governi hanno reagito alla crisi dell’immigrazione indica un secondo, decisivo criterio sulla base del quale valutare la qualità delle autonomie: l’apertura o la chiusura nei confronti dei migranti. Quanto, insomma, l’orrendo principio del «padroni a casa nostra» venga assunto come bandiera dell’indipendenza. Vi sono, a questo proposito, realtà territoriali assai migliori degli stati nazionali, come ve ne sono di ben peggiori.
Una scommessa rischiosa
Abbiamo un serio problema. Non possiamo respingere le istanze autonomiste in difesa dello stato nazionale e del suo monopolio sovrano, ma non possiamo appoggiare le indipendenze in quanto fondazione di nuove sovranità nazionali che riproducano su scala minore, e possibilmente ancor peggiore, lo stato da cui si sono separate. Dobbiamo guardare, dunque, alla natura del processo democratico che si sviluppa nei territori, ai suoi contenuti sociali alla capacità di innovazione politica e di apertura che esprime. La domanda è allora da che cosa ci si vuole rendere indipendenti e per fare che cosa.
La posizione assunta da Podemos, e che le ha assicurato uno straordinario successo elettorale (in coalizione con altre forze regionali) in Catalogna, nel Paese basco, in Galizia, si fa carico appunto di questo problema. Pur contrario alla frammentazione dell’unità della Spagna il partito di Iglesias intende rispettare l’autodeterminazione democratica delle regioni separatiste. Se non si tratta di puro tatticismo, si apre così un processo che, in virtù del suo programma sociale, potrebbe modificare in senso antinazionalista l’una e le altre. Scommessa rischiosa, dall’esito assai incerto, ma che ha comunque il merito di indicare una strada, di aprire uno spazio politico nuovo. Che per l’Europa significherebbe ripensare il rapporto con quanto è sempre meno rappresentato dagli stati nazionali che, malgrado le apparenze, la tengono in ostaggio in uno stabile compromesso con le oligarchie finanziarie: il rapporto con i movimenti sociali, le realtà territoriali, i cittadini europei insoddisfatti dei rispettivi governi, i soggetti e le forze produttive sospinti ai margini del patto sociale.
Il nodo da sciogliere
Insomma quell’«Altra Europa» costruita dal basso di cui si continua a sognare ad occhi neanche troppo aperti. La domanda che il nuovo scenario ci propone è se non sia necessario, a questo punto, demolire il feticcio dell’integrità, anche territoriale, degli stati nazionali per mettere effettivamente in movimento un processo d’integrazione europea di questa natura. E se le «indipendenze» conseguite in un simile contesto non possano riuscire a configurare realtà politiche diverse dagli stati nazionali e ad alta capacità di reciproca integrazione. Siamo, ovviamente, nel campo dell’azzardo e sul confine di terre sconosciute. Ma nel laboratorio spagnolo questa materia si accinge a diventare estremamente concreta.
All’indomani delle elezioni in Spagna Lanfranco Caminiti interveniva nel suo blog, «La camera dello scirocco», assumendo proprio questo orizzonte. Ricordava, in quel testo, quanto la questione delle autonomie fosse collegata a quella del welfare e della distribuzione delle risorse. È noto come l’indipendentismo venga generalmente accusato di rappresentare l’interesse egoistico delle aree più ricche e produttive, restie a farsi carico dei problemi di quelle più svantaggiate. Accusa irricevibile da parte di Stati nazionali patentemente incapaci di rimediare ai loro squilibri interni, quando non cinicamente dediti a servirsene, sordi alle potenzialità dei diversi territori e sempre orientati a soddisfare gli imperativi del mercato. E ancor più priva di fondamento se si guarda alla cittadinanza europea come a una realtà effettiva e sostanziale. Del resto le sovranità nazionali si sono dimostrate pessime mediatrici tra la governance europea e le realtà locali. Oscillando tra la parte dello sbirro di Bruxelles, con le sue assurde normative, e quella dell’ azienda nazionale, il cosiddetto «sistema paese», in competizione con i suoi simili a colpi di precarietà, bassi salari e tagli dello stato sociale. Cosicché non si può che convenire con Caminiti quando scrive che non è lo stato nazionale a non potersi più permettere i costi del welfare, ma il welfare a non sopportare più il peso dello stato nazionale.
Il discorso dell’indipendenza è un modo vecchio (e piuttosto screditato dall’esperienza storica) di porre il tema dell’autogoverno e della sua cornice politica, ma è pur sempre un modo di proporlo. Podemos sembra avere riconosciuto la necessità di disporsi ad affrontare questo nodo. Né Partito dell’ Indipendenza, né partito della Nazione. Ma cosa vi sia fuori da questa alternativa è ancora tutto da immaginare.