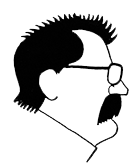Di MICHELE SPANÒ
…anche
nelle più vili macchine
concepite da tedeschi ubriachi
abitano leggi, s’ingenerano
ubbidienze, servilismi che arrivano
alla conoscenza pura,
al miracolo. Così un meccanismo
tende a durare per sempre,
s’inzeppa d’infinito,
forse rincoglionisce.
(Mario Santagostini)
1
Quando, nel 1890, Raymond Saleilles apriva il suo Essai d’une théorie générale de l’obligation dichiarando, con enfasi solo apparente, che le obbligazioni non sarebbero altro che “l’espressione ideale della logica giuridica”, affermava un principio i cui effetti dobbiamo ancora completamente misurare. Appena quarant’anni dopo la pubblicazione del Das Obligationenrecht savignyniano, il giurista francese si limitava a rendere esplicito uno dei più consistenti guadagni della storia del diritto privato moderno: l’obbligazione è la forma logica di tutti i rapporti giuridici. Detto altrimenti: perché guadagni la sua propria consistenza giuridica ogni rapporto può e deve essere ridotto alla forma obbligatoria.
Negli ultimi anni, la filosofia ci ha abituati a inchieste sullo sfondo metafisico del neoliberalismo o sulle matrici teologiche della sempre più generalizzata condizione di indebitamento.
Più ancora che da un corpo a corpo con la questione puramente politica dell’ordine o con quella religiosa, ma variamente secolarizzata, della colpa, il neoliberalismo – e il suo effetto di tendenziale “economizzazione” delle condotte – dipende da una infrastruttura più resistente e forse prosaica, la cui matrice, inapparente, giace nella dogmatica del diritto civile.
Si capirebbe davvero poco delle metamorfosi del rapporto sociale di capitale, dei processi di finanziarizzazione e delle tecniche di regolazione dell’economia senza tenere in debita considerazione il ruolo che il rapporto obbligatorio svolge nella qualificazione e nel disciplinamento delle attività di produzione e circolazione della ricchezza.

2
L’emergenza che stiamo vivendo non ne offre soltanto una puntuale verifica ma – e questo importa soprattutto – apre lo spazio a una sua improcrastinabile revisione critica. Apriamo il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (noto giornalisticamente come “Cura Italia”), consacrato alle “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” e, all’art. 91, leggiamo: «All’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”».
Il dettato del comma 6-bis può rendersi forse più chiaro esplicitandone i riferimenti. Gli articoli 1218 e 1223 del codice civile disciplinano il risarcimento del danno in caso di inadempimento contrattuale. L’articolo del decreto legge ne disattiva gli effetti qualificando le «misure di contenimento» come il factum principis in ragione del quale il debitore inadempiente non sarà considerato responsabile.
Si tratta di una norma che potrà forse avere un impatto non irrilevante sulla vita di molte e molti: basti pensare a un conduttore che – impedito nella percezione di reddito perché costretto a casa dalle misure contenitive – non possa corrispondere il canone fissato dal locatore. Ma degli effetti sugli eventuali contenziosi civili che seguiranno e della bontà degli argomenti che in essi potranno essere fatti valere i giuristi stanno discutendo animatamente.
Non è tuttavia meno interessante sfruttare l’occasione di queste timide brecce che il legislatore ha cominciato a operare sulla altrimenti inviolabile vincolatività degli accordi negoziali per dare corso – in forma necessariamente stringata e probabilmente arruffata – a una riflessione di carattere più generale. Se è infatti vero che la vincolatività del patto è l’architrave della fisiologia obbligatoria, tutto ciò che è destinato a turbarla – si chiami oggi virus oppure in tempi più recenti crisi finanziaria – non può che avere un ruolo secondario nel più generale quadro del diritto dei contratti. Il cui obiettivo – storico, va da sé, ma dogmaticamente tradotto – è infatti da sempre molto meno quello di procurare arnesi utili a rinegoziare il contenuto dell’accordo che non quello di offrire modi rapidi e sicuri – per il creditore – di risolverlo.
Non è dunque casuale che la disciplina delle sopravvenienze, illustrata da una manciata di articoli del codice – 1463, 1467 – abbia generalmente un carattere marginale. L’eccessiva onerosità, da un lato, o l’impossibilità sopravvenuta, dall’altro, costituiscono quelle “ragioni” che consentirebbero al debitore di proporre al creditore una rinegoziazione dei contenuti del contratto. È lecito dubitare che esse possano sfoggiare oggi una inedita capacità di aggressione su sicurezze dogmatiche considerate inscalfibili e a tal punto interiorizzate dai giuristi.
Perché al dogma della vincolatività sia sottratta l’apparenza della naturalità e della razionalità bisognerebbe cominciare a considerarlo per quel che veramente è: l’esito di una contesa storica sulle forme del contratto.
Vale a dire: sull’apprensione formale e storicamente determinata di un certo modo di produrre e far circolare la ricchezza; su un modo possibile di disciplinare e qualificare i rapporti privati. Allora esso si confesserà uno schema, storicamente e ideologicamente, materialmente e logicamente, borghese. Uno schema, cioè, in cui la capacità normativa della volontà – il poter volere – non è altro che apparenza giuridica dello scambio – vendere, vendersi e comprare (forza lavoro, per esempio).

3
Il polveroso dossier delle sopravvenienze, disseppellito ora dalle segrete del codice, non sarà certamente decisivo in questa partita, la cui posta in gioco è, come si intuisce, immane. Tuttavia, anche limitandosi a considerarle nulla più che spie di una più profonda trasformazione, esse esibiscono il carattere virtualmente antagonistico della forma contrattuale, obbligando a fare i conti con le metamorfosi che interessano il traffico della ricchezza prodotta e appropriata.
Non è un caso che da qualche parte si cominci a parlare di autotutela del debitore. È un timido annuncio del progetto di sovversione di una retorica altrimenti egemone e montante, che, con la giustificazione dell’alleggerimento dei tribunali, ingorgati di contenziosi, propone la traduzione di esigibilità e esazione dei crediti in faccende quasi esclusivamente private.
È il caso dei cosiddetti nuovi patti marciani e di non poche direttive europee: forme di esecuzione del credito in autotutela, modi di escussione extragiudiziale accelerata che illustrano un progressivo assorbimento del diritto di credito in quello di proprietà. In questi casi, e senza il vaglio di un giudice, il creditore finisce col diventare proprietario di parti del patrimonio del debitore su cui può intervenire direttamente in vista della propria soddisfazione.
Ancora una volta, i contratti di locazione costituiscono un buon esempio e le molteplici astuzie in grado di aggirare il divieto di patto commissorio – art. 2744 c. c. che vieta l’estinzione del debito per mezzo della cosa ipotecata o impegnata – come è il caso di certi tipi di mutui ipotecari, non fanno che indicare che il diritto privato (europeo, specialmente) è a conti fatti nient’altro che una politica dei creditori. Un diritto dei privati, certo, almeno in qualche misura, ma che fa di effettività e private Ordnung un modo molto sofisticato di protezione dell’equilibrio degli scambi. Senza dimenticare, d’altronde, che il diritto privato europeo della regolazione rivendica la sua ascendenza ordoliberale come un blasone.
Chi è in cerca di illustrazioni di cos’è e come funziona quel neoliberalismo ancora troppo spesso descritto come fosse una divinità onnisciente e capricciosa è da qui che dovrebbe cominciare l’inchiesta. La crisi economica è stata una prima occasione per contestare questo stato di cose.
Una critica esigente, ma forse perfettibile, del divieto di patto commissorio è al centro dell’iniziativa politica della Plataforma de Afectados para la Hipoteca (PAH) in Catalogna già da molti anni. Oggi gli effetti del virus, e del suo governo giuridico, sulla materia contrattuale potrebbero avere un esito simile: imporre cioè, insieme a una diversa lettura dell’autotutela, qualcosa come una vera e propria politica dei debitori.
Non si tratterebbe allora più di proteggere la “parte debole” del contratto, come accade esemplarmente nel diritto dei consumatori, ma sarebbe la struttura stessa del rapporto obbligatorio a essere finalmente messa sotto cauzione.

4
La clausola di buona fede e il principio di solidarietà sono l’ascissa e l’ordinata di una strategia giuridica di contenimento degli effetti che la crisi – sanitaria, economica, ecologica, sociale – imprime alla struttura e all’equilibrio dei contratti. Ma la crisi del contratto che l’emergenza consente di leggere in forme tanto nitide non può accontentarsi di interpretazioni che avessero anch’esse un rango speculativo semplicemente emergenziale. Essa domanda di adoperarsi in una più generale e intransigente critica dell’obbligazione. Il tema principale riguarda la struttura del contratto e il ruolo che in essa ha giocato e potrebbe giocare il principio di solidarietà.
Siamo così costretti a tornare sulla Urszene delle obbligazioni: quando si riduce la forma dei rapporti a quella dell’obbligazione – separando la causa dai motivi – si decide, con lo stesso gesto speculativo, di identificare ogni rapporto, almeno virtualmente, con uno scambio; o per dirla altrimenti: di considerare giuridico solo quel rapporto economicamente valutabile.
L’astrazione e la forma sono, del diritto, le più formidabili invenzioni: alla metà dell’Ottocento esse hanno istituito il rapporto sociale di capitale mediando i rapporti attraverso il valore di scambio e disegnando la silhouette istituzionale della società (civile) sotto le spoglie di un mercato.
Ora, per ragioni che coincidono con la storia stessa del rapporto sociale di capitale, quel sistema di mediazioni (quella forma, quell’astrazione – non la forma, non l’astrazione) non ha semplicemente più corso. Le crisi, le emergenze sono occasioni che ricapitolano la storia passata e perciò, mettendocela di fronte agli occhi senza la mediazione della tradizione, ne autorizzano anche la critica.
La solidarietà continua purtroppo, in diritto civile, a funzionare come un contravveleno: un antidoto che l’interprete – che si tratti di dottrina o giurisprudenza – può somministrare a un rapporto la cui iniquità è patente o la cui onerosità insopportabile.
Ma essa non riguarda mai la struttura del rapporto di cui il contratto è lo schema formale. Questa solidarietà-vaccino tuttavia aveva senso soltanto in un tempo in cui la produzione della ricchezza e il suo traffico erano istituzionalmente coestensivi allo spazio di un “mercato”. Non aveva già più senso – anche se ha indubbiamente avuto una funzione progressiva – in epoca di produzione industriale. Può averne ancora in tempo di integrale socializzazione del lavoro, di tendenziale indiscernibilità di produzione e riproduzione sociale, di rarefazione della forma di vita salariale, di marginalizzazione dello scambio come dispositivo di estorsione e accumulazione del valore, di comune come modo di produzione?
Esistono quindi almeno due modi di intendere il rapporto tra solidarietà e contratto a cui fanno probabilmente capo due modi diversi di intendere il diritto privato e le sue politiche. Il primo li considera in un rapporto estrinseco: esisterebbe un principio “sociale” o “morale” della solidarietà che attraverso opportune operazioni – in cui la parte del leone tocca alla giurisprudenza – si tratta di “applicare” o “imporre” a una materia, come quella contrattuale, che, naturaliter (cioè dogmaticamente e non storicamente), si sarebbe istituita secondo linee anti-solidaristiche.
La solidarietà è cioè – sia nel caso di un’emergenza che in quello di un conflitto – un “supplemento”, giustificabile tanto secondo linee moralistico-caritatevoli – come fu nella sua variante corporativa – quanto secondo linee ispirate alla giustizia sociale e all’equità – come è stato e ancora è nella soluzione costituzionalmente orientata.
Il secondo postula invece l’esistenza di un rapporto (materialmente e storicamente) intrinseco tra principio di solidarietà e forma del contratto. Qui la solidarietà non è più un’integrazione postuma di un rapporto che sarebbe per definizione non-solidaristico, non-cooperativo; ma essa è invece un presupposto e una mediazione inaggirabile dello stesso rapporto di cui il contratto è la forma. Si dovrebbe a rigore parlare – per quanto la relatività del diritto lo conceda – di un “retroterra non obbligatorio” proprio come si è potuto parlare di un “retroterra non proprietario”.

5
Il “rincoglionimento” di quel “miracolo” tedesco che è il rapporto obbligatorio è attestato a chiare lettere da una panoplia di esperienze di mutualismo, solidarismo e auto-aiuto che – nonostante le misure contenitive – continua inopinatamente a crescere. Si tratta di un ventaglio di pratiche – che possono e non possono diventare “lotte” – interne alla produzione cooperativa di ricchezza (capitalistica), di cui esse provano tuttavia a interrompere la traduzione in valore privatamente appropriato.
Le attrici e gli attori che calcano questa scena non sono samaritane e filantropi, eremite e tecnofobi, ma utenti e locatarie, consumatori e lavoratrici, che producendo e riproducendo il comune in comune illustrano che la solidarietà non è qualcosa che si ottiene da altri ma è la condizione stessa di questo co-operare: della produzione e riproduzione di beni e servizi, dell’organizzazione di bisogni e interessi.
Forme di vita cooperative dunque non perché buone e coscienziose, ma perché così soltanto possono produrre e riprodursi, barcamenandosi tra ricerca di reddito, credito al consumo, risparmio e debito privato. Se ciò che esse annunciano è l’antropologia di un nuovo welfare, si tratta adesso di pensare le forme capaci di istituirla.
Il fatto che la “casa” sia lo speciale teatro di questa cooperazione è un’evidenza, o un’ironia, che meriterebbe un’analisi ulteriore. Il diritto civile l’ha costruita come uno spazio per eccellenza impolitico – sede di quelle obbligazioni dette non a caso “naturali” – confezionando il singolare paradosso per cui ai suoi occhi l’oikos è tecnicamente il meno “economico” degli spazi. Ma matrimonio e patrimonio, che ne custodiscono i limiti giuridici, stingono facilmente l’uno sull’altro.
La casa è quindi soprattutto il luogo che ospita la confusione e l’indeterminazione progressiva tra produzione e riproduzione. Lo è stato da sempre; adesso lo sanno tutti.
C’è da temere che sarà molto difficile arredarla con uno nuovo stile politico senza averne prima considerato fino in fondo l’infrastruttura giuridica. Una pandemia globale e qualche articolo del codice civile potrebbero darci una mano a intravedere un diverso modo di pensare le relazioni, qualificare i bisogni, disciplinare i rapporti, istituire e dare forma alla cooperazione. Per chi non ha dimenticato la sesta tesi su Feuerbach non dovrebbe trattarsi di un’impresa impraticabile.
Questo articolo è stato pubblicato su DinamoPress il 29 aprile 2020.