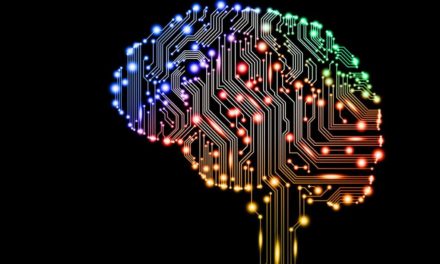di BENEDETTO VECCHI.
Indifferenti alla denunce, alle critiche, alle mobilitazioni dentro e fuori lo schermo – l’ultima, quella di Anonymous, ha suscitato l’indifferenza dei media mainstrem -, i guru dei big data continuano a presentare la raccolta, l’elaborazione e la vendita dei dati personali come una tappa della lunga marcia verso la società dell’abbondanza digitale. Fanno spallucce quando Snowden, Bradley Manning o Julian Assange denunciano che tale ammasso di dati viene conseguito ignorando il sacro principio delle società anglosassoni – la privacy – e di come i big data abbiano come contraltare una strisciante militarizzazione della comunicazione sociale, esemplificata dalla costituzione di un complesso militare-digitale che vede la partecipazione degli uomini e donne in divisa con i white collars della più note società che operano in Rete, da Microsoft a Google, da Apple a Facebook, solo per rimanere in ambito statunitense. Sia però chiara una cosa. Le recenti divulgazioni sulla attività di spionaggio della National Security Agency è una classica scoperta dell’acqua calda. E’ noto dai tempi di Echelon che le attività di intercettazione, di raccolta dati sulle comunicazioni personali sia un obiettivo strategico da parte dei governi nazionali. Quel che colpisce è che tale raccolta vede spostare una massa così ingente di finanziamenti statali verso tale attività che supera di gran lunga quelli destinati all’acquisto e alla messa a punto di nuovi sistemi di armamento. Solo negli ultimi cinque anni, infatti, Washington ha investito oltre cento miliardi di dollari nelle operazioni di intelligence digitale, proprio mentre chiudeva basi militari e «metteva in pensione» decine di migliaia di soldati e personale del Pentagono. Suonano altresì imbarazzanti le dichiarazioni di Barack Obama sulla necessità di regolamentare tale attività, visto che ne era a conoscenza e che sotto la sua amministrazione la Nsa ha visto quadruplicare i finanziamenti da parte di Washington. Così come suonano ridicole le rassicurazione che il presidente statunitense ha dato ai governi tedesco, francese, brasiliano, boliviano e argentino sul fatto che in futuro i cellulari dei rispettivi presidenti e le e-mail dei cittadini non saranno più “spiati”.
Nell’era del synopticon
La costituzione del complesso militare-digitale non è tuttavia un processo lineare. Vede smottamenti, differenziazioni, talvolta conflitti tra le agency della sicurezza nazionale e le imprese del big data. Da una parte la retorica della sicurezza nazionale, dall’altra la sottolineatura che la subordinazione delle imprese ai militari blocca lo sviluppo di un settore economico in progressiva crescita. Nessuno dei “duellanti” mette in dubbio che i dati raccolti siano una merce preziosa da mettere a profitto, con buona pace della privacy e dei diritti individuali: la posta in gioco, semmai, è quale debba essere l’ordine del discorso pubblico che legittimi tale espropriazione dei dati individuali. In ogni caso, le stesse imprese che contestano la centralità dei militari sono le stesse che usufruiscono, in maniera diretta e in maniera diretta, dei finanziamenti che gli stati nazionali devolvono al monitoraggio in tempo reale della comunicazione sociale. Con un linguaggio d’altri tempi, sembra di asssitere al remake del conflitto tra lo stato (rappresentante del capitale collettivo) e i capitali individuali. Una rappresentazione tuttavia parziale, che non coglie la differenza tra una società del controllo dove le tecnologie devono essere organizzate per centralizzare le attività di intercettazione e elaborazione dei dati e il dispiegarsi di quel fenomeno che lo studioso canadese chiama nel saggio La società del controllo il synopticon, cioè un controllo diffuso, capillare, attivato non solo dall’autorità costituita, ma anche da imprese e dai singoli, dove l’obiettivo non è la sola repressione, bensì la prevenzione di possibili comportamenti che mettono in discussione l’ordine costituito e il principio della proprietà privata.
L’affaire Nsa è tuttavia solo la punta dell’iceberg di un fenomeno che, su questo hanno ragione i guru dei big data, non coinvolge solo la violazione della privacy, ma la produzione dell’opinione pubblica e l’agire politico dentro le società capitalistiche. I big data, infatti, sembrano riuscire laddove altre procedure hanno fallito nell’assegnare alla doxa lo statuto della scientificità. Finora i sondaggi erano considerati solo incerti e spesso fallaci strumenti per capire cosa bolliva nella pentola dell’opinione pubblica. C’erano troppo variabili che giocavano a loro sfavore. In primo luogo la non neutralità dei committenti, che chiedevano infatti alle società del settore di veder confermate le loro strategie imprenditoriali o politiche. L’altra variabile era la scelta del campione, che spesso soddisfaceva i luoghi comuni stratificati sui comportamenti, le preferenze, gli stili di vita dominanti in un contesto nazionale. Infine, il terzo aspetto che ha sempre giocato a sfavore dei sondaggi nel legittimarli come strumento scientifico per capire i mutamenti dell’opinione pubblica è che vengono elaborati quando il rilevamento si è concluso da tempo. Questo sfasamento temporale tra raccolta e elaborazione dei dati impedisce di stare nel flusso cangiante e mutevole delle opinioni nelle società contemporanee. Tutto questo è invece aggirato dalla infrastruttura tecnico-cognitiva inerente ai big data. L’archiviazione dei dati presenti in rete e gli algoritmi per la loro gestione sono fattori che consentono una elaborazione in tempo reale. Inoltre, i big data non pretendono di aderire a un principio di scientificità Le correlazioni che permettono di stabilire hanno un margine di inesattezza che tende a zero. Questo margine viene gestito, indagato e interpretato, favorendo così ulteriori elaborazioni a partire da altri aspetti del vivere collettivo. Come è noto, nella statistica ciò che di discosta dalla rappresentazione matematica è altrettanto significativo da quanto postulano i grafici, le curve ricavata dall’elaborazione dei dati.
L’interfaccia dell’opinione pubblica
L’opinione pubblica non coincide tuttavia solo con i sondaggi. E’ un’espressione densa di storicità. Attiene al rapporto tra sovrano e governati; al funzionamento dei sistemi politici. Segnala la secolarizzazione del potere politico in epoca moderna e dell’agire politico nella contemporaneità, perché presuppone libertà di espressione, di stampa, di voto, di organizzazione politica. Viene per questo usata, almeno nel pensiero politico liberal-democratico, come termometro della democrazia: se si manifesta, anche vivacemente, lo stato di salute della democrazia è buono; se decade, indica una politicizzazione della sfera pubblica e il trionfo, appunto del sondaggio, cioè di una rappresentazione mediatica del conflitto tra punti di vista e interessi sociali. Anche in questo caso, i big data consentono di stabilire un legame di interdipendenza tra opinione pubblica e gli “intermediari” che agiscono – partiti politici, sindacati e organizzazioni degli interessi – tra gli stati, le imprese e società. Sono cioè l’indispensabile “interfaccia” tra agire politico e una supposta caotica società civile. E’ questa concezione che va messa a critica. Il pensiero critico – almeno dai “manoscritti del 44” e dalla Questione ebraica di Karl Marx – lo ha sempre fatto. Ma ciò che va registrato in questa fase dello sviluppo capitalistico è che l’opinione pubblica si presenta immediatamente sia come dispositivo politico usato dallo Stato in funzione pastorale che come settore produttivo. Google, Facebook, Microsoft, Apple con la loro raccolta e elaborazione di dati e informazioni sono nodi di una rete produttiva dell’opinione pubblica e al tempo stesso ne fanno il loro modello di business. E’ alla luce di questo dualità dei big data che alcuni studiosi della netculture li usano per sviluppare convenzione sociale incardinata nella visione neoliberista del capitalismo, in base alla quale il soggetto che accede alle informazione può decidere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, cancellando così le asimmetrie di potere, le disuguaglianze sociali e di classe presenti nel capitalismo. E allo stesso tempo stabilisce i criteri di legittimità dell’azione politica: chi si discosta, chi è fuori dalle elaborazioni delle informazioni e dai dati non è titolato ad esprimere il suo punto di vista. Da questo punto di vista, i big data, proprio perché producono opinione pubblica e alimentano un fondamentale settore produttivo, sono una dei capisaldi nella legittimazione dello staus quo. Un doppio movimento questo del capitale che va “destrutturato”. In primo luogo perché l’opinione pubblica è antitetica a una politica della trasformazione. In secondo luogo, perché i big data sono parte fondamentale dell’economia di rete e dunque del regime di sfruttamento.
Su questo secondo aspetto molto è stato scritto. I big data vengono accumulati con i click del “mi piace” di Facebook; oppure attraverso gli hashtag di Twitter; o con le centinaia di schede che vengono proposte ogni volta che si prenota un biglietto aereo, una stanza di albergo, si acquista un libro o un dvd on line. Ma sono anche raccolti quando si acquista una merce con una carta di credito. Ogni impresa coinvolta, li usa, li elabora per la sua attività imprenditoriale, per la gestione in tempo reale del magazzini, per riempire gli aerei, adottando una politica flessibile delle tariffe. Se mai avesse un qualche valore euristico il termine prosumer, è nei big data che può essere tranquillamente usato per descrivere come avviene questo immane accumulo della merce informazione, dove il consumo è anche produzione di una merce. I big data sono cioè un caso emblematico di una appropriazione capitalistica dell’intelligenza collettiva, della cooperazione sociale sans phrase. Anche in questo caso, l’intelligenza collettiva così come la cooperazione sociale non possa essere rinchiuse in una gabbia d’acciaio. L’appropriazione è efficace quando la cooperazione sociale è “libera”. Da questo punto di vista, le tecnologie del controllo sono sempre tecnologie del controllo ex-post: intervengono cioè in un secondo momento. E’ in questo frangente che entra in campo una infrastruttura tecnico-cognitiva composta di banche dati, di software sofisticatissimi che “impacchettano”, assemblano i dati non solo per essere venduti, ma anche per pianificare le strategie imprenditoriali delle stesse imprese che raccolgono i dati.
Il case study più noto è ovviamente quello di Google, un modello di impresa che coniuga l’uso di programmi informatici open source, la difesa strenua delle logica che presiede le sue banche dati, che fornisce gratuitamente i suoi servizi e ha blindato il brevetto del suo algoritmo Page Rank. Ma quel che offre come servizio Google – dalla posta elettronica alla consultazione dei file della sua libreria digitale, dalle mappe al software per organizzare il lavoro nelle imprese – è finalizzato a definire una mappa aggiornata in tempo reale di quanto accade in Rete. Il vero valore aggiunto di Google non è il motore di ricerca, bensì le decine di migliaia di server dove sono memorizzati miliardi di miliardi di dati. E’ ovvio che li vende agli inserzionisti pubblicitari; è ovvio che la attività di profiling è parte integrante della sua strategie di business, ma è altrettanto evidente che i big data hanno come destinatari privilegiate altre imprese e più recentemente anche i governi nazionali, come quello statunitense che quello cinese, come sanno bene i dissidenti detenuti nelle prigioni di Pechino dopo che la società di Sergej Brin e Larry Page ha fornito ai militari i contenuti delle loro mail e delle loro navigazioni in Rete.
Google, così come anche Facebook, altro esempio di appropriazione privata dell’intelligenza collettiva, sanno che il flusso di informazioni non può essere contenuto, arginato, controllato. Per questo hanno sviluppato, ognuna a loro modo, una strategia di fidelizzazione degli utenti. Devono cioè mantenere gli account operanti e attirarne di nuovi. Qui il case study più interessante è senza dubbio Apple. La sua strategie di cloud, cioè di offrire a chi acquista i suoi iPhone, iPad e computer portatili la possibilità di avere a disposizione software e memoria dove immagazzinare le informazioni individuali e potere raggiungere in ogni momento e in ogni luogo, è diventata di fatto un modello per tutti. A ruota ogni impresa ne ha fornito una propria versione.
Perdersi nel flusso
Ogni impresa propone dunque propone la sua «nuvola» di dati, garantendo una moderata privacy, sicurezza dei dati e accesso ai medesimi da ogni dispositivo tecnologico in possesso dei singoli, dal computer portatile, al tablet allo smartphone. Questo non significa una “disconnessione” dal flusso dell’informazione, bensì la possibilità di non “perdersi”, garantendo un porto di ingresso e alcune coordinate per meglio orientarsi. La logica della cloud è certo una logica economica, ma è anche un dispositivo per produrre opinione pubblica. Il flusso dei dati è infatti costituito dalle attitudini e alle preferenze nei consumi, ma anche di quella comunicazione generica inerente il proprio «essere in società». E’ la prima volta da quando si è cominciato a parlare di opinione pubblica che comportamenti quotidiani, consumi, affermazione di uno stile di vita sono parte integrante proprio della manifestazione dell’opinione pubblica.
Il democratico statunitense Robert Reich nella malinconica ricerca di un’opinione pubblica liberal negli Stati Uniti ha messo in evidenza, nel pamphlet Reason: Why Liberal Will Win the Battle for America come, negli Stati Uniti di George W. Bush e dei successi elettorali dei repubblicani, che tutti i sondaggi restituiscono una immagine degli Stati Uniti contraddittoria. Da una parte, una presenza costante di un significativo voto repubblicano , dall’altra comportamenti e stili di vita eterodossi rispetto a a quanto si richiamano ai valori americani e alle campagne della destra fondamentalista. Per Reich, l’opinione pubblica è così il nucleo fondante di quella “guerra culturale” che ha preso il posto del conflitto di classe e sociale. Per esteso, i big data sono il bacino che accoglie gli umori, i punti di vista dell’opinione pubblica.
E’ questa, per quanto mitigata, una versione della concezione neoliberista dell’opinione pubblica che è agli antipodi di una politica radicale della trasformazione. Per i movimenti sociali è l’habitat che va destrutturato per sfuggire alla trappola, ma anche alla tentazione, di essere ridotti anch’essi a opinione pubblica. Più semplicemente, occorre far tesoro di quell’indicazione metodologica che invita a stare dentro e contro il flusso di dati che dallo schermo tracima nelle “strade” (o dall’agorà) e che dalle strade irrompe nel cyberspazio. Stare dentro perché così si costruisce consenso, stare contro per riappropriarsi dell’intelligenza collettiva “catturata” dai padroni dei big data. Come sempre, il nodo da sciogliere è il dare forma allo stare contro, visto che anche l’espressione di punti di vista alteri, se non antagonisti possono essere sussunti dai produttori dell’opinione pubblica. Sicuramente, c’è la produzione di dispositivi alternativi a quelli mainstream. Sicuramente c’è la costruzione di mobilitazioni contro i segreti industriali e di Stato, come ha fatto Wikileaks. Politicamente significativa è anche l’esperienza della galassia di Anonymous, che partendo dal virtuosismo della tastiera ha poi stabiliti relazioni non episodiche con i movimenti sociali, come dimostrano le loro azioni a supporto di Occupy Wall Street, di piazza Tahrir, di Gezi Park e, per citare movimenti sociali geograficamente più vicini, ai NoTav. Negli ultimi tempi, soprattutto a partire dalle acampadas spagnole, alcuni gruppi di mediattivisti hanno sviluppato software che cercano di riprodurre sul web le procedure decisionale sperimentate dagli indignados. Sono strumenti wiki, cioè basati sulla condivisione e sulla costruzione della decisione attraverso il consenso. Con poca fantasia, vengono chiamati prototipi di tecnopolitica, quasi a sottolineare un uso sovversivo della tecnologia. Anche in questo caso, si tratta di sperimentazioni, caratterizzate da una concezione di una sfera pubblica non statale dove l’organizzazione politica può essere desunta dalla rete, inseguendo l’obiettivo che la risposta organizzativa adeguata al capitalismo contemporaneo può essere sviluppata riproducendo, cambiandogli di segno, i modelli organizzati più “avanzati” del capitale.
Ambivalenza della tecnopolitica
Non è certo la prima volta che il termine tecnopolitica ha fatto capolino nella discussione pubblica. Ad usarla come parola chiave per indagare il rapporto tra politica e tecnologia è stato Stefano Rodotà, laddove indica nei media tradizionali e nella Rete un potente agente nello svuotamento delle forme politiche novecentesche – il partito, il sindacato, la democrazia rappresentativa -, ma anche come tecnologie tendenti ad esercitare un controllo sulla vita individuale, al punto che non solo l’agire politico ma anche le idee sull’identità individuale che ne escono stravolte: i singoli devono conformarsi al «profilo» elaborato mettendo in relazione i dati acquisiti attraverso Internet. La funzione «colonizzatrice» delle tecnologie corrode alle base la democrazia, dissolvendo rapidamente la vision libertaria che ha accompagnato lo sviluppo della Rete. E se per un illuminista radicale come Rodotà, la tecnopolitica perde la sua ambivalenza per mostrare a tutto tondo il volto di tecnologia del controllo sociale, per Manuel Castells invece è proprio tale ambivalenza che ne esce rafforzata. In Comunicazione e potere (Università Bocconi Editore) lo studioso catalano analizza le esperienze di mobilitazione politica attivata attraverso social network e smartphone, individuando nella Rete la forma più compiuta di una «autocomunicazione di massa» che mette all’angolo i media mainstream. I software disponibili, così come i ridotti costi di connessione al world wide web permettono ai singoli di autoprodursi libri, cd musicali, ma anche di sviluppare siti informativi che hanno nei social network un potente megafono per le attività dei movimenti sociali. Si produce dunque azione politica attraverso la rete. Allo stesso tempo, le tecnologie digitali consentono di intervenire direttamente nella produzione dell’opinione pubblica, modificando le traiettorie del flusso di dati, così come riescono ad imporre temi e punti di vista che i media mainstream neppure registrerebbero. Ed è su questa concezione della tecnopolitica che i movimenti sociali hanno recentemente sviluppato una riflessione a partire dell’esperienza spagnola. La Rete non è solo uno strumento di comunicazione delle mobilitazioni sociali, ma anche un dispositivo per produrre organizzazione politica. A questo proposito sono interessanti alcune inchieste svolte in Spagna durante la fase alta delle acampada e delle mobilitazioni degli indignados, che metteno in evidenza non solo come dentro il movimento le parole d’ordine siano state recepite dagli attivisti, ma anche come il flusso comunicativo dentro i social network ne è stato influenzato. La tecnopolitica in questo caso è intesa come una produzione di organizzazione politica a partire dai flussi dentro la Rete, consentendo una inchiesta in tempo reale dei conflitti in corso.
Questa versione tardoleniniana della tecnopolitica sconta tuttavia un limite. La Rete viene infatti considerata come un modello perfetto di organizzazione dove sono assenti gerarchie e dove la divisione tecnica del lavoro – politico in questo caso – tende a un’armonia grazie alle procedure tese a costruire il consenso. E’ il contesto della libertaria orizzontalità. Una lettura meno lineare della genealogia della Rete può tuttavia mettere in evidenza come la Rete sia una forma di organizzazione molto rigida, dove sono presenti altrettante rigide gerarchie, con entrambi i fattori finalizzati a sviluppare una flessibilità nella risposta a un contesto in costante mutamento. La Rete è cioè sempre in divenire: Ciò che invece presenta una certa continuità è proprio l’organizzazione di base. Dimenticare questo, vuol dire consegnarsi alla mutazione della politica della trasformazione a opinione pubblica. Lo studio dei big data aiuta a rintracciare gli elementi di questa organizzazione che consente continuità e il divenire dell’azione politica. Senza cadere nella trappola dei due tempi – la tattica e la strategia, lo spontaneismo e la centralizzazione organizzativa – l’interrogazione continua dei big data, in questo caso dell’agire politico dei movimenti, consente appunto una flessibilità nella risposta dei movimenti alla divenire del contesto in cui operano. Certo c’è bisogno di software adeguati per riuscire in ciò. Ma è un software che non è un virtuoso succedersi di linee di codice, bensì quella forma specifica di intelligenza collettiva che è il pensare politicamente. Stando dunque dentro il flusso dei dati per essere contro chi lo sottopone a controllo, poco importa se uno Stato o un insieme di imprese.