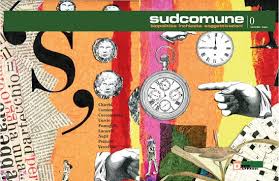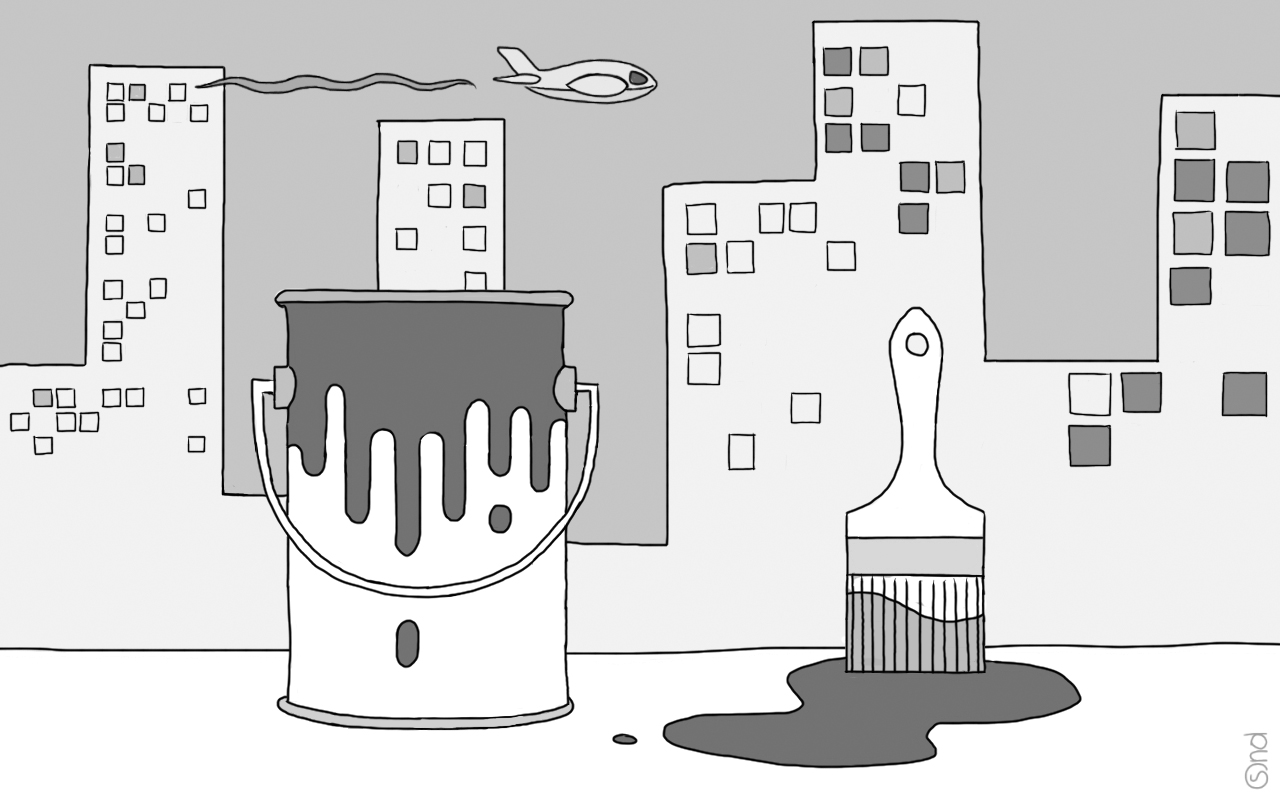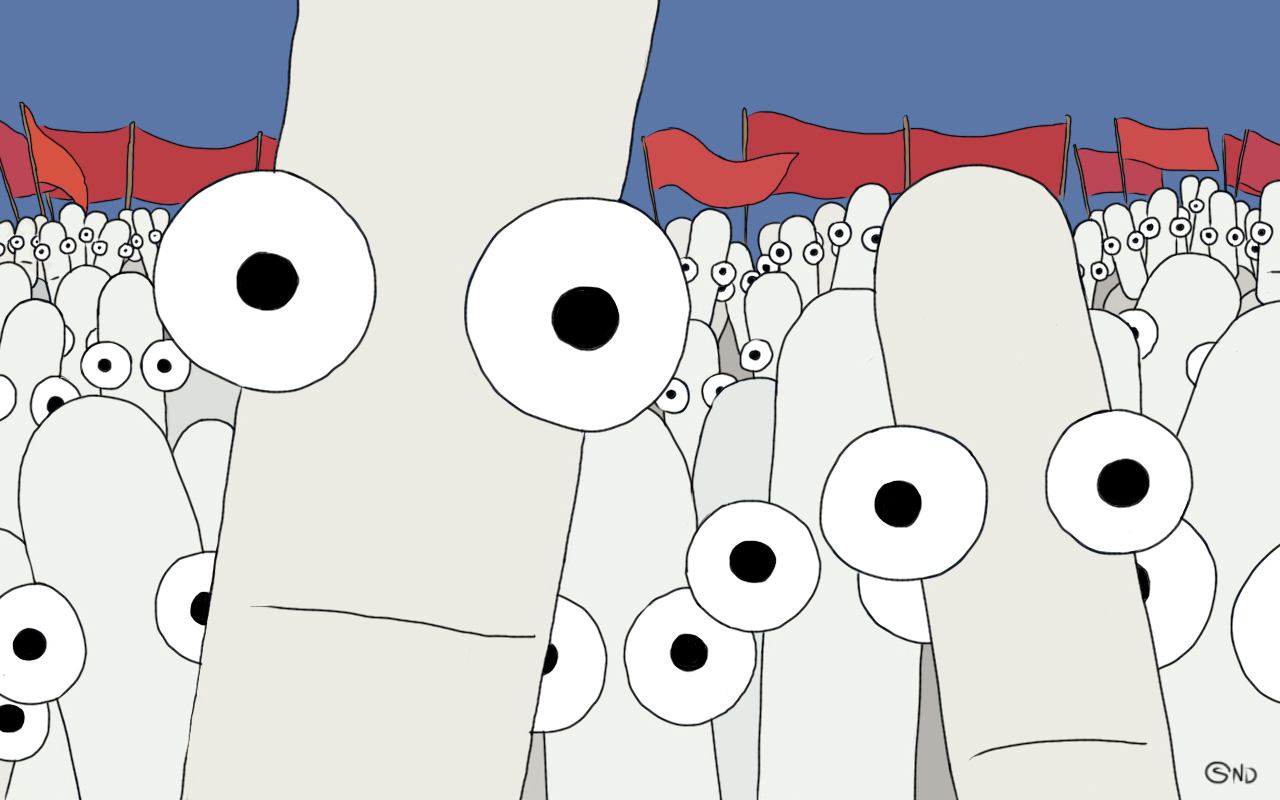TONI NEGRI intervistato da FRANCESCO RAPARELLI
(L’intervista, in vista della della C17 – Conferenza di Roma sul comunismo, che si tiene a Roma dal 18 al 22 gennaio, è stata pubblicata nell’inserto speciale de il manifesto “I 100 anni che sconvolsero il mondo”, giovedì 12 gennaio 2017)
Tra i più importanti filosofi politici mondiali, Toni Negri non smette di pensare il problema del comunismo. Per farlo, si colloca nell’unica posizione che conta: quella dei movimenti reali. Con lui abbiamo ripreso il filo della riflessione sulla crisi del neoliberalismo, ma abbiamo soprattutto insistito sui nuovi soggetti produttivi e le loro potenzialità rivoluzionarie.
Ne Il lavoro di Dioniso (con Michael Hardt) il modo di produrre contemporaneo viene descritto insistendo sulla centralità dei «prerequisiti di comunismo»; essendo il linguaggio, gli affetti, la mobilità divenuti pilastro della valorizzazione capitalistica. Invece di cancellare questa diagnosi, la crisi esplosa nel 2008 sembra confermarla. Concordi?
Penso di sì. In quel libro si trattò, in fondo, di riassumere una serie di elementi di analisi del lavoro e delle sue trasformazioni; analisi avviata molti anni prima, a partire dalla ricerca collettiva di Potere Operaio. Era una critica del movimento operaio tradizionale, fondata sulla mutazione profonda della composizione tecnica e politica della classe operaia. In particolare, ci apparivano radicalmente cambiati i processi di soggettivazione. Le lotte studentesche, soprattutto dopo il 1986 (come cominciai a chiarire in Fine secolo), sussumevano molti aspetti delle lotte operaie di allora; così come il lavoro informatico, digitalizzato, cominciava a conquistare centralità in queste ultime. Già nel 1986, e poi nel ’94-’95 in Francia, i conflitti enormi che esplodono – dal sapere alla salute, dai servizi urbani alla previdenza – insistono sul terreno della riproduzione e si articolano su quello metropolitano. È chiaro, dunque, che la crisi successiva al 2008 non fa altro che attaccare questo nuovo contesto. Di più: si tratta di una crisi che tenta di stabilire una forma di governabilità, come sempre succede in questi casi, sopra una modificazione radicale del soggetto produttivo.
In un saggio dedicato a Lenin, Lukács sosteneva che non si dà materialismo storico senza afferrare l’attualità della rivoluzione come «sfondo dell’epoca». Tale attualità sembra ormai introvabile. Eppure, come dicevamo, oggi più che mai i «prerequisiti di comunismo» qualificano il modo di produrre. Di fronte alla barbarie della crisi e della guerra, la rivoluzione è nuovamente l’unica alternativa?
Certamente è venuta meno ogni mediazione tra il livello del comando come si configura oggi nella sua dimensione finanziaria e il contesto generale nel quale opera il lavoro vivo. Venuta meno questa mediazione, è evidente che un processo rivoluzionario non può che essere la soluzione di una contraddizione tanto radicale quanto insuperabile. Tuttavia occorre chiarire cosa significa, oggi, rivoluzione. Già nei miei scritti degli anni ’80 c’era un’attenzione ai comportamenti attivi, alla produzione di soggettività che emergeva dalla nuova condizione proletaria. Credo che parlare di rivoluzione non significhi più – perché è un fatto ormai definitivo – parlare della rottura fra comando e resistenza, forme del capitale fisso e passività attiva del lavoro vivo nei confronti del comando, e quindi della rottura della dialettica. Non è più questo il problema centrale. Ma è quello di capire quali siano i comportamenti, i livelli di organizzazione, la capacità di espressione che ha il nuovo proletariato. Perché, quando si dice “non c’è soluzione se non la rivoluzione”, si dice una cosa ormai banale. Il problema non è sapere se è necessaria, piuttosto sapere come è necessaria e come è possibile. Escludere ogni soluzione riformista, implica oggi più che mai una soluzione processuale, definita dalla costruzione di istituzioni di contropotere reale. L’altro elemento da tener presente, oltre la forma del processo, è il fatto che quest’ultimo si sviluppa interamente sul terreno della riproduzione: la produzione è subordinata alla riproduzione; la fabbrica alla società; l’individuo al collettivo che si forma nella società. Ci si trova di fronte alla necessità di costruire istituzioni del comune, non come risultato ultimo del processo rivoluzionario, ma come condizione dello stesso. Da questo punto di vista penso che si tratti di riparlare dell’attualità della rivoluzione e di parlarne al presente, non come attualità di qualcosa a venire.
Torna in auge, nella scena contemporanea (dal bolivarismo ai populismi di sinistra europei), il tema dello Stato. Di più: la necessità, per i subalterni, di «farsi Stato». Una ripresa in forze di Gramsci, letto spesso con le lenti di Togliatti. Può darsi esperienza comunista – a maggior ragione nell’epoca della globalizzazione dei processi di valorizzazione – senza critica radicale della forma-Stato?
È chiaro che la critica radicale della forma-Stato è necessaria, ma per molti versi superflua. Nel senso che, se è vero quello che dicevamo prima, e cioè che si è data una rottura completa della mediazione, la stessa funzione dello Stato non può più essere recuperata in termini riformisti: è una funzione semplicemente oppressiva. Da questo punto di vista, lo Stato è qualcosa di parassitario; come tale, non può più collocarsi nella riflessione rivoluzionaria. Detto questo, però, bisogna stare attenti, perché il problema non è l’uso dello Stato in quanto tale. In qualsiasi fase di transizione non si può che praticare l’uso di strumenti generali come quelli che offre lo Stato. Per rovesciarli, evidentemente; per scarnificarli, mano a mano, dal carico di potere (oppressivo) che essi hanno in se stessi. Il vero nemico, dunque, è il feticismo dello Stato. Oggi esistono posizioni, non più ragionevoli, che nel considerare gli usi di certe funzioni pubbliche – affermate nella costituzione dello Stato – feticizzano la sovranità, l’autonomia del potere statale, comprimendo a dismisura la libertà delle lotte. Un feticismo di avanguardie che stanno sopra i movimenti reali – gli unici che trasformano il sociale. Occorre precisare, poi, che dietro il feticismo dello Stato ci sono sempre due ideologie/comportamenti: l’una è quella dell’avanguardia; l’altra è quella anarchica, dell’immediatezza, dell’apertura messianica. È di questi riferimenti che bisogna veramente sbarazzarsi.
La tua militanza comunista è cresciuta nelle lotte straordinarie dell’«operaio massa»; per poi incontrare, già nei tardi anni ’70, l’«operaio sociale»: nuova figura proletaria esito della scolarizzazione, dell’espansione del welfare, delle lotte per il rifiuto del lavoro. Queste stessa figura, nel mezzo della crisi, si presenta nel segno della precarietà. Cosa significa, su questo terreno, militanza comunista?
Significa riuscire a trasformare la sofferenza del bisogno, della mancanza, nella costruzione di un ‘noi’ desiderante. Nella flessibilità e nella mobilità, imposte dal regime neoliberale, aumenta la sofferenza individuale. Il collettivo, invece, va portato con forza dentro la “condizione operaia” contemporanea. La socialdemocrazia è stata incapace di cogliere, nella forma stessa del welfare e del lavoro che gli stava dietro, la necessità di esaltare il collettivo, l’insieme, e cioè il fatto che le singolarità vivono nel rapporto tra loro. Nella riscoperta di un collettivo cooperante può nascere oggi un nuovo spirito comunista! Evidentemente sono necessari passaggi materiali per capire come si procede dal bisogno al desiderio… e penso alla vecchia formula: appropriazione, istituzione e presa del potere. Appropriazione è la pressione che si esercita sul salario e sul reddito. Il momento ulteriore è quello istituzionale: riconoscersi e agire come ‘noi’. Passaggio fondamentale, in nessun caso riducibile all’immediatezza o alla presa di coscienza pura. Poi c’è il problema della presa del potere, che non è cosa mitica ed è fenomeno del tutto diverso da come l’abbiamo conosciuto: perché è la messa in atto di un processo costituente continuo, che non si blocca mai su forme istituzionali prefissate, ma che apre sempre le istituzioni a nuove capacità di consenso, di coesione, di cooperazione. E tutto ciò, ormai, deve avvenire sul terreno della riproduzione. C’è stata una cosa formidabile lo scorso autunno: la manifestazione delle donne di Roma. Un fatto che ha innovato, perché non è stata semplicemente una manifestazione contro la violenza di genere, quanto una dichiarazione fondamentale contro lo sfruttamento della donna inteso come elemento legato a tutte le forme del politico, così come oggi si presenta. Questo è il terreno biopolitico sul quale ci si muove.