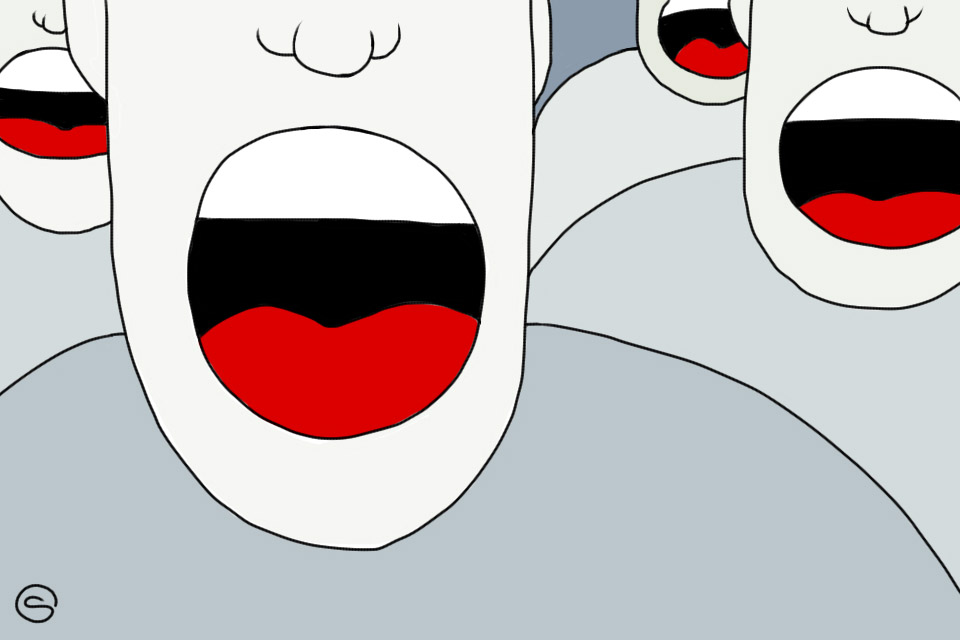di GIROLAMO DE MICHELE.
1. Cosa dice davvero la sentenza della Cassazione
Cominciamo col dire di cosa si sta parlando: non dei destini di Totò Riina, ma del rinvio per nuovo esame di un’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna.
La sentenza della prima sezione della Corte di Cassazione n. 27766, infatti, non delibera l’uscita o meno dal carcere del “capo dei capi”, ma rinvia l’ordinanza che ne aveva rigettato la richiesta di differimento dell’esecuzione della pena o, in subordine, di esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare perché formulata in base a una valutazione parziale e inadeguata; contraddittoria nelle motivazioni; basata su valutazioni errate e incomplete per aver deliberato sulle condizioni di detenzione, “le quali non possono certo essere considerate in astratto, bensì, in concreto, con riferimento anche a particolari caratteristiche del luogo di detenzione, se rilevanti”, in assenza di un doveroso accertamento volto a verificare, in concreto, la compatibilità della struttura carceraria con le condizioni di salute di Riina; carente di motivazione sotto il profilo della attualizzazione della valutazione sulla pericolosità del soggetto. E indica in modo puntuale cosa dovrà essere preso in considerazione, e sotto quale forma, nella nuova ordinanza che il Tribunale di sorveglianza dovrà scrivere. Da questo punto di vista, le ragioni (formali) del rigetto sono un atto di garanzia verso chiunque, in un ipotetico futuro, vorrebbe essere giudicato con piena e coerente considerazione delle proprie ragioni, dei nessi fra la situazione oggetto di giudizio e le norme penali, e il dettato costituzionale che le sorregge.
Chi ha criticato la sentenza, concedendo l’avvenuta lettura (doveroso nel caso di esponenti politici, magistrati di fama, giornalisti e direttori di giornali, per i quali non è pensabile che sia stato formulato un giudizio sulla base di un lancio di agenzia), non sembra in grado di discernere fra un’ordinanza malscritta e il suo oggetto: fra la cosa e il segno, in parole povere. O fra l’oggetto materiale e la sua simbolizzazione, che è anch’esso un segno; di fatto, l’oggetto dell’ordinanza è un essere umano che si approssima alla morte, e la cui morte può essere, a seconda delle cure di cui sarà in grado di disporre, differita o accelerata, e del quale il Tribunale di sorveglianza non può, sostiene la Cassazione, elencare le patologie ma non valutarne gli effetti né specificare quali debbano essere “i rimedi necessari [e] i tempi di realizzazione degli stessi”. Il che concerne il principio della dignità della morte. Che è, nei fatti, già stato violato dallo svolgersi degli eventi, se è vero che un ricorso avente conseguenze su un essere umano (non importa chi sia) affetto da gravissime patologie ha richiesto un anno per essere esaminato dalla Cassazione, che a sua volta non può che rimandarlo al mittente mentre il tempo scorre inesorabilmente: una giustizia che assomiglia al coccodrillo che, avendo ingerito la sveglia, ticchetta implacabile alle spalle di capitan Uncino. Se così fosse (e spesso così è), non vi sarebbe alcuno spazio per la dignità; ma neanche per quella che la retorica chiama “civiltà giuridica”.
2. La dignità nella Costituzione formale (presa sul serio)
 Il tema della dignità è apparso poco più che un orpello retorico, nella discussione para- (pseudo-) giuridica. E invece stiamo parlando di uno dei pilastri (qualcuno sostiene, in dottrina: il pilastro) che sorreggono l’architettura costituzionale: sarebbe davvero bizzarro che la Corte Costituzionale non ne avesse tenuto conto, considerato che, per citare qualche pronunciamento, per la Corte “quello della dignità della persona umana è valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo” (sentenza n. 293/2000); che di conseguenza non può essere leso “il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana” (111/2005; v. anche 162/2007); che uno dei nomi con cui la Costituzione chiama la dignità è il “diritto ad essere se stesso, inteso come rispetto dell’immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l’individuo”, ovvero quella “identità personale [che] costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata” (13/1994); di passaggio, ma non per caso: da qui discende il diritto a difendersi dai processi di soggettivazione eteronomi anche con pratiche di metamorfosi o desoggettivazione. Infine, sin dalla sentenza 12/1966: che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”.
Il tema della dignità è apparso poco più che un orpello retorico, nella discussione para- (pseudo-) giuridica. E invece stiamo parlando di uno dei pilastri (qualcuno sostiene, in dottrina: il pilastro) che sorreggono l’architettura costituzionale: sarebbe davvero bizzarro che la Corte Costituzionale non ne avesse tenuto conto, considerato che, per citare qualche pronunciamento, per la Corte “quello della dignità della persona umana è valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo” (sentenza n. 293/2000); che di conseguenza non può essere leso “il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana” (111/2005; v. anche 162/2007); che uno dei nomi con cui la Costituzione chiama la dignità è il “diritto ad essere se stesso, inteso come rispetto dell’immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l’individuo”, ovvero quella “identità personale [che] costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata” (13/1994); di passaggio, ma non per caso: da qui discende il diritto a difendersi dai processi di soggettivazione eteronomi anche con pratiche di metamorfosi o desoggettivazione. Infine, sin dalla sentenza 12/1966: che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”.
Per dirla in sintesi, la dignità compare nella Costituzione sotto un duplice aspetto: come principio personalistico (che rimonta al famoso ordine del giorno Dossetti del 9 settembre 1946), e come principio relazionale. Salda assieme gli articoli 2 e 3 della Costituzione, costituendo un insieme di diritti incomprimibili persino dalla sovranità popolare, a fortiori dallo Stato: e si fa garante dell’alterità dello Stato costituzionale da quello Stato Etico rispetto al quale la Costituzione si voleva diametralmente opposta. E vale la pena di sottolineare che lo Stato Etico è sempre e comunque fascista, nella teoria come nella prassi storica.
La dignità è l’indice di concretezza dell’eguaglianza (che sarebbe l’altro pilastro dell’architettura), e dà la misura dell’indivisibilità dei diritti (che non possono essere separati ad arbitrio del legislatore) e dell’effettività e universalità dei principi costituzionali. La pluralità delle sue denominazioni (dignità coincide anche con “rispetto”, oltre che “identità personale”) rende la sua forza giuridica equivalente a quella di altre carte costituzionali, come quelle tedesca, o di carte come quella di Nizza del 2000 (“la dignità umana è inviolabile”), o la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (“tutti gli esseri umani nascono eguali in dignità e diritti”) che ne esplicitano il carattere di fondamento.
Rimanendo al livello formale – prima di mettere in questione la decostituzionalizzazione di fatto e il sopravvento di una costituzione materiale che tende a sospendere quella formale –, una veloce rassegna dei pronunciamenti della Corte sul tema della dignità costituisce un elenco di ciò che è chiamato in causa dalla dignità costituzionalmente definita: universalità e completezza del sistema assistenziale (111/2005), diritto all’abitazione (404/1988), diritto a uno stile di vita compatibile col proprio stato di salute (218/1994), applicabilità agli stranieri dei principi di eguaglianza e dignità sociale (120/1967), ivi compresa l’incostituzionalità di misure discriminatorie in materia di prestazioni sociali (432/2005, avverso un provvedimento della regione Lombardia), pari dignità e uguaglianza della donna (126/1968), tutela delle minoranze linguistiche (15/1996) e religiose (117/1979), libertà di manifestare il proprio pensiero (112/1993). Infine, di un’ampia gamma di pronunciamenti in tema di welfare e, più in generale, di attuazione di quel comma 2 dell’art. 3 della Costituzione che prescrivono compiti irrinunciabili allo Stato, sino a configurarne la sua stessa ragion d’essere.
Concludendo questa rassegna, si deve convenire che mettere in discussione il principio della dignità significa minare il fondamento di una vastissima gamma di diritti: a riprova che i diritti sono sempre un insieme unitario, che viene leso nella sua interezza quando uno solo dei diritti dell’insieme viene leso (come scriveva non Stuart Mill o un qualche altro liberale, ma il giovane Marx che si batteva contro i provvedimenti di censura, sottolineando che è proprio la cattiva stampa il banco di prova del diritto alla libertà di espressione).
Tutto ciò costituisce, nella dura materialità dell’odierno esistente, una sorta di libro dei sogni. E si hanno ottime ragioni per sostenere che l’aspetto formale della Costituzione italiana “fondata sul lavoro” non è fuoriuscito dai limiti dell’immagine marxiana della contraddizione fra il cittadino che vive ne cielo di diritti, e l’uomo concreto che vive nello stato che determina le condizioni strutturali della negazione di quei diritti “borghesi”. Per di più, la decostituzionalizzazione in atto si configura come un deperimento dello stesso statuto formale della Carta.
Ma proprio per questo il principio della dignità trova spazio come terreno di resistenza.
3. La dignità come eccedenza giuridica
 Ha giustamente sottolineato Stefano Rodotà, facendo propria l’affermazione lapidaria di primo Levi “per vivere occorre un’identità, ossia una dignità”, che «il modo in cui il tema della dignità è stato riproposto nel tempo che viviamo si è sempre più identificato non tanto con una essenza o una natura dell’uomo, quanto piuttosto con le modalità della sua libertà ed eguaglianza» (Il diritto di avere diritti). Senza incamminarci sulla strada di una lettura sostanzialistica, cui in qualche modo il personalismo allude – perché “l’uomo è un’invenzione recente” –, qui preme sottolineare l’eccedenza del principio, o “valore” (meglio sarebbe dire, allora: metavalore) della dignità: da una perenne eccedenza deontologica e assiologica rispetto alle norme giuridiche che tendono a realizzarla (per dirla con l’Emilio Betti della Teoria generale dell’interpretazione). Questa eccedenza fa della dignità il nome comune di una pluralità di diritti potenzialmente illimitata (nel senso spinoziano del diritto secondo potenza): una nozione comune che esprime sempre un di più rispetto allo stato di cose esistente e giuridicamente normato. Questo di più costituisce un potenziale terreno di resistenza costituente per la (ri)appropriazione di quel complesso di diritti che si riassumono all’interno di quel tutto superiore alla somma delle parti che è il principio di dignità.
Ha giustamente sottolineato Stefano Rodotà, facendo propria l’affermazione lapidaria di primo Levi “per vivere occorre un’identità, ossia una dignità”, che «il modo in cui il tema della dignità è stato riproposto nel tempo che viviamo si è sempre più identificato non tanto con una essenza o una natura dell’uomo, quanto piuttosto con le modalità della sua libertà ed eguaglianza» (Il diritto di avere diritti). Senza incamminarci sulla strada di una lettura sostanzialistica, cui in qualche modo il personalismo allude – perché “l’uomo è un’invenzione recente” –, qui preme sottolineare l’eccedenza del principio, o “valore” (meglio sarebbe dire, allora: metavalore) della dignità: da una perenne eccedenza deontologica e assiologica rispetto alle norme giuridiche che tendono a realizzarla (per dirla con l’Emilio Betti della Teoria generale dell’interpretazione). Questa eccedenza fa della dignità il nome comune di una pluralità di diritti potenzialmente illimitata (nel senso spinoziano del diritto secondo potenza): una nozione comune che esprime sempre un di più rispetto allo stato di cose esistente e giuridicamente normato. Questo di più costituisce un potenziale terreno di resistenza costituente per la (ri)appropriazione di quel complesso di diritti che si riassumono all’interno di quel tutto superiore alla somma delle parti che è il principio di dignità.
Torniamo alla sentenza della Corte: essa traccia una distinzione netta fra due concezione della vita e del Bíos che va ben oltre il caso specifico.
Per il Tribunale di sorveglianza, «la possibilità del prospettato esito infausto integr[a] una “condizione di natura” comune a tutti gli appartenenti al consesso umano, anche non detenuti e, pertanto, di una circostanza neutra ai fini della valutazione del senso di umanità richiesto dalla costituzione nell’espiazione della pena». Morire è un fatto neutro che accade a tutti, la cui ineludibilità rende poco rilevante la sua modalità: per questi giudici la vita appartiene alla morte.
All’opposto la tesi della Corte, «dovendosi al contrario affermare l’esistenza di un diritto di morire dignitosamente che, proprio in ragione dei citati principi, deve essere assicurato al detenuto ed in relazione al quale, il provvedimento di rigetto del differimento dell’esecuzione della pena e della detenzione domiciliare, deve espressamente motivare». È il morire che è una modalità della vita, e la cui modalità rientra in quell’intangibilità eccedente del Bíos che costituisce un limite alla potestà della legge.
L’homo dignus non si limita a vivere in un sistema di relazioni definito dalla norma costituzionale (fin qui Rodotà) ma la eccede, e proprio per questo ha diritto di pretendere che ogni sfaccettatura, ogni declinazione del principio di dignità sia difeso dall’imperio e dalla potestas. Una dignità comprimibile e soggetta a sospensione implica un Bíos comprimibile, assoggettato alla legge del valore, riducibile a merce: fino alla reintroduzione del potere di dare, determinandone le modalità, la morte da parte di quel biopotere che già si arroga il diritto di determinare le modalità del vivere.
Il diritto a morire dignitosamente è l’espressione dell’evento della morte che accade a una vita che ha diritto di vivere dignitosamente: ma questa dignità non è una fatto giuridico, ma un terreno di lotta, al di là del convenire della Corte costituzionale su questo terreno. Dopo tutto, la critica del diritto, per noi che abbiamo visto Genova (dove si andò per rivendicare dignità per tutt@) e letto Pasukanis, comporta la possibilità di usare il diritto stesso come strumento, una volta sfatato l’incanto della sua santità. Il che significa, per limitarci allo stretto ambito carcerario, che di questo terreno di lotta fanno parte rivendicazioni storiche quali l’abolizione dell’ergastolo, l’umanizzazione della pena, il rifiuto di condizioni di detenzione che scendano al di sotto della soglia dell’umana dignità e di ogni forma di tortura, implicita o esplicita.
4. Il partito dei parenti e il frame dello Stato contro la mafia
Contro la sentenza della cassazione si è levato un muro di proteste aventi per oggetto la specifica figura di Totò Riina: da esponenti politici a testate giornalistiche, fino al fantomatico partito dei familiari delle vittime, fra i quali i pareri sono stati scelti fior da fiore in base al tenore delle dichiarazioni – e dunque ampio spazio a chi ha evocato una sorta di occhio per occhio, e silenzio su chi, come Maddalena Rostagno, ha ricordato il valore dell’umanità in quei familiari che non augurano la morte, o altro, a chi è rinchiuso in carcere.
Ma sarebbe una regressione gravissima se le passioni, gli umori, le percezioni soggettive dei congiunti avessero rilievo nell’applicazione delle norme, come esemplificò a suo tempo il romanzo di Massimo Carlotto L’oscura immensità della morte (in seguito adattato al teatro da Alessandro Gassman).
Così come sarebbe – anzi: è – cosa gravissima se a determinare l’esito di un’istanza fossero passioni, percezioni, umori della cosiddetta pubblica opinione: ovvero quel coacervo di passioni tristi e sentimenti reattivi che orientano la propria percezione di impotenza e passività verso il doppio vincolo della delega “verso l’alto” della decisione e della designazione “dal basso” di un capro espiatorio sul quale sfogare il proprio rancore.
Per tenersi lontani da discussioni sul ripagare l’indegnità con l’indegnità: ciascuno ha diritto non solo a una morte degna, ma se possibile anche a non morire, a Palermo come a Genova o Milano, dal carcere dell’Asinara a quello di Alessandria; e ciascuno ha le proprie Spoon River che esigono rispetto. La questione ha allora due aspetti, quello simbolico e quello afferente alla concreta figura di Riina.
Quanto al primo punto, ha ricordato il Garante dei diritti dei detenuti Mauro Palma che «se le decisioni su un determinato soggetto vengono assunte in funzione del messaggio che ne può derivare, allora quella persona è ridotta appunto a mezzo, e questo non è mai lecito». I simboli sono (o pretendono di essere) atemporali, gli esseri umani no; il Riina di oggi (ricoverato da oltre un anno, com’è ormai noto, in una clinica adattata a sezione carceraria), un “soggetto di età avanzata, affetto da plurime patologie [una duplice neoplasia, cioè un cancro] che interessano vari organi vitali, in particolare cuore e reni, con sindrome parkinsoniana in vasculopatia cerebrale cronica”, non è lo stesso del 2013, quando sembrava ancora in grado di come in grado di occupare una “posizione di vertice assoluto dell’organizzazione criminale Cosa Nostra”.
Chiede la retorica odierna: può “lo Stato che combatte la mafia” consentire alla scarcerazione di una delle sue figure di vertice (della mafia, beninteso)?
Qui è inutile cercare la risposta giusta, poiché errata è la domanda. In primo luogo, perché la domanda presuppone Stato e mafia come due entità contrapposte ai due lati dell’ipotetica barricata della “legalità”, senza alcuna frammistione, zona grigia, compartecipazione e compresenza: un’idea della criminalità organizzata che rimonta ai tempi in cui Leonardo Sciascia era ancora un giovane maestro di belle speranze e buone letture. La criminalità organizzata (quella parte definita “illegale”) è in realtà un sistema di possesso, circolazione e distribuzione del capitale, delle merci e degli esseri umani tanto quanto la parte “legale”; come questa, è costituita da processi di assoggettamento e controllo, di aggressione ed estrazione della ricchezza sociale; al pari di questa, favorisce ed è favorita dal progressivo divenire-rendita del profitto.
L’economia criminale, come ogni altro segmento, si è finanziarizzata: «si avvale del mercato globale e della comunicazione, si caratterizza per il prevalere del capitalismo cognitivo. E proprio per questo non è separabile dal meccanismo capitalistico nel suo complesso» (Gianni Giovannelli, Triplo zero o zero work?). L’economia criminale, così come quella legale, è parte, non limite, dello Stato. Si avvantaggia delle norme che rendono il lavoro sempre più precario come di quelle che trasformano gli esseri umani in merce vendibile dalle coste della Libia alle celle frigorifere degli hub della logistica; può accumulare una grande quantità di ricchezza monetaria perché la finanziarizzazione e globalizzazione dell’economia le consente di allocarla; può impossessarsi di segmenti della società e del comune grazie alla privatizzazione di ogni aspetto di socialità, dal welfare all’istruzione, dalla sanità all’abitare, dallo smaltimento dei rifiuti alla moda.
![]() Reiterare il frame dello “Stato contro la mafia” e del Riina “capo dei capi” favorendo al tempo stesso le condizioni strutturali di riproduzione e allargamento della presa di possesso criminale del comune significa in realtà riaffermare l’immagine del mafioso cafone semianalfabeta, tutto coppola-e-lupara, e nasconderne la vera natura del fenomeno. E fare della “lotta alla criminalità” una questione di carceri e tribunali: ovvero, ridurre il diritto (e la lotta necessaria) a una vita degna alla delega della lotta in favore di figure e istituzioni che si fanno garanti di una società promessa futura “senza criminalità”: nella quale, come nel caso della beneficenza che guarisce dalla malattia il bambino africano, si potrà vivere “in sicurezza” all’interno di quella stessa società che la malattia che si è rimossa o dilazionata la genera e riproduce.
Reiterare il frame dello “Stato contro la mafia” e del Riina “capo dei capi” favorendo al tempo stesso le condizioni strutturali di riproduzione e allargamento della presa di possesso criminale del comune significa in realtà riaffermare l’immagine del mafioso cafone semianalfabeta, tutto coppola-e-lupara, e nasconderne la vera natura del fenomeno. E fare della “lotta alla criminalità” una questione di carceri e tribunali: ovvero, ridurre il diritto (e la lotta necessaria) a una vita degna alla delega della lotta in favore di figure e istituzioni che si fanno garanti di una società promessa futura “senza criminalità”: nella quale, come nel caso della beneficenza che guarisce dalla malattia il bambino africano, si potrà vivere “in sicurezza” all’interno di quella stessa società che la malattia che si è rimossa o dilazionata la genera e riproduce.
Quanto al vecchio “capo dei capi” morente in cella: la sua immagine verrà buona per una nuova fiction, della quale si parlerà poi da Bruno Vespa, interpretata dal solito noto attore che sarà intervistato da Fabio Fazio. Il tutto con la giusta misura, e senza mai nominare un sintagma come “democrazia cristiana”: non sia mai che ad altri sia dato il pretesto per una trasmissione concorrente che ne impoverisca l’audience e scontenti gli inserzionisti pubblicitari.