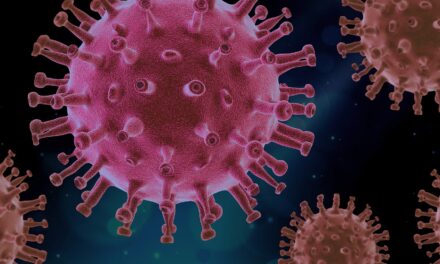di MIGUEL MELLINO.
29/12/2011
1. Il 23 Ottobre scorso Cristina Fernández de Kirchner ottenne una vittoria schiacciante alle elezioni nazionali argentine. Si tratta della terza vittoria consecutiva di un Kirchner alle presidenziali dal 2003. La serie di successi e il suo arco temporale ci offrono un primo dato da tenere in considerazione: il post 2001 – tranne la sanguinosa parentesi di Duhalde (messa definitivamente a nudo con il massacro di Avellaneda nel 2002) – è stato interamente dominato dal kirchnerismo. Anche se nel discorso pubblico il governo non smette di istituire il Dicembre 2001 come il significante chiave della catastrofe, come il momento più nero di una lunga notte neoliberista iniziata nel 1976 con l’ultimo golpe militar, anziché come il suo felice anno zero, è chiaro che il kirchnerismo ha costruito buona parte della sua forza e originalità a partire da quello che si può chiamare un’efficace “lettura a contropelo” (rinvigorimento e castrazione al tempo stesso) di ciò che questo evento ha significato nella storia del paese. In breve: rispetto al resto dello spettro politico locale solo i Kirchner (un po’ a causa della propria storia, marchiata a pelle dalle tragedie della sinistra rivoluzionaria peronista, un po’ a causa di un innegabile talento politico) hanno compreso subito che l’unico modo di ricostruire potere e consenso a partire dallo stato era quello di contrattare – negoziare – con le soggettività politiche emerse nel 2001. E questo perché il legato più duraturo del Dicembre 2001 riguardava proprio la questione della rappresentanza nella sua totalità (Que se vayan todos!): governare da qui in poi avrebbe significato fare quotidianamente i conti con il conclamato potere destituente della moltitudine, di un’irreversibile e oramai costitutiva eterogeneità sociale maturata (sia come soggettività che come resistenza) nel lungo processo di neoliberalizzazione della società. Contrariamente a quanto crede un certo senso comune in Italia, “que se vayan todos” voleva dire proprio “todos”: la classe dirigente nel suo complesso (politici, partiti, sindacati, burocrati, élite economiche e culturali, imprenditori, giudici, giornalisti ecc.) e non soltanto il ceto politico. Si può dire che il sentire che ogni governo è destituibile, così come il grande protagonismo dei movimenti, il loro radicamento sociale e territoriale, nella disputa degli spazi di potere e contropotere (un fatto del tutto inedito nell’Argentina precedente agli anni novanta) siano stati i veri condizionanti della gestione politica post 2001.
D’altra parte, è proprio questa esigenza di contrattazione permanente, al cuore del progetto politico K, ad aver reso difficile da sempre una definizione plausibile di ciò che i kirchneristi chiamano da qualche anno il “modello” del governo. Sin dall’inizio, il kirchnerismo è stato costretto a inventarsi, a plasmarsi e riplasmarsi, giorno per giorno, ben consapevole che il proprio consolidamento sarebbe dipeso da questa estrema plasticità e incompiutezza della propria forma. Come ha suggerito il filosofo argentino Horacio Gonzalez nel suo Kirchnerismo: una controversia cultural (2011), se vi è qualcosa che ha caratterizzato il kirchnerismo nei suoi primi anni di vita è stata soprattutto la “mancanza di testi”.
Tuttavia, rispetto ai due successi elettorali precedenti, l’ultimo sembra aver segnato un punto di non ritorno, la condensazione, la cristallizzazione di un processo egemonico ascendente iniziato nel 2008, paradossalmente, dopo una doppia sconfitta: nel conflitto con il campo e alle successive elezioni di mezzo termine. Se parliamo di punto di non ritorno non è unicamente a causa della dimensione del trionfo elettorale di Cristina, ma perché negli ultimi due anni il kirchnerismo sembra essersi (finalmente) costituito come progetto egemonico. In termini hegeliani, potremmo dire che il kirchnerismo è venuto finalmente al concetto.
Così, da due anni a questa parte appare più fondato, politicamente e culturalmente, nominare qualcosa come “kirchnerismo”. Certo, non è un caso che questa “materializzazione egemonica” sia avvenuta in concomitanza con quello che settori importanti della società argentina (e non solo l’intellighenzia progressista) hanno letto come una chiara radicalizzazione del modello K, come un deciso avvicinamento alle esperienze di Chavez e Morales: soprattutto se guardiamo ai provvedimenti “progressisti” intorno a cui il governo ha costruito intelligentemente questo tipo di consenso negli ultimi due anni (la legge contro i monopoli mediatici, le leggi dell’assegnazione universale per figlio, dei matrimoni ugualitari, delle pensioni per le casalinghe ecc.); all’impegno più deciso in favore di un’integrazione regionale continentale non solo sulla carta (vedi la centralità di Néstor Kirchner nella costituzione della UNASUR e nella promozione di iniziative come il Banco del Sur) e, infine, a un avvicinamento più determinato in politica estera (anche se piuttosto temperato a livello retorico-discorsivo) al cosiddetto “blocco contro-egemonico” internazionale (Venezuela, Brasile, Cina, India ecc.). Da questo ultimo punto di vista, non è casuale che questo “schieramento” abbia acquistato contorni meno sfumati unitamente al dipanarsi della crisi finanziaria globale, soprattutto dentro i confini UE, e all’intensificarsi della rete di scambi economici tra i paesi emergenti. In sintesi, il kirchnerismo sembra mostrare ora una forma politica più compiuta rispetto al passato. Riprendendo un’espressione di César Altamira, sembra che oggi appaia più facile fotografare il “kirchnerismo al desnudo” (vedi Kirchnerismo extemporaneidad latente, in questo stesso sito).
2. Ma di che cosa è sintomo questo maggiore compimento del kirchnerismo come progetto politico? Secondo alcuni, le autorappresentazioni del governo e i discorsi di buona parte dell’intellighenzia progressista locale, il kirchnerismo è oramai espressione del definitivo consolidamento di una sorta di “neo-sviluppismo inclusivo”. Si tratta di una formula che richiama al vecchio modello nazional-popolare di sostituzione delle importazioni attraverso cui il peronismo aveva operato in passato (nei due primi governi, 1946-1955) una radicale redistribuzione della ricchezza sociale e materiale del paese e costruito un solido stato di benessere. Secondo altri, come Ernesto Laclau (divenuto a Buenos Aires una sorta di consigliere del principe) e alcuni dei suoi seguaci locali, il kichnerismo ci interpella come una forma di “populismo” o di “neo-populismo” radicale. Infine, altri contributi al dibattito vedono nel kirchnerismo il sintomo dell’affermazione e stabilizzazione nel paese di una sorta di “ultra-centro” o “estremismo di centro”.
Mi sembra che ognuna di queste tre nominazioni riesca a cogliere alcuni dei tratti costituenti del kirchnerismo; tuttavia, nessuna di esse appare in grado di mettere a fuoco in modo efficace le novità – ovvero l’alto grado di mobilitazione e di produttività politica – rappresentate comunque dal kirchnerismo: le prime due perché guardano (in modo distorto, anche se da diversi posizionamenti politico-culturali) verso un passato in qualche modo “mitico” o “mitizzato”; la terza perché, al contrario, cercando di rendere conto del (peraltro reale) brusco arresto operato dal kirchnerismo sull’autonomia delle lotte e del lavoro “biopolitico”, ovvero del suo costituirsi come potente “dispositivo di cattura” di quell’immanenza sociale e politica emersa con forza nel 2001 (aspetto più marcato nel testo di Altamira), finisce per minimizzare quello che vogliamo chiamare la sua “storicità”, il suo dover operare “qui e ora” e quindi i suoi elementi di discontinuità rispetto alle gestioni politiche precedenti. In questo senso, ci sembra che il kirchnerismo abbia assunto progressivamente la forma più o meno compiuta di quello che può essere chiamato una “governance post-neoliberale”. Dove il post qui sta a indicare proprio quella convivenza tra vecchio e nuovo, tra regressivo e progressivo, tra crisi permanente e stabilizzazione, tra politicizzazione e de-politicizzazione che sembra attraversare la sua (fragile) articolazione sin dall’inizio. Crediamo inoltre che interpellare il kirchnerismo come “governance post-neoliberale” ci consenta di comprendere in modo più efficace la stessa logica dell’articolazione di quei tre “poli” giustamente identificati dall’articolo del Colectivo Situaciones come “centro centripeto” della congiuntura K in Argentina: 1) un polo esportatore estrattivista, fondato sullo sfruttamento delle risorse naturali, generatore di eccedenti fiscali-monetari; 2) un polo fondato su una retorica tecnologico-industrialista (sviluppista); 3) un polo fondato sulla dinamica dei “diritti” (sociali e umani) e quindi (aggiungerei) dell’inclusione sociale.
3. Come è stato più volte detto, il Kirchnerismo cominciò a legittimarsi come progetto politico dopo le elezioni del 2003 (in cui ottenne una vittoria soltanto di misura) a partire dalla trasformazione in politiche costituenti di alcune delle istanze più urgenti emerse con il movimento insurrezionale del 2001. É oramai parte del senso comune affermare che uno dei punti di forza del Kirchnerismo è quello di aver letto in modo corretto ed efficace non solo le domande emerse dal 2001, ma anche la nuova composizione sociale e politica della società argentina. Può essere di qualche utilità ricordare oggi, nel momento in cui la BCE esorta i paesi UE a radicalizzare ancora le politiche neoliberiste di austerità come unico rimedio alla crisi finanziaria globale, alcuni dei principi fondamentali attraverso cui il kirchnerismo ha articolato questo primo processo di legittimazione: stop alla repressione poliziesca della protesta sociale; riapertura delle cause giudiziarie ai militari e promozione attiva degli organismi dei DDHH sullo scenario pubblico; uscita dal consenso di Washington, vale a dire rottura con le ricette economiche del FMI e della Banca Mondiale in quanto chiave per risolvere il default e quindi sospensione e successiva liquidazione del pagamento di buona parte del debito estero; no deciso all’ipotesi di ulteriori “aggiustamenti strutturali” in senso monetarista; progressivo aumento della spesa pubblica nei settori sociali chiave (salute, istruzione, infrastrutture in generale ecc.), apertura ad alcune delle domande provenienti dai movimenti sotto forma di nuove politiche sociali (sussidi di diverso tipo, concessione di ampi spazi di (auto)gestione, ecc.), destituzione della vecchia e corrotta corte di giustizia nominata da Menem, incoraggiamento del riconoscimento legale (sotto forma di cooperative) di molte delle fabbriche occupate; misure e sovvenzioni in favore della riattivazione dell’apparato produttivo nazionale.
Attenzione però, non si tratta di idealizzare alcunché. Nel 2003, dopo 25 anni ininterrotti di saccheggio neoliberista, l’insurrezione del 2001, il default economico e i due anni di sanguinosa e altamente instabile transizione del governo Duhalde, una lettura sensata del rapporto di forza realmente esistente tra governo e movimenti sociali suggeriva un’apertura a queste istanze come unico modo possibile di ricomporre sia le logiche nazionali dell’accumulazione che la governabilità della società. Insistere sulla strada della repressione, dell’aggiustamento e dell’austerity cominciava a profilarsi come una scelta impraticabile e “poco redditizia” anche per buona parte delle élite. L’alto livello di mobilitazione politica e sociale, e un livello incontrollabile di indignazione popolare, rendevano problematica la scelta del terrore fisico e dell’austerity: il costo (in termini di violenze e di ingovernabilità) di questa politica appariva al tempo stesso inquietante e poco prevedibile. In questo senso, il massacro di Avellaneda ne era stato un macabro sintomo. La soluzione Duhalde, che in passato era stata sempre affidata a un altro tipo di agente politico, l’oramai del tutto fuorigioco “partito militare”, si presentava allo stato e al capitale come una strada piuttosto impervia.
É chiaro però che il progetto kirchnerista sarebbe ugualmente naufragato senza altre due ulteriori svolte. La prima è stata quasi immediata, e riguardava una revisione dell’inserimento stesso dell’economia argentina nel sistema globale, il quale cominciava a mostrare allora una congiuntura per certi aspetti diversa da quella degli anni precedenti. Così, approfittando del boom ascendente dell’agrobusiness e delle commodities (prima di tutto la soia, ma anche altre risorse naturali come gas, petrolio, pesca, industria mineraria ecc.), il kirchnerismo optò per la trasformazione graduale dell’Argentina, da mero ricettacolo della speculazione finanziaria internazionale a stato neo-mercantilista improntato allo sfruttamento intensivo ed estensivo delle risorse naturali e quindi all’esportazione di materie prime. Il modello qui traeva ispirazione in qualche modo dalle politiche del primo peronismo (1946-1955): trasferire l’eccedente fiscale (dovuto a un’alta tassazione dell’export) e quello monetario generato dalle esportazioni (surplus della bilancia commerciale) verso la spesa sociale e la riattivazione dell’apparato produttivo. Come si può intuire, è stata questa ricollocazione dell’Argentina nel mercato mondiale, all’interno di una congiuntura economica nettamente favorevole, a garantire le risorse necessarie a supportare ciò che abbiamo chiamato “governance post-neoliberale” kirchnerista. La seconda scelta è stata successiva e più graduale: mettere al lavoro (attraverso sussidi, incarichi statali e municipali, deleghe di gestione, politiche sociali mirate ecc.) la ricchezza sociale e politica, così come l’alto grado di insediamento territoriale, accumulati negli anni precedenti dalle lotte di resistenza dei diversi movimenti sociali. In poche parole: si trattava di captare e di rendere più produttivo il capitale sociale e politico “alternativo” dei movimenti e di altri settori dell’attivismo sociale, della cooperazione e dell’associazionismo. Ma è bene ricordare che questa “messa al lavoro” della produttività sociale maturata attorno alle lotte di resistenza dei movimenti è avvenuta attraverso “politiche sociali” molto diverse rispetto a quelle del passato: ogni finanziamento pubblico venne elargito in cambio di un certo tipo di controprestazione (servizi alla comunità, micro-imprendimenti, ecc.) e quindi non sotto forma di diritto formale-universale precostituito e destinato a una certa categoria di soggetti. Come ogni governance, dunque, anche quella kirchnerista funziona attraverso la mobilitazione soggettiva, l’invito a una co-partecipazione attiva alla gestione del sociale, la messa al lavoro delle capacità e del comune. Si tratta di un aspetto che non può comunque farci dimenticare il suo lato oscuro: il ricorso ai “punteros” e quindi alla gestione e al controllo territoriale del territorio.
4. Ora però mi interessa rimarcare che l’enorme produttività politica del kirchnerismo non è dipesa soltanto dall’adozione di queste politiche come punti fermi di un semplice, freddo ed efficiente nuovo “macchinario politico di gestione”. Dal mio punto di vista, risulta limitante considerare il kirchnerismo come una sorta di vuoto “soggetto di potere”, come la mera materializzazione del passaggio a uno stato più di tipo “tecnico-amministrativo” che non “rappresentativo”. Condividiamo dunque a metà la tesi esposta da uno dei tentativi più suggestivi di comprensione del kirchnerismo: El Estado Posnacional. Mas allà di Kirchnerismo y Antikirchnerismo (2011) di Pablo Hupert. Ci sembra che l’interessante analisi di Hupert sullo “stato postnazionale kirchnerista” finisca per sottovalutare il fatto che il kirchnerismo è andato via via conquistando buona parte della propria forza dalla sua progressiva e sapiente trasformazione in qualcosa che potremmo chiamare, sulla scia di Raymond Williams, una formidabile “struttura di sentimento”. In altre parole, crediamo che buona parte della produttività politica del kirchnerismo stia proprio nella sua capacità di mobilitare, riattivare e rilegittimare costantemente memorie, passioni e affetti, legati alle lotte di emancipazione del passato, prossimo e lontano, che da tempo cercavano espressione. In termini benjaminiani, si può dire che il kirchnerismo abbia fondato buona parte della sua attuale forza politica ponendosi in perfetta linea di continuità con i vinti di un dramma di emancipazione nazionale-continentale rimasto ancora irrisolto, ovvero nel richiamare a combattere le sue lotte anche quei morti (la generazione degli anni settanta, i desaparecidos, i caudillos, i gauchos, gli indigeni, ecc.) che finora non avevano trovato sepoltura, che navigavano nell’oblio sin dal 1976 e che erano stati ulteriormente annichiliti – insieme al loro progetto emancipatore – durante la miseria culturale degli anni del neoliberismo duro e puro. In questo senso, dobbiamo dire che la “struttura di sentimento” kirchnerista, in modi chiaramente ambivalenti e al di là dei suoi eccessi retorici sviluppisti, si nutre anche in gran parte di tutta la simbologia rivoluzionaria derivante da quella vecchia espressione sociale del comune che furono le forze contro-moderne radicali delle lotte di liberazione nazionale. Per rendersene conto, basta guardare alla “Galeria de los patriotas latinoamericanos” allestita dal kirchnerismo nella Casa Roasada per le celebrazioni del Bicentenenario dell’Indipendenza argentina: Tupaj Qatari, Bolivar, Jose Martí, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Che Guevara, Haya de la Torre, Artigas, Torrijos, Evita. In questo senso, il kirchnerismo come evento, come discontinuità, come ritorno e memoria dei morti delle lotte anticoloniali e antimperialiste del passato, ha indubbiamente qualcosa di postcoloniale. Poiché con questi morti ritorna anche quella linea coloniale del colore che sin dalla conquista dell’America ha dato forma alla composizione di classe sia del capitalismo continentale che di quello nazionale.
Per questo, anche se ad alcuni intellettuali argentini sono sembrati gesti facili o comunque tipici di un certo opportunismo politico del tutto amorale (vedi Martín Caparrós, Tomas Abraham ecc.), la famosa enunciazione di Nestor Kirchner “appartengo a una generazione decimata”, così come la rimozione del quadro di Videla dal “Colegio Militar di Campo de Mayo”, ordinata dallo stesso ex-presidente, costituiscono momenti essenziali e fondativi di un mutamento davvero importante nell’egemonia politico-discorsiva del paese. Il risultato di questo mutamento è stato entusiasmante da qualunque prospettiva lo si voglia guardare: ha dato luogo non soltanto alla riapertura dei processi contro torturatori e responsabili del genocidio, ma anche alla rivendicazione e riabilitazione delle lotte e dei progetti emancipatori delle vittime. Questo rovesciamento è riuscito a innervare un processo ricchissimo di revisione di tutta la storia nazionale che non solo ha incorporato alla memoria pubblica i desaparecidos non più come “vittime” della violenza incomprensibile di un ceto militare fuori controllo bensì come militanti politici impegnati in un progetto comune di liberazione nazionale e giustizia sociale, ma ha anche riconosciuto l’esistenza del “terrorismo di stato” come un’opzione sempre latente per le oligarchie nazionali. Chiaramente, si tratta di un processo che non è stato provocato direttamente dal gesto di Kirchner, ma dalle lotte precedenti dei movimenti per i DDHH e di altri settori popolari; tuttavia, è stato grazie al kirchnerismo se esso è riuscito ad emergere come elemento trainante di ciò che lo stesso kirchnerismo chiama la “politica dei diritti e dell’inclusione” post-2001. Da questo punto di vista, il conflitto con il campo e con il gruppo mediatico Clarín, così come la partecipazione moltitudinaria ai festeggiamenti del Bicentenario dell’indipendenza e le migliaia di giovani accorsi a Plaza de Mayo il giorno della morte di Kirchner (moltissimi di loro non inquadrati affatto all’interno di organizzazioni e movimenti “governativi”), appaiono piuttosto emblematici non tanto della forza (in senso astratto o semplicemente “manipolatorio”) della “struttura di sentimento kirchnerista” quanto della sua capacità di divenire un potente e produttivo “dispositivo biopolitico”. In sintesi, non recuperando il kirchnerismo come evento si rischia di deprivare di parte della sua potenza soggettiva anche alla ribellione popolare del 2001. É quanto ci ricorda il filosofo argentino marxista, e non certo kirchnerista, Leon Rozitchner, in un passo divenuto oramai celebre e che vale la pena di riportare almeno in parte:
Néstor Kirchner non ha fatto, certo, la rivoluzione economica tanto desiderata dalla sinistra, ma ha inaugurato, niente di meno, che una nuova genealogia nella storia popolare argentina: “Somos los hijos de las Madres y de las Abuelas de Plaza de Mayo”, ci ha detto aprendo le braccia a una fraternità perduta. É stato capace di rinverdire uno spazio politico che, come si sa, gli uomini dobbiamo alle madri, almeno a quelle della prima infanzia, senza le quali non vi sarebbe alcun desiderio di felicità. Venendo dall’orrore che gli assassini avevano marchiato sul corpo di ogni argentino, Kirchner ha dato luogo a una Giustizia che non veniva soltanto dal diritto: veniva invece da “quell’altro diritto” che è un ordine precedente alla legge che la violenza sostiene, ingenerato dal corpo amorevoli delle Madri, non certo dal corpo dello stato e dal Padre Terribile. Da quel momento in poi, è questa la nostra nuova ascendenza politica.
5. Ma è chiaro che riconoscere la forza di questo dispositivo non significa dimenticare i suoi limiti. La politica riparatoria dei DDHH non si è mai tradotta pienamente in una vera politica inclusiva dei diritti sociali: i casi di “grilletto facile” da parte delle forze repressive nei barrios non sono affatto scomparsi; diversi movimenti contadini e comunità indigene dell’interno del paese, in lotta per la conservazione o riconquista delle proprie terre di fronte al processo di espansione sojera e dell’industria mineraria, hanno dovuto subire diversi tipi di violenze, soprusi e anche omicidi; precarizzazione e flessibilità riguardano segmenti piuttosto considerevoli della forza lavoro complessiva; malgrado un ritmo di crescita annua dell’8% negli ultimi cinque anni, di un’importante riduzione della povertà e della disoccupazione, una parte consistente di quella popolazione espulsa dalla cittadinanza durante il venticinquennio neoliberista vive ancora in una situazione di “marginalità”; e infine, il governo (non attuando alcuna nazionalizzazione in materia) non ha mai risolto il problema della “sovranità energetica” (ereditato dalle privatizzazioni nel settore operate dal neoliberismo precedente) mentre, fatto inedito nell’Argentina (el granero del mundo), il paese sta cominciando a mostrare problemi di tenuta nella “sovranità alimentare” (a causa dell’espansione della soia come monocoltura).
Rischiamo di dire banalità, dunque, se ricordiamo qualcosa di ovvio: per quanto “progressiste” possano apparire le conquiste o politiche della “struttura di sentimento kirchnerista” poco hanno a che vedere con il programma tipico di quell’immaginario nazional-popolare rivoluzionario con cui condisce buona parte dei propri discorsi. Come abbiamo anticipato, il kirchnerismo non si è mai auto-rappresentato come figlio dei movimenti del 2001. Preferisce invece retrodatare il proprio anno zero al 25 Maggio del 1973: il giorno dell’assunzione del governo di Héctor Cámpora (ovvero del governo della sinistra peronista durato soltanto 49 giorni). Nelle proprie cerimonie di insediamento, tanto Néstor quanto più recentemente Cristina, hanno ricordato quel giorno di Maggio in cui erano in piazza come tante altre migliaia giovani militanti speranzosi in un mutamento radicale nel paese all’insegna della giustizia sociale. Si può dire che la complessa e contraddittoria catena di significazione kirchnerista (sviluppismo + frontismo popolare + autonomia nazionale) abbia in questo momento storico “che non fu” il suo “grado zero”. Ancora una volta, si tratta di un’operazione di memoria che si presenta come una potente e mobilitante “struttura di sentimento”, soprattutto per coloro che fecero parte della ex-sinistra peronista, ovvero del settore del peronismo più massacrato (e non solo in senso metaforico) nei trent’anni che precedettero l’elezione di Kirchner nel 2003. L’operazione discorsiva kirchnerista ha ridato senso, dignità e collocazione storica al progetto di tutta quella generazione di militanti peronisti che furono messi a tacere prima con il terrore e la violenza (perpetrati dalla macabra alleanza tra la destra sindacale del partito e gli apparati repressivi dello stato), poi con la svolta neoliberista di Menem. Anche qui il kirchnerismo mostra il suo vigore, la sua produttività politica, combattendo insieme ai “morti”.
Tuttavia, malgrado gli eccessi dell’immaginario “sviluppista” e “sovranista” della retorica K (l’enfasi costante sul trinomio sviluppo+industria+tecnologia) risulta piuttosto complicato definire il modello kirchnerista come mero “neo-sviluppismo inclusivo” o come qualcosa di simile al vecchio modello di sostituzione delle importazioni. Al di là della retorica “sovranista” dell’immaginario K, negli otto anni di Kirchnerismo non vi è stata alcuna nazionalizzazione nei settori chiave dell’economia o dei servizi pubblici essenziali: né in nome del vecchio “pubblico” né in nome dei “beni comuni”. Anzi, in alcuni casi lo sviluppo della sojizacion del territorio e dell’industria mineraria nel centro-nord del paese sta dando ancora luogo a violenti processi di “accumulazione originaria” e di squilibri ambientali (inquinamento della falde acquifere, delle terre coltivabili, ecc.), ovvero all’espulsione di comunità indigene e contadine dalle proprie terre. Le rendite derivanti dal petrolio, dalla pesca, dai servizi pubblici e dalle telecomunicazioni restano ancora in mano a monopoli privati e stranieri. In questo senso, il notevole aumento degli investimenti statali in università e ricerca (che comunque non ha eliminato il problema dell’estenso precariato universitario), in scienza e tecnologia, così come la riattivazione dell’apparato industriale locale, legata più alle politiche di delocalizzazione industriale della nuova divisione internazionale del lavoro, che non a una politica “sovranista” da parte dello stato, rendono difficile l’appellativo di sviluppista allo stato kirchnerista.
Inoltre, lo stato sviluppista presupponeva un’omogeneità sociale e politica della cittadinanza che non solo in Argentina non esiste di più da tempo, ma che nemmeno il kirchnerismo cerca di incentivare attraverso le sue politiche (produttive e sociali) chiaramente “differenziali” e “post-rappresentative” (basate sulla delega di gestione a terzi, sulla contrattazione diretta con i movimenti, sulla controprestazione come condizione). È chiaro ormai a tutti (e anche al kirchnerismo, se guardiamo al suo modo di governare) che l’omogeneità sociale e politica non è più un dato di fatto e tanto meno un obiettivo politico perseguibile: l’eterogeneità sociale (prodotta sia dai processi di gerarchizzazione legati alla frammentazione del lavoro, sia dalla proliferazione di singolarità e differenze alla base dell’economia biopolitica capitalista) appare sempre di più come una componente costitutiva anche della società argentina. Mi sembra lecito aggiungere che se il kirchnerismo non è mai caduto in una reale tentazione sviluppista-sovranista, nonostante la continua riesumazione dell’apparato discorsivo settentista improntato alla logica della liberazione nazionale, ciò è accaduto per tre motivi: a) perché vi è grande consapevolezza del fatto che gli attuali notevoli surplus della bilancia commerciale argentina dipendono puramente ed esclusivamente dalla transnazionalizzazione del proprio apparato produttivo; b) perché uno degli obiettivi di lungo termine della politica kirchnerista è quello di diversificare davvero il tessuto produttivo locale (di renderlo meno soiadipendente), ovvero di rafforzare una sua trasformazione (malgrado l’immaginario sviluppista-industrialista di vecchio stampo) in senso hi-tech o immateriale. È all’interno di questa prospettiva che deve essere anche inquadrato l’aumento progressivo degli investimenti in scienza, ricerca, tecnologia, saperi, nell’estensione della rete, nella politica del rimpatrio dei “cervelli”, nella distribuzione massiva di net-book agli studenti delle scuole medie superiori (vedi il programma “Conectar Igualdad”) ecc. E se questo investimento nell’economia immateriale – nel capitalismo cognitivo – fa parte del programma kirchnerista si capisce allora perché il governo stia cercando di favorire in tutti i modi l’accesso “locale” al flusso globale di saperi, informazioni, linguaggi ecc. e di mantenere come principio irrinunciabile l’istruzione universitaria pubblica e gratuita; c) perché il kirchnerismo, nonostante il ricorso ai “punteros” e quindi alla vecchia politica clientelare di controllo e gestione del territorio, sa che buona parte della propria forza politica ed economica dipende anche dalla “produttività”, dalla messa al lavoro, delle soggettività, dei saperi, delle reti sociali ed economiche, così come dell’ottimo livello di insediamento territoriale di movimenti, associazioni e altre sfere appartenenti all’attivismo sociale e culturale.
In sintesi, tutto questo per dire che all’implosione dello stato neoliberale degli anni novanta non è seguita una restaurazione del vecchio Stato-nazione moderno (come afferma invece in continuazione l’apparato discorsivo sviluppista-settentista kirchnerista). Ciò che è seguito è qualcosa di più ibrido e complesso, che noi abbiamo proposto di chiamare “governance post-neoliberale”. Si può dire tuttavia che l’appello del kirchnerismo all’immaginario nazional-popolare-setentista trovi la sua unica giustificazione (e forse la più importante dal punto di vista della “struttura del sentire”) in una sorta di “rivendicazione identitaria”: collocandosi dalla parte del progetto dei “vinti” il kirchnerismo cerca di costruire la sua diversità rispetto al neoliberismo precedente; il suo rappresentare comunque, malgrado i molti limiti e contraddizioni, un “mutamento di segno” nella più recente storia politica argentina. Un mutamento rappresentato non certo dalla ripresa reale del programma politico del vecchio progetto di liberazione nazionale, ma dal ritorno a un sistema fondato in qualche modo sulla “redistribuzione” della ricchezza sociale e materiale e quindi sull’estensione dei diritti attraverso “politiche sociali di inclusione”. Istituendo questa precisa linea di continuità con il passato, il kirchnerismo si pone storicamente come un altro dei governi dalla parte del pueblo, o meglio come l’effetto di una nuova ricostituzione di quel patto “politica-popolazione” distrutto dal neoliberismo. Diciamolo in altre parole: senza l’attivazione di questa “politica della memoria”, senza questa “carica affettiva e passionale” di cui investe il proprio progetto politico, il kirchnerismo non potrebbe autorappresentarsi come emblema del “ritorno della politica” di fronte alla mera “amministrazione” tecnico-monetarista. Anche se si tratta di un’enunciazione da prendere con le molle, come abbiamo cercato di mostrare, non andrebbe comunque sottovalutata: soprattutto poiché sembra essersi sedimentata nel profondo della società argentina (e anche tra gli anti-kirchneristi).
6. È all’interno di questo panorama che buona parte dell’intellighenzia locale progressista ha accolto con favore le teorie di Ernesto Laclau secondo cui il kirchnerismo andrebbe considerato come un altro dei sintomi del ritorno egemonico del populismo in America Latina. L’impressione è che ciò sia avvenuto più grazie all’appeal che il vecchio “populismo” progressista conserva ancora nelle “strutture di sentimento” della società argentina (in particolare rispetto alla “nostalgia” del progetto peronista di emancipazione nazionale), che non a un reale coinvolgimento con la sua prospettiva.
Non è questa la sede per tentare un confronto critico aperto con la proposta di Laclau, ma vi è qualcosa che mi preme dire per evitare fraintendimenti: il suo “populismo”, alla fine dei conti, presenta un legame piuttosto esile con i vecchi populismi latinoamericani (Vargas, Perón, Cárdenas, Velazco Alvarado, Torrijos ecc.). Questo presunto legame di parentela si riduce infatti a un unico aspetto: alla presunta volontà dei populismi contemporanei di rappresentare e di riconoscere, attraverso forme, discorsi e metodi non direttamente riconducibili ai meccanismi procedurali tipici della democrazia formale, tutti quei settori popolari rimasti esclusi dalla cittadinanza dal normale sviluppo del capitalismo neoliberista degli anni scorsi e dalla sua specifica forma parlamentare. Cosi come i vecchi populismi avevano cercato di riportare entro i confini della cittadinanza, in nome di un’entità plebea, nazionale e movimentista, tutti quei segmenti sociali e culturali stigmatizzati o esclusi dal capitalismo liberal-coloniale e dal discorso liberal-democratico delle élite bianche e creole dominanti, i nuovi populismi sarebbero emersi per Laclau a partire da domande popolari rimaste insoddisfatte durante l’egemonia del neoliberismo. È proprio in virtù di questo suo essenziale tratto costituente che l’interpellazione kirchnerista, secondo Laclau, è venuta a configurarsi come una nuova forma di populismo: in quanto si propone alla società argentina come un nuovo “catalizzatore” (come una riattualizzazione) del vecchio soggetto sovrano “Pueblo”.
Attenzione però, almeno nelle intenzioni di Laclau, questo nuovo “pueblo” rappresentato dal significante kirchnerismo non dovrebbe essere interpretato come il vecchio soggetto sovrano (essenzialista) della tradizione giacobina. Il kirchnerismo, in quanto significante del nuovo populismo, non sta a significare la riduzione dell’eterogeneità sociale nell’Uno della vecchia nazione-popolo. Anzi, per Laclau, il suo divenire “blocco egemonico” sta soprattutto nell’essersi saputo configurare come “catena di equivalenze”: come connessione e articolazione di tutte le singole istanze popolari o subalterne rimaste insoddisfatte nel periodo precedente. Il pueblo del kirchnerismo, dunque, non esiste come un ente omogeneo e già dato in partenza, non ha quindi alcun fondamento storico o ragione intrinseca, ma viene a costituirsi proprio a partire dall’articolazione in una “catena di equivalenze” di ogni singola istanza o lotta popolare. Si tratta di un pueblo che può emergere unicamente attraverso l’esaltazione (e non certo la sussunzione) della sua eterogeneità costitutiva, e che dipende dalla volontà politica di una delle istanze popolari di divenire “significante vuoto” del blocco antagonista-popolare, ovvero di condensare – senza sussumere – ogni domanda popolare nel suo nome.
Questa costruzione del popolo comporta due importanti premesse, dense di conseguenze politiche: a) ogni singola istanza articolata nella catena riconosce nel kirchnerismo il nome anche della sua specifica domanda; b) senza la partecipazione a questa “catena di equivalenze”, alla conformazione di un blocco egemonico di potere (in questo caso del kirchnerismo), ogni singola istanza o domanda “progressista” resterebbe, per ricorrere a una metafora lacaniana, al di qua dello specchio, ovvero al di sotto della sfera politica oppure al di là degli interessi del “pueblo”, oggi rappresentati in Argentina dal kirchnerismo. Il populismo, dunque, non è altro che la semplice costruzione – articolazione – del politico (dell’antagonismo sociale in nome degli esclusi); e il pueblo di questo populismo altro non sarà che l’atto di nominare ciò che prima non aveva nome.
A noi pare che definire il kirchnerismo secondo questa accezione del populismo risulti piuttosto equivoco. Non solo perché il kirchnerismo, come abbiamo visto, ha poco a che spartire con i populismi latino-americani tradizionali, ma anche perché lo stesso populismo di Laclau sembra andare in tutt’altra direzione rispetto ai populismi del passato. Chiaramente, non si tratta qui di rivalutare in modo semplicistico e anacronistico le esperienze populiste del passato, ma di capire meglio cosa nasconda ogni “nome”. Dal mio punto di vista, il populismo di Laclau si presenta più come una legittimazione dell’attuale “governance post-neoliberista kirchnerista” che non come un’alternativa davvero antagonista al capitalismo globale (come lo furono ai loro tempi, pur se in modo contraddittorio, i vecchi populismi latinoamericani). Nella critica all’autonomia di ogni singola istanza popolare, ovvero nell’insistere sulla necessità della costituzione di una “catena di equivalenze” o di un “blocco egemonico” come unico modo per renderle politicamente intelligibili ed efficaci, Laclau non fa che neutralizzare a priori l’esistenza di qualunque tipo di potere sociale immanente incentrato sul comune. Ristabilendo il “pueblo” come potere comunque trascendente – nonostante la sua eterogeneità costitutiva – il populismo di Laclau si presenta come un altro nemico della (potenza della) moltitudine e quindi come un mero dispositivo di cattura della sua produttività. In sintesi, il populismo di Laclau finisce per assolutizzare – considerandola intrascendibile – la governabilità dell’attuale capitalismo kirchnerista; un capitalismo, lo ripetiamo, caratterizzato da un inedito doppio volto: mentre il suo cuore pulsante resta un modello economico estrattivista che trae la sua forza dall’intreccio alla logica transnazionale e finanziaria dei flussi del capitale globale neoliberista, la sua gestione sociale e politica interna è andata affermandosi sempre di più su un profilo che abbiamo deciso di chiamare “governance post-neoliberale”. In questo senso, l’alternativa neopopulista sembra rappresentare nulla di più che una regolazione contingente – nella speranza che la crisi globale non tocchi nelle sua fondamenta il nuovo modello latinoamericano – degli effetti socialmente più deleteri del neoliberismo. E si capisce a questo punto anche perché essa abbia trovato terreno fertile nella “lettura a contropelo” del 2001 promossa dal kirchnerismo.
7. Infine, il kirchnerismo, come governance post-neoliberale, può rientrare in quell’estremismo di centro che secondo Etienne Balibar sta unificando lo spettro politico istituzionale un po’dappertutto? Di per sé, non ci appare sconsiderato leggere il kirchnerismo – o la governance kirchnerista – come il consolidamento di un “ultra-centro” nella società argentina. Chiaramente, il kirchnerismo può essere interpretato – ed è questo che noi abbiamo proposto – come una delle tante articolazioni locali dell’Impero e della sua divisione internazionale del lavoro, ma ridurlo a una semplice versione locale dell’ultra-centro o dell’estremismo di centro globale può comportare qualche fraintendimento. Innanzitutto, si rischia di vedere nel kirchnerismo semplicemente “más de lo mismo”, ovvero un progetto di mera restaurazione della vecchia politica (punteros, apparatismo del PJ, clientelismo, populismo ecc.). Abbiamo cercato di mostrare, ma anche gli articoli di Altamira e soprattutto quello del Colectivo Situaciones espongono in modo molto efficace le novità della congiuntura K, che il kirchnerismo è qualcosa di più complesso. Se partiamo dal presupposto che il 2001 ha costituito un punto di non ritorno nello scenario politico locale, è chiaro che anche il kirchnerismo (con tutte le sue contraddizioni e ambivalenze) rappresenta qualcosa di radicalmente diverso rispetto alle formazioni politiche di potere precedenti.
Il secondo problema è che l’ultra-centro globale di cui parla Balibar (e in questo egli pecca forse di eurocentrismo) appare intrinsecamente legato ai dogmi politici ed economici del neoliberismo del consenso di Washington e di altre istanze del potere globale imperiale come gli accordi commerciali sanciti dal WTO ecc.; si tratta di un insieme di concezioni politiche ed economiche che tanto per le destre quanto per le sinistre istituzionali europee appaiono oramai come “cose”, per usare il linguaggio del vecchio Marx, anziché come il frutto di rapporti specifici di potere e quindi di decisioni meramente “politiche”. Sappiamo che alcune delle misure adottate dal kirchnerismo vanno in tutt’altra direzione rispetto a questi dogmi, come per esempio, a) togliere l’autonomia alla Banca Centrale e porla sotto il controllo diretto, e al servizio delle politiche sociali ed economiche di sviluppo sociale, del governo; b) favorire accordi bilaterali e regionali bypassando le regole multilaterali degli organismi internazionali al servizio dell’Impero; c) negoziazione con altri partner regionali in favore di transazioni economiche in divise locali anziché in dollari o in euro; d) misure e incentivi fiscali finalizzati a favorire la sostituzione delle importazioni di alcuni prodotti industriali (e non solo di basso valore aggiunto); e) il ripristino del salario minimo per legge e della contrattazione collettiva come base della politica dei redditi; f) aumento quantitativo e qualitativo delle politiche sociali destinate a incrementare la produttività dell’economia “antropogenetica” (di produzione dell’uomo attraverso l’uomo), benché spesso si facciano anche in nome dell’immaginario fordista-welfarista, ovvero di aiuti agli esclusi, ai poveri ecc.; g) aumento della spesa pubblica nel settore dell’istruzione; h) estensione del sistema pensionistico alle casalinghe; i) misure destinate al controllo dei flussi di capitale a breve termine, ovvero a sfondo chiaramente speculativo; j) approvazione della legge che fissa lo statuto lavorale dei braccianti (dei peones de campo); k) approvazione della legge che fissa dei limiti all’acquisto di terre da parte di capitali stranieri. Anche se è bene ripetere che l’adozione di tali misure non va nelle direzione di una ricostituzione del vecchio sistema keynesiano-welfarista imperniato attorno all’autonomia dello stato-nazione e alla figura del cittadino in quanto soggetto astratto, ovvero che si tratta di politiche adottate per compensare l’insostenibilità a lungo termine di un modello economico che rimane nelle sue strutture principali del tutto dipendente dal capitale finanziario globale, abbiamo a che fare con misure ben distanti da ciò che qualunque esponente dell’ultra-centro europeo o globale può immaginare come scelte politiche possibili.
8. In conclusione, due domande sorgono spontanee: quanto può durare ancora il governo kirchnerista della crisi? Che tipo di lotte e di agenda politica antagonista può mettere in discussione la sua egemonia? Chiaramente, queste due domande possono essere sintetizzate in una sola: come uscire da quello che il Colectivo Situaciones ha denominato in passato l’impasse dei movimenti? Rispetto a quest’ultima domanda, mi pare che vengano indicazioni interessanti sia dall’articolo di Altamira che da quello del C. Situaciones. Si tratta di capire cosa “splenda” dentro le ombre del kirchnerismo, così ben descritte dai due articoli. Vorrei aggiungere soltanto che, malgrado le apparenze, la schiacciante vittoria elettorale e l’enorme popolarità della figura di Cristina, la governance kirchnerista resta piuttosto fragile. Fragile è la congiuntura economica internazionale da cui deriva il surplus economico alla base delle sue politiche sociali; fragile, e insostenibile a lungo termine, è il modello economico estrattivista su cui essa comunque si fonda, come mostrano le lotte delle comunità indigene e contadine e la violenza repressiva che hanno dovuto affrontare; fragile è il suo rapporto con la CGT (il sindacato peronista maggioritario) e con l’apparato del PJ (partito Justicialista peronista) che, sebbene abbia garantito buona parte della sua governabilità, non ha mai digerito fino in fondo i Kirchner e non aspetta altro che regolare i conti con Cristina (la recente rottura con il segretario della CGT Moyano è indicativa della fragilità di questo rapporto); fragile resta la sua “lettura a contropelo” del 2001, poiché ha sempre bisogno di ulteriori concessioni ai movimenti “filo-governativi” (benché queste concessioni siano di diverso tipo e vadano in diverse direzioni); fragile resta la posizione di forza raggiunta da CFK all’interno dell’oggi ampio consenso kirchnerista. Si tratta di qualcosa che può divenire più chiaro fra qualche mese, quando si scateneranno le lotte intestine al PJ per la successione alla presidenta. In sintesi, la governance kirchnerista appare in prospettiva tutt’altro che solida. É difficile fare delle previsioni, ma molto presto il governo, data la sua connotazione e sostegno popolare, potrebbe trovarsi nella posizione di dover operare delle scelte meno concilianti con i reali blocchi di potere e tornare così verso il frontismo e la trasversalità degli inizi. Chiaramente, e vista la costituzione materiale della governance K, molto dipenderà anche da ciò che i movimenti stessi, interni ed esterni al kirchnerismo, sapranno generare in questa nuova fase. Crediamo dunque che l’attuale consenso kirchnerista sia destinato a restringersi: la crisi del capitalismo finanziario globale, da una parte, e le contraddizioni interne allo stesso modello kirchnerista di governance, dall’altra, potrebbero riaprire in tempi relativamente brevi spazi che oggi appaiono se non proprio chiusi, almeno marginali. Ciò nondimeno vorrei chiudere riaffermando che il kirchnerismo, come evento, come discontinuità storica sancita dall’irruzione dei morti, resta un fenomeno politico e culturale importante nella storia argentina più recente. Come sempre la memoria parla al futuro, e in questo senso i limiti stessi posti dal kirchnerismo in quanto formazione di potere a ciò che con esso ritorna possono costituirsi a breve come i germi del suo stesso superamento.