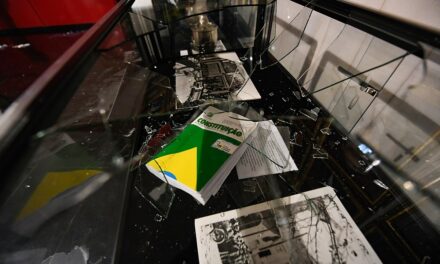di MAURA BRIGHENTI e SANDRO MEZZADRA.1
16/03/2012
1. Ritorni?
Ernesto Laclau lascia l’Argentina negli anni Settanta per farvi ritorno, come una delle principali figure intellettuali di riferimento, in un contesto che appare radicalmente rinnovato tanto nel suo Paese d’origine quanto, più in generale, in America Latina: l’emergenza di nuovi governi “progressisti” negli ultimi dieci anni sembra in particolare aprire prospettive del tutto inedite in risposta alla crisi radicale del modello economico neoliberale. Del resto, è lo stesso Laclau che certo non occulta il suo appassionato sostegno all’esperienza del “kirchnerismo” in Argentina, come “alternativa al sistema tradizionale dei partiti” e “progetto coerente di cambiamento”2. Biografia e storia sembrano curiosamente procedere di pari passo: il ritorno di Laclau e il ritorno di quello che si potrebbe chiamare, in una prospettiva paradossale ma non distante da quella di Laclau, il peronismo con Perón.
“Perón vinse il duello coi successivi regimi anti-peronisti” perché, scrive Laclau, “questi non riuscirono a integrare i gruppi neo-peronisti – quelli del ‘peronismo senza Perón’ – in un sistema politico allargato, mentre la domanda del suo ritorno in Argentina divenne un significante vuoto, capace di unificare un campo popolare in continua espansione”3. Indubbiamente il kirchnerismo ha mostrato e continua a mostrare, con il trionfo elettorale dello scorso ottobre, la capacità di parlare a un insieme di figure e forze sociali al tempo stesso eterogenee e politicamente determinanti, assegnando un corpo a quel “significante vuoto” (di qui la formula “un peronismo con Perón”). Ci domandiamo però se tale esperienza, e più in generale le nuove esperienze politiche latinoamericane (tanto sul versante dei governi “progressisti” quanto su quello dei movimenti), possano essere davvero intese come un “ritorno” della “ragione populista”. Da questo punto di vista, più che dedicarci a una lettura critica dell’apparato teorico di Laclau, su cui del resto vertono altri saggi all’interno di questo volume, ci interessa provare a delineare, nelle pagine che seguono, alcuni dei tratti salienti di quello che sembra consolidarsi come un modello latinoamericano di “governance post-neoliberale”, nonché riflettere su alcuni dei problemi teorico-politici fondamentali che quel modello propone4.
Una premessa ci sembra tuttavia necessaria. Se trasliamo la raffinata elaborazione filosofica di Laclau sul terreno affatto materiale della politica, l’immagine stessa del “ritorno” ci appare problematica, così come quella del soggetto – il “popolo” – che di questo ritorno pare essere, per ampie sezioni dello stesso dibattito latinoamericano, l’indiscusso protagonista. Come è noto, Laclau non pensa certo il popolo come una categoria già data, né tantomeno omogenea, per porre invece al centro della sua analisi, fin dai suoi primi scritti, l’eterogeneità sociale, l’impossibilità della sua riduzione e la necessità invece di pensarne un’articolazione egemonica. Che cos’è, dunque, che può trasformare la “costitutiva eterogeneità del sociale” nella categoria politica di “popolo”? Il popolo – ci dice Laclau – è il prodotto di “un atto di istituzione”, “il risultato di un’aggregazione di domande sociali” che possono essere portate “a unità solo attraverso articolazioni politiche equivalenziali”. Quella che Laclau definisce l’“autonomizzazione del momento equivalenziale rispetto agli anelli della catena” costituisce per lui il momento politicamente decisivo. “Il momento equivalenziale”, leggiamo in La ragione populista, non può essere comunque subordinato alle domande, poiché ha il compito cruciale di renderne possibile la pluralità stessa5. Siamo qui chiaramente di fronte alla riproposizione di una movenza classica della teoria politica moderna: la produzione dell’unità politica – la produzione del “popolo” – appare possibile soltanto attraverso l’azione di un soggetto – lo Stato o il partito – collocato in una posizione qualitativamente altra rispetto all’eterogeneità costitutiva del sociale6. Il ritorno al popolo appare così un ritorno al fondamento stesso dello Stato moderno, alla sua “totalità sempre sfuggente” – e dunque fantasmatica7.
Se spostiamo però lo sguardo sulla “costitutiva eterogeneità sociale” che negli ultimi anni ha fatto la sua prepotente irruzione sulla scena politica in Argentina, Bolivia, Brasile, Ecuador, Venezuela, producendo la stessa condizione di possibilità delle nuove esperienze di governance post-neoliberale, il punto di vista cambia radicalmente. Nella potenza destituente di quei movimenti e di quelle insurrezioni, nel ¡que se vayan todos! riverberato nelle piazze di un intero continente – e la cui eco, pur depotenziata, è giunta fino a qui – è racchiusa l’impossibilità del ritorno. Come osserva efficacemente Miguel Mellino, al centro di quell’irruzione vi è la “questione della rappresentanza nella sua totalità”: “governare da qui in poi avrebbe significato fare quotidianamente i conti con il potere destituente della moltitudine, con un’irreversibile e oramai costitutiva eterogeneità sociale maturata (sia come soggettività sia come resistenza) nel lungo processo di neoliberalizzazione della società”8.
La potenza destituente dei movimenti sociali latinoamericani ha indubbiamente segnato l’impossibilità di un ritorno alle politiche neoliberali dell’austerity, degli aggiustamenti strutturali, della selvaggia accumulazione di rendita senza redistribuzione della ricchezza. Al tempo stesso, i lunghi anni di egemonia del modello neoliberale hanno tuttavia prodotto trasformazioni profondissime nei sistemi economici, sociali e politici, avviando sviluppi difficilmente riconducibili al modello dello Stato moderno e ai paradigmi concettuali che hanno avuto la propria origine al suo interno. Seguendo la rilettura di Foucault proposta da Wendy Brown, il neoliberalismo può essere infatti rappresentato come un nuovo paradigma fondato sulla generalizzazione dell’homo oeconomicus come “norma dell’umano”: un “progetto costruttivista”, dove i confini tra la sfera politica e la sfera economica si confondono, costringendoci a ripensare l’autonomia della prima e la sua identificazione con la statualità9. D’altra parte, i governi dei Kirchner, di Lula, di Morales e Chávez (per richiamare quattro esperienze particolarmente importanti, che analizzeremo come parte di una congiuntura unitaria, ponendo in secondo piano le grandi differenze che indubbiamente esistono tra di esse) sembrano iscrivere la propria azione all’interno dell’orizzonte inaugurato dalla doppia cesura determinata dalle politiche neoliberali e dalle rivolte contro di esse. A essere qui in questione è la crisi della figura dello “Stato dello sviluppo”, che ha caratterizzato un lungo tratto di storia all’interno del cosiddetto Terzo mondo, conoscendo un gran numero di varianti (tra democrazia e dittatura, socialismo e nazionalismo, tecnocrazia e populismo) e intrecciandosi in America Latina con i dibattiti sulla “dipendenza” e con la formulazione delle teorie, delle politiche e delle retoriche del desarrollismo 10.
Come vedremo, a garantire l’efficacia politica dell’esperienza latinoamericana di governance post-neoliberale è esattamente la sua radicale discontinuità, da molteplici punti di vista, con il modello nazional-sviluppista spesso retoricamente evocato dagli stessi governi “progressisti”. Abbiamo infatti a che fare con processi di governance pienamente inseriti all’interno dei circuiti finanziari globali, che fanno i conti con la continua transnazionalizzazione degli apparati produttivi dei singoli Paesi. E transnazionali sono spesso anche le economie informali messe a valore nei processi di accumulazione capitalistica, così come le forme organizzative e gli immaginari di quei soggetti – i movimenti indigeni – che dai margini delle società latinoamericane sono emersi al centro della scena politica, portando ad esempio all’approvazione di nuove carte costituzionali esplicitamente pluri-nazionali in Bolivia e in Ecuador11. Non meno importante è l’impegno dei nuovi governi nel consolidamento dell’integrazione continentale, attraverso la costituzione di Unasur, il Banco del Sur, gli accordi interregionali sulle infrastrutture e il fabbisogno energetico. È all’interno di questa cornice che si sono moltiplicati negli ultimi anni i tentativi di ripensare la scala continentale dei processi politici in atto, a partire da una riscoperta di testi classici, come Nuestra America di José Martí12.
Se si guarda alla realtà latinoamericana a partire dalla materialità complessa e contraddittoria delle esperienze di governance post-neoliberale, il riferimento di Laclau alla catena di equivalenze e al ritorno del popolo appare singolarmente “sfasato”. La sua valenza è essenzialmente simbolica, per quanto potenti siano i simboli mobilitati. Del resto è lo stesso Laclau a rivelarcelo nel momento in cui, durante un’intervista, sostiene la necessità di rendere possibile la rielezione presidenziale senza limiti di tempo: “è molto difficile dire quanto dovrebbe durare, direi per un intero periodo storico. […] Il punto non è che un presidente sia rieletto a vita, ma che possa candidarsi. Per esempio, nell’attuale periodo storico, senza Chávez il processo di riforma in Venezuela sarebbe impensabile […] Senza Evo Morales, il cambiamento in Bolivia è impensabile. In Argentina non siamo arrivati a una situazione in cui Kirchner è indispensabile, però se tutto ciò che rappresenta il kirchnerismo come configurazione politica scompare, scompariranno altresì molte possibilità di cambiamento”13. Un anno e mezzo dopo, sulla scorta del trionfo elettorale di Cristina Kirchner, Laclau torna a difendere la sua posizione: “in America Latina abbiamo sistemi presidenzialisti forti e i processi di cambiamento si cristallizzano intorno a certe figure, ragion per cui sostituirle crea uno squilibrio politico”14.
2. Critica e crisi dello sviluppo
Dagli anni Trenta agli anni Settanta del Novecento, l’America Latina ha vissuto la lunga stagione del desarrolismo, specifica variante – come già si è detto – della figura storica che viene definita come “Stato dello sviluppo”: in questione era il tentativo di individuare un mix di politiche di piano e di mercato che, all’interno di modelli anche molto diversi tra loro, avrebbero dovuto funzionare come ricetta miracolosa per uscire dalla dipendenza plurisecolare cui il colonialismo prima, e le oligarchie nazional-creole poi, avevano condannato l’intera regione. Dal Messico di Lázaro Cárdenas (1934-1940) al Brasile di Getúlio Vargas (1937-1945), dall’Argentina del primo governo di Juan Domingo Perón (1946-1952) fino alla Bolivia della rivoluzione del 1952, lo sviluppo è stato il criterio fondamentale di legittimazione dello Stato e al tempo stesso la chiave di un progetto di costruzione nazionale; ne sono derivati un insieme di misure economiche e sociali (di grande rilievo tanto per la crescita economica che hanno saputo determinare, quanto per l’estensione della cittadinanza sociale che hanno pur contraddittoriamente prodotto attraverso la legislazione sul lavoro e il ruolo di primo piano assunto dalle grandi organizzazioni sindacali) e una potente ideologia nazional-statale.
Riprendendo le analisi di Michel Foucault ed Edward Said, l’antropologo colombiano Arturo Escobar definisce con grande efficacia lo sviluppo come un “discorso storicamente prodotto”, una prospettiva che consentirebbe al tempo stesso di comprendere le ragioni per cui i paesi ex coloniali “cominciarono a considerarsi all’inizio del secondo dopoguerra sottosviluppati, in che modo ‘svilupparsi’ si trasformò per essi in un problema fondamentale e perché, da ultimo, essi si imbarcarono nell’impresa di ‘de-sottosvilupparsi’ sottomettendo le loro società a interventi sempre più sistematici, dettagliati e intensi”15. In questo senso, lo sviluppo può essere inteso secondo Escobar come un discorso “orientalista”: “nella misura in cui gli esperti politici occidentali cominciarono a vedere come un problema certe condizioni dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina fece la sua apparizione un nuovo campo di pensiero e di esperienza. […] Creata inizialmente negli Stati Uniti e in Europa occidentale, la strategia dello sviluppo si convertì in pochi anni in una potente forza all’interno dello stesso Terzo Mondo”16.
Se lo “sviluppo” come discorso inizia la sua parabola con la dottrina Truman e la fondazione delle Nazioni Unite, è pur vero che all’interno di quello che proprio in quegli anni cominciava a essere definito il “Terzo Mondo” esso ha funzionato a lungo come un terreno affatto materiale di scontro. In questione erano la ridefinizione complessiva del capitalismo come “sistema mondo” e il riposizionamento al suo interno delle ex colonie: lo “sviluppo” diventa qui la posta in gioco all’interno di un lungo ciclo storico, inaugurato in America Latina dalle spinte antimperialiste dei governi degli anni Trenta e Quaranta, con l’ondata di nazionalizzazioni17 e l’industrializzazione “per sostituzione delle importazioni” a fronte della depressione post ’29, e proseguito su scala globale con la costituzione del blocco dei non allineati, i cui momenti salienti furono la Conferenza di Bandung (1955), la nascita del G-77 (1964), la federazione dei paesi produttori di petrolio nell’Opec (1965), la Conferenza tricontinentale tenuta a L’Avana (1966) e la dichiarazione del New International Economic Order in seno all’Assemblea delle Nazioni Unite (1974)18. L’emergenza nel secondo dopoguerra del “Terzo Mondo” come spazio di inedite alleanze politiche è un antefatto importante del grande investimento che i nuovi governi “progressisti” latinoamericani effettuano nel consolidamento tanto di una nuova cornice politica regionale e sub-continentale quanto di un blocco “contro-egemonico” da costituire attraverso accordi con potenze emergenti come l’India, la Cina e il Sudafrica. Sullo sfondo, come ha più volte ricordato nei suoi ultimi scritti Giovanni Arrighi, c’è la prospettiva di una “nuova Bandung”, costruita su basi “essenzialmente economiche” – e dunque “molto più solide” di quelle “politico-ideologiche” della Bandung storica19.
Le dittature militari degli anni Settanta e Ottanta (che a partire dal colpo di Stato di Pinochet in Cile segnano una radicale discontinuità rispetto agli stessi governi militari degli anni precedenti) e le democrazie neoliberali degli anni Novanta determinano la fine della parabola desarrollista, mostrando tragicamente l’inadeguatezza del suo paradigma: “invece di far definitivamente decollare le economie latinoamericane lungo un sentiero di sviluppo ‘nazionale’ autonomo, gli altissimi tassi di crescita economica fanno esplodere il debito estero e la diseguaglianza sociale, ponendoli in una spirale infernale”20. La crisi del debito costringe molti paesi latinoamericani – coerentemente con quanto accadeva in altre aree del “Terzo Mondo” – a una radicale ristrutturazione e disarticolazione delle proprie economie per adempiere ai programmi di aggiustamento strutturale del FMI e della Banca mondiale. In pochi anni agli Stati non resta che “il ruolo di mendicante internazionale e polizia locale incaricata di disciplinare le classi pericolose” e “lo Stato produttore cede il passo al capitale straniero come locomotiva economica”21. Il sogno della crescita si converte così in un vero e proprio incubo, e in luogo del regno dell’abbondanza immaginato dai teorici e dai politici degli anni Cinquanta e Sessanta il discorso e la strategia dello sviluppo lasciano spazio a una realtà di segno opposto: “miseria e sottosviluppo di massa, sfruttamento e oppressione. La crisi del debito pubblico, la crescente povertà, la denutrizione e la violenza sono solo i sintomi più plateali del fallimento di cinquanta anni di sviluppo”22.
L’illusione del desarrollismo è stata quella di pensare la possibilità di uno sviluppo capitalistico autonomo su scala nazionale23, senza fare davvero i conti con il fatto che il capitalismo moderno nasce come sistema costitutivamente globale, caratterizzato fin dalla sua prima espansione da un vincolo profondo con il colonialismo. Il “peccato originale” del colonialismo si è riprodotto lungo l’intero arco storico della modernità latinoamericana, e conseguentemente la crescita ha continuato a generare dipendenza, l’accumulazione di ricchezza a produrre accumulazione di povertà24. È questo il punto di partenza della prospettiva “decoloniale”, attorno a cui negli ultimi anni si è raccolta una significativa rete di intellettuali tra l’America Latina e gli Stati Uniti25. La prospettiva decoloniale insiste sulla natura strutturale del rapporto tra la dominazione coloniale e il farsi mondo del capitalismo, definito da Aníbal Quijano attraverso la categoria di “colonialidad del poder”: fin da quando la modernità capitalistica si è prodotta – su una scala immediatamente globale – essa ha sempre contenuto dentro di sé il suo esterno, il suo altro, generando una complessità di rapporti sociali, resistenze, inclusioni ed esclusioni che permangono nel presente, e al cui interno la linea della razza e del colore ha giocato e continua a giocare un ruolo fondamentale. È per questo che, sostiene Quijano, la critica della teoria di una sequenza lineare e universalmente valida tra i modi di produzione, dell’immagine della transizione che costituiva il presupposto delle teorie desarrolliste, rimane come una delle principali questioni del dibattito contemporaneo. Se dal punto di vista dell’Occidente moderno, “reciprocità, schiavitù, servitù e produzione mercantile indipendente sono percepite come momenti di una sequenza storica precedente alla mercificazione della forza lavoro”, come “pre-capitale”, in America Latina essi non si pongono in un rapporto di lineare successione storica: “nessuna di esse fu una mera estensione di antiche forme pre-capitalistiche e nessuna fu incompatibile con il capitale”. Queste forme di organizzazione del lavoro “non solo agirono simultaneamente, ma furono articolate intorno all’asse del capitale e del mercato mondiale”: “insieme formarono un nuovo sistema: il capitalismo”. E solo in questo modo “il capitale diventa il modo di produzione dominante”26.
Per larga parte del Novecento, in evidente tensione con le dottrine desarrolliste, in America Latina continuano dunque a riprodursi, in forme nuove e originali, le fratture e le linee di esclusione ereditate dal colonialismo e perpetuate dalle oligarchie nazional-creole del diciannovesimo secolo. Se un’apertura progressista della cittadinanza politica e sociale ha indubbiamente avuto luogo, con l’emergere del lavoratore salariato come figura centrale a cui buona parte delle stesse politiche desarrolliste si sono rivolte27, ai margini della nuova cittadinanza del lavoro persiste sotto traccia un’“altra società”28, che si può accostare a quella che Partha Chatterjee ha definito – in riferimento all’India – la “società politica” dei subalterni29. Come vedremo, è quest’altra società – frammentata, oppressa e per lunghi secoli silenziata – a irrompere (insieme agli stessi cittadini-lavoratori espulsi dalla produzione industriale in seguito alla ristrutturazione neoliberale) al centro del nuovo spazio politico che le rivolte e i movimenti destituenti degli ultimi anni hanno irreversibilmente aperto. E il protagonismo dei soggetti che abitano quest’altra società figura tra le premesse e le condizioni di possibilità di una nuova governance post-neoliberale e “post-sviluppista”30.
3. Transizione come campo di battaglia
In una certa misura, la stagione inaugurata dei governi “progressisti” latinoamericani ha oscurato la straordinaria novità e il portato dirompente delle rivolte che ne hanno costituito la premessa. Fin dal momento del loro insediamento, ci troviamo davanti a un significativo scarto tra il terreno radicalmente conflittuale da cui essi hanno tratto origine e consenso e la diffusa tendenza a inserire le esperienze dei nuovi governi all’interno di una continuità storica con epoche precedenti, dai governi nazional-sviluppisti degli anni Trenta e Quaranta ai movimenti popolari e socialisti (tanto di massa quanto armati) degli anni Sessanta e Settanta31. Ciò risulta evidente tanto se si guarda alle auto-narrazioni attraverso cui i nuovi governi legittimano se stessi come protagonisti di un “ritorno della politica”, quanto se si prendono in esame le rappresentazioni, anche di segno politico opposto, che circolano al di fuori dell’America Latina. In un ampio saggio introduttivo a un recente numero monografico della rivista “South Atlantic Quarterly”, Alvaro Reyes nota ad esempio come gran parte delle interpretazioni del nuovo contesto latinoamericano diffuse negli Stati Uniti, di “destra” come di “sinistra”, muova da un equivoco di fondo: dalla tendenza, appunto, a pensare le esperienze politiche contemporanee nel segno di un ritorno, cogliendo in esse ora un “semplice momento del caos che sembra non cessare mai e che costantemente attanaglia ‘i nostri vicini del sud’” ora, “in modo più simpatetico ma non meno problematico”, un “revival della figura romantica del guerrigliero e della lotta per il ‘socialismo’”32. Non diversa è la situazione in Europa, dove il dibattito sui nuovi governi “progressisti” si è venuto svolgendo sul terreno ampiamente dissodato da una tradizione storiografica che ha per lo più delineato la storia politica latinoamericana come una continua oscillazione tra i due poli rappresentati da liberalismo e populismo.
Eppure le narrazioni e auto-narrazioni del “ritorno” poco o nulla hanno da offrire al tentativo di comprendere il modello di governance post-neoliberale che sta prendendo corpo negli ultimi anni in America Latina. Si tratta di un modello che – è bene chiarirlo – si sta affermando sulla base tanto di una rottura radicale con le precedenti forme di governo e statualità, quanto di pesanti eredità storiche: basti pensare, da questo secondo punto di vista, alla riproduzione in tutta la regione di un’economia di tipo “estrattivista” che ha le sue lontane origini nella dominazione coloniale33. E tuttavia, insistiamo, è l’elemento della rottura a funzionare da premessa e da punto di non ritorno per le nuove esperienze di governance. Dal momento in cui la potenza destituente di moltitudini straordinariamente eterogenee si è imposta al centro della scena politica in Brasile come in Argentina e in Messico, in Venezuela come in Bolivia e in Ecuador, “nulla in effetti è tornato a essere come prima”. Come osserva efficacemente Miguel Mellino, è mutata in primo luogo “l’egemonia discorsiva”: chi riproporrebbe oggi in America Latina “il tipico linguaggio imperiale/neoliberale degli anni Ottanta come chiave interpretativa del reale e dei suoi conflitti”? Ma cambiamenti significativi riguardano anche il “modello stesso di sviluppo sociale, culturale ed economico”. E soprattutto a mutare è “il rapporto tra governi e governati”34. È un punto cruciale: benché le retoriche governative, come quelle, pur tra loro differenti, dei Kirchner, di Chávez e di Morales, insistano sull’immagine di uno Stato forte – la cui “forza” deriverebbe appunto dalla capacità di includere al proprio interno l’insieme eterogeneo delle domande popolari (al contrario dei precedenti governi neoliberisti “venduti” all’imperialismo degli organismi internazionali) – la posta in gioco nelle insorgenze contro il neoliberalismo era – ed è – ben più alta35. All’interno di quei movimenti i concetti stessi di cittadinanza e rappresentanza, nonché la loro articolazione nella forma Stato moderna, sono stati messi radicalmente in discussione. I loro discorsi, le loro pratiche, le loro forme organizzative si pongono fin da principio come irriducibili all’immagine del popolo sovrano rappresentato dallo e nello Stato. È stata in particolare la sconnessione tra lavoro e cittadinanza, determinata proprio dalle politiche neoliberali, a costituire il terreno su cui si sono determinati e hanno agito i movimenti. Le forme della politica che emergono dalla crisi del neoliberalismo registrano questa circostanza e si dipanano a partire dall’obsolescenza della figura del cittadino-lavoratore e della sua progressiva inclusione nella forma Stato attorno a cui è stata teorizzata, nel secolo scorso, la cittadinanza democratica anche in America Latina. In questione non è certo la “fine del lavoro”, quanto piuttosto il tramonto di “un determinato statuto dell’impiego”, di “una determinata forma di relazione salariale”36 e, conseguentemente, anche di una determinata forma di organizzazione del lavoro e dei suoi soggetti.
Analizzando ad esempio l’esperienza boliviana, Alvaro García Linera mette in risalto come i quindici anni di egemonia neoliberale abbiano portato alla scomparsa dalla scena politica della Central Obrera Boliviana (COB), la potente organizzazione sindacale che fin dalla rivoluzione del 1952 “riassumeva in sé le caratteristiche strutturali del proletariato, della sua soggettività, della sua etica collettiva”. A emergere oggi, sulla traccia della sua dissoluzione, è una “forma nuova di proletarizzazione sociale ampia e diffusa”, priva tuttavia di “radicamento organizzativo, deterritorializzata”37. L’egemonia della COB – come organizzazione in grado di rappresentare il lavoro nel suo complesso – si fondava per Linera su una serie di elementi che non hanno resistito alla ristrutturazione economica neoliberale: la concentrazione della forza lavoro all’interno della nuova produzione di massa, un rapporto di lavoro tendenzialmente a tempo indeterminato, la presenza di “sistemi di fedeltà” all’interno dei centri industriali e minerari che consentivano “di accumulare forza organizzativa a partire dai luoghi di lavoro” e “la fusione dei diritti di cittadinanza con i diritti del lavoro a partire dal riconoscimento da parte dello Stato, fin dagli anni Quaranta, della legittimità dell’organizzazione sindacale”38.
Ma la crisi di questo modello di organizzazione del lavoro e di relazioni industriali, in cui si può facilmente riconoscere una variante di quello che viene definito “fordismo”, non è solo la crisi di un determinato modo di regolare i rapporti di produzione e i processi di accumulazione del capitale. Essa costringe piuttosto a ripensare lo sviluppo nel suo complesso, a partire dal nesso tra “crescita economica” e “integrazione sociale” che ha rappresentato il nucleo duro del desarrolismo. Guardando a quella che è ormai una delle grandi potenze mondiali, Giuseppe Cocco ci mostra uno scarto evidente: “anche se il Brasile riuscirà a raggiungere (come deve) un ritmo di crescita superiore alla media degli ultimi venticinque anni, ciò non si tradurrà automaticamente in una crescita dell’integrazione sociale”39. Se il Brasile può rappresentare oggi, nello scenario della crisi globale, un modello efficace di governance, è proprio perché riesce ad assicurare e incrementare la crescita economica sulla base tanto di una specificità brasiliana quanto di tendenze che caratterizzano il capitalismo contemporaneo nel suo complesso. Paradossalmente, è proprio lo scarto tra crescita economica e integrazione sociale (uno scarto che in Brasile coniuga specifiche eredità storiche come “gli altissimi livelli di concentrazione della rendita, la precarietà delle conquiste democratiche, l’inferiorizzazione razzista di buona parte della popolazione” con la “generalità dei modi sempre più precari di mobilità della forza lavoro”) a consentire tanto la crescita economica quanto la possibilità di nuove forme di integrazione e di relazione tra governanti e governati, vale a dire l’emergenza di un possibile modello di governance post-neoliberale. È quello che Cocco chiama “il divenire mondo del Brasile e il divenire Brasile del mondo”: “la questione sociale non è un’esclusione crescente – o la disoccupazione – ma un modo di inclusione – nel lavoro – che già non contiene più gli elementi di integrazione sociale che caratterizzavano l’occupazione fordista”40.
Se dunque l’America Latina, come pensiamo, rappresenta un fondamentale laboratorio politico per un presente globale “in transizione”, ciò si deve anche al fatto che una lunga storia al cui interno l’accumulazione capitalistica non si è mai liberata dal “peccato originale” della conquista, del genocidio e della violenza coloniale costituisce oggi la base di sperimentazioni innovative, tanto sul lato del capitale quanto su quello dei governi quanto su quello delle lotte e dei movimenti. Pur nelle specifiche differenze (Paesi come il Brasile o l’Argentina risultano qui difficilmente comparabili con la Bolivia, l’Ecuador o il Venezuela), la configurazione coloniale e postcoloniale dell’accumulazione capitalistica ha prodotto e riprodotto una peculiare articolazione tra “vecchio” e “nuovo”, “tradizione” e “modernità”. È stata questa stessa articolazione a irrompere nelle rivolte d’inizio millennio contro il neoliberalismo: rivolte che hanno potuto avere un esito dirompente – aprendo a dismisura spazi politici e istituzionali prima decisamente ristretti – perché in esse, per la prima volta, i lavoratori temporaneamente o definitivamente espulsi dalla macchina produttiva nei decenni di egemonia neoliberale hanno potuto riconoscere la propria condizione comune con chi di quella macchina non ha mai fatto parte, se non in forma del tutto marginale, con l’“l’altra società”. Proprio nel riconoscimento di questa condizione comune, le rivolte degli ultimi anni rendono visibile a tutti (e quindi non più mascherabile) quella che con molta efficacia Linera definisce una “modernità barocca”: una volta abbandonato il modello nazional-sviluppista (“l’idea della modernizzazione attraverso la sostituzione delle strutture tradizionali urbane e contadine”), il nuovo ordine neoliberale “ha subordinato in modo crescente e strategico il taller informale, il lavoro a domicilio e le reti comunitarie delle classi subalterne ai sistemi di controllo numerico della produzione (industria e miniera) e ai flussi monetari delle borse straniere (la banca)”. In questo modo, “il modello di accumulazione si è trasformato in un ibrido che unifica in forma stratificata e gerarchizzata strutture produttive dei secoli xv, xviii e xx attraverso tortuosi meccanismi di esazione ed estorsione coloniale delle forze produttive domestiche, comunali, artigianali, contadine e piccolo-imprenditoriali della società boliviana”41.
Qualche considerazione si impone a questo proposito. In primo luogo, se il capitalismo neoliberale mette a valore, in modo del tutto nuovo, forme di produzione pre- o non-capitaliste, quelle stesse forme sono esistite e si sono trasformate sotto traccia dal Cinquecento a oggi, restando ai margini della società coloniale e all’esterno dello spazio della cittadinanza nazional-sviluppista. Paradossalmente, è proprio la messa a valore in forma subordinata e gerarchizzata di quest’altra società (accanto a regimi produttivi ereditati da precedenti epoche dello sviluppo capitalistico) a renderla visibile e a impedire un ritorno ai precedenti modelli di governo. In secondo luogo: se l’articolazione di “strutture produttive dei secoli xv, xviii e xx” si è data storicamente in forma determinante in alcuni paesi dove si è mantenuta una presenza significativa di comunità indigene e si è riprodotta una precisa linea coloniale del colore (aspetto difficilmente estendibile all’intera regione latinoamericana), oggi essa tende ad assumere sempre più un carattere transnazionale e globale, accompagnando i movimenti dei migranti e delle merci dentro e fuori l’America latina. Basti pensare a un mercato come quello de La Salada stabilito nei primi anni Novanta al confine tra Buenos Aires e il suo “conurbano” e che è oggi considerato il più grande mercato informale dell’America latina42. In esso “s’incrociano la logica del laboratorio tessile con quella del contrabbando e della rivendita indipendente, l’importazione di merci dalla Cina e l’esportazione illegale al resto del Mercosur”43. Come dimostra Veronica Gago, un’esperienza come quella de La Salada è resa possibile dall’incontro, entro un contesto certo dominato da logiche di mercato, di differenti forme di resistenza popolare e subalterna: da quella dei boliviani che, colpiti dalla ristrutturazione neoliberale, migrano nella metropoli argentina per diffondervi l’economia informale dei laboratori tessili, alle “micro-economie proletarie” sorte all’indomani della rivolta del 2001 e che attualmente supportano le operazioni logistiche del mercato. Traendo la sua origine da un insieme di risposte di parte subalterna (non certo prive di ambivalenze44) alle politiche neoliberiste, La Salada è oggi uno specchio delle trasformazioni e della moltiplicazione del lavoro in Argentina, ben al di là dell’egemonia del lavoro salariato45. Ed è anche uno specchio dei processi transnazionali che attraversano la cooperazione sociale e produttiva in America Latina, imponendo la necessità di immaginare nuovi modelli di governance fondati su ciò che Giuseppe Cocco e Antonio Negri chiamano “cooperazione interdipendente”. Paradossalmente “l’apertura neoliberale ai flussi della mondializzazione riqualifica i termini della dipendenza: quest’ultima, anche quando si approfondisce e si estende, in realtà si trasforma, presentandosi ora come interdipendenza non solo tra il centro e la periferia ma anche tra gli stessi paesi della ‘periferia’”46.
Pur all’interno di significative differenze, le nuove esperienze di governance latinoamericana sono accompagnate – come già si è detto – dalla riconfigurazione del loro inserimento nei flussi economici transnazionali, in particolare attraverso lo sfruttamento e la commercializzazione delle risorse naturali e il peso crescente assunto dall’agrobusiness. Se negli ultimi anni, con buone ragioni, si moltiplicano le voci critiche nei confronti di regimi economici fondati in buona misura su una logica “estrattiva”, non si può tuttavia sottovalutare l’enorme incremento della capacità di spesa che tale riconfigurazione ha prodotto, tanto che si tratti dei proventi ricavati dall’esportazione su larga scala di monoculture (come la soia), quanto che si tratti di quelli ricavati dalla “‘nazionalizzazione’ di settori chiave dell’economia (in particolare i gas naturali e il petrolio) rivendicata dai movimenti”47. Ha qui le sue radici un’autonomia finanziaria che ha consentito ai governi “progressisti” di sperimentare un nuovo modello di governance post-neoliberale, attraverso la predisposizione di ambiziosi programmi sociali, come la Borsa Familia e i Pontos de Cultura in Brasile, i Planes Sociales in Argentina, il Bono Juancito Pinto in Bolivia, il Socio País in Ecuador e le varie misiónes in Venezuela48. Si tratta di politiche sociali che non sono concepite “sotto forma di un diritto formale-universale precostituito e destinato a una certa categoria di soggetti” (come nelle logiche classiche della cittadinanza moderna), quanto piuttosto “in cambio di un certo tipo di controprestazione”: “in poche parole – osserva Mellino a proposito del kirchnerismo – si trattava di captare e di rendere più produttivo il capitale sociale e politico ‘alternativo’ dei movimenti e di altri settori dell’attivismo sociale, della cooperazione e dell’associazionismo”49. È la produttività sociale che proprio attorno alle lotte e ai movimenti degli ultimi anni è maturata a essere così “messa al lavoro”, attraverso un modello che in Argentina si è sviluppato tra i due poli della mobilitazione “delle capacità e del comune” e della cooptazione clientelare in una prospettiva di controllo dei territori50. Pur nell’ambito di un diverso rapporto con i movimenti sociali, le politiche sociali di Lula in Brasile si collocano all’interno di un analogo contesto. A essere in gioco non è solo la “necessaria riduzione della diseguaglianza” o “l’imperativo della lotta alla fame”, ma soprattutto il fatto di “pensare la mobilitazione produttiva come qualcosa che dipende dalla cittadinanza, sostituendo l’equazione che poneva l’integrazione sociale come dipendente dalla crescita economica”. A questo riguardo – insiste Giuseppe Cocco – se “la cittadinanza che la Bolsa Familia prefigura è produttiva”, ancora di più lo sono i Pontos de Cultura che “democratizzano radicalmente la politica culturale e pongono la cultura potenzialmente al centro della mobilità produttiva”51.
Quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante: se la persistenza di un’economia di tipo estrattivo rimanda all’idea di una continuità con le forme precedenti di accumulazione capitalistica, è nel progressivo aumento degli investimenti sulla cultura, sulla ricerca e sulla circolazione dei saperi che si può cogliere la transizione a un nuovo modello di governance post-neoliberale. Quel che si intravede al centro di questa transizione non è certo in ogni caso un fantomatico “ritorno del popolo”, quanto piuttosto la questione della “captazione” di una nuova figura della cooperazione e della produttività sociale. È attorno a questa questione che si definisce il nuovo rapporto tra governanti e governati, riqualificato dalle rivolte contro il neoliberalismo e assunto dagli stessi nuovi governi “progressisti” come terreno di “contrattazione permanente”52. La transizione a un nuovo modello di governance post-neoliberale è dunque un “campo di battaglia”.
Pur prendendo a prestito questa immagine da uno scritto recente di Alvaro García Linera lo facciamo con un proposito diverso, e per certi versi opposto al suo: se per il vicepresidente del governo boliviano, “l’approvazione referendaria della nuova Costituzione Politica dello Stato e la rielezione del Presidente Evo Morales Ayma chiudono il ciclo di transizione statale e danno inizio alla costituzione del nuovo Stato”53, tanto la “transizione” quanto il “campo di battaglia” sono questioni del tutto aperte nel presente boliviano e più in generale latinoamericano. A maggior ragione se si pensa alle nuove ondate di conflittualità sociale che si stanno diffondendo negli ultimi tempi e con cui i governi “progressisti” sono costretti in buona sostanza a confrontarsi se vogliono dar seguito alla transizione: dal gasolinazo del 26 dicembre 2010 che ha costretto Morales a sospendere il provvedimento in cui duplicava il prezzo della benzina, alle ancora più recenti mobilitazioni indigene contro la costruzione di un’autostrada sulle terre del Tipnis54; dall’emergenza di un’altra politica in Venezuela che si oppone alla burocrazia e al corporativismo del governo chávista a partire dalla difesa delle risorse naturali e territoriali55 alle proteste contro la deforestazione e all’uso predatorio della terra in Amazzonia; e ancora, ai crescenti conflitti delle comunità rurali contro l’estensione delle terre destinate alla coltivazione della soia e l’emergenza di nuovi conflitti sindacali in Argentina56.
All’interno di queste lotte, e di molte altre che si potrebbero menzionare, si manifesta la tensione della transizione in atto, che appare come “una sorta di partita a scacchi tra movimenti e governi, una sorta di guerra di posizione, una delimitazione di terreno e spazi”57.
4. Conclusioni
Per molti aspetti, si può certo affermare che l’ascesa dei governi “progressisti” abbia chiuso un ciclo storico caratterizzato dalla crisi del neoliberalismo e dallo sviluppo di straordinari movimenti sociali: la netta discontinuità, rimarcata dai nuovi governi, con l’egemonia neoliberale, l’inedita apertura dell’arena politica e istituzionale a soggetti che ne erano stati a lungo esclusi, l’inserimento di settori dei movimenti sociali all’interno stesso delle strutture di governo e amministrative, il riconoscimento diffuso dell’autonomia territoriale e organizzativa delle comunità indigene sono tutti elementi che, nella loro complessità, delineano indubbiamente un passaggio d’epoca. Sotto questo profilo, i movimenti possono rivendicare di avere conseguito riconoscimenti e successi importanti. Niente sarà più come prima è un’affermazione che fa parte delle retoriche di molti governi “progressisti” in America Latina, che interpretano in questo modo il loro “debito” con i movimenti e le rivolte che ne hanno reso possibile la nascita. È tuttavia la lettera stessa di questa affermazione a indicare l’impossibilità di una chiusura del processo di trasformazione nelle forme istituzionalizzate della politica, nel progetto di “costruzione di un nuovo Stato”. I nuovi soggetti che hanno conquistato spazi e protagonismo nella congiuntura latinoamericana di inizio secolo continuano a rivendicare con forza la propria autonomia dagli stessi governi “progressisti”, ed è in questo senso che la costruzione di nuove modalità di rapporto tra “governi” e “movimenti” emerge come problema politico essenziale all’interno del laboratorio latinoamericano nel suo complesso58.
Non sorprende da questo punto di vista la reazione indispettita di García Linera, l’intellettuale e sociologo ex-guerrigliero che si è fatto oggi autorevole interprete del progetto di “costruzione di un nuovo Stato”, di fronte all’emergere di una nuova opposizione al governo tra le stesse fila di coloro che ne hanno accompagnato il processo costituente59. L’esperienza boliviana è indubbiamente quella in cui, all’indomani della vittoria elettorale di Evo Morales nel dicembre del 2005, il rapporto tra azione di governo e autonomia dei movimenti si è presentato nelle forme più originali e creative. È anche quella in cui l’affermazione niente sarà più come prima chiama in causa più direttamente, oltre al passato prossimo neoliberale, la lunga durata storica di una società “duale”60, costruita sull’opposizione tra la modernità coloniale – con le sue istituzioni e le sue forme di organizzazione sociale ed economica – e “un’altra società radicata in remote aree rurali e organizzata in comunità, ma che può esistere anche nelle periferie dei grandi centri urbani”61, una sorta di “anti-modernità” che è comunque ben viva nell’esperienza quotidiana della popolazione di origine indigena. È all’interno di questa altra società che è nata quella formula del buen vivir che, pur riconosciuta tanto dalla nuova Costituzione boliviana quanto da quella ecuadoriana, è stata contrapposta negli ultimi anni alle politiche di “sviluppo” dei nuovi governi “progressisti”62. In Bolivia, in ogni caso, la nuova centralità politica e simbolica assunta dallo Stato soprattutto di fronte al radicalizzarsi dell’opposizione a Morales dei dipartimenti della Media Luna è stata ampiamente vissuta come una chiusura non solo del campo di tensione tra governo e movimenti ma anche di quello tra modernità e “anti-modernità”.
Riprendiamo la categoria di “antimodernità” da un libro recente di Michael Hardt e Antonio Negri63, collocandola tuttavia all’interno di un dibattito latinoamericano in cui ben si presta a nominare l’insieme delle esperienze, delle pratiche politiche, sociali e culturali, di cui sono stati protagonisti negli ultimi anni i movimenti indigeni. È sullo sfondo del protagonismo di questi movimenti, della forza e della diffusione di un indigenismo i cui confini si sono rapidamente allargati coinvolgendo movimenti rurali e urbani non necessariamente a base indigena, che lo scontro politico in America Latina si è spesso intrecciato con vere e proprie “lotte ontologiche”, sul terreno di un confronto tra “cosmovisioni” alternative che ha messo radicalmente in discussione il significato di termini come “crescita” e “sviluppo”64. Non si tratta qui, per noi, di fare un’ingenua apologia dell’indigenismo, ma certamente è necessario registrare l’importanza di questa ulteriore posta in palio nel “laboratorio” latinoamericano contemporaneo. D’altro canto, ciò che rende davvero interessante da questo punto di vista le esperienze degli ultimi anni è il fatto che l’“anti-modernità”, irrompendo nello spazio politico, si è incontrata con un insieme di movimenti sorti dalla crisi dell’assetto storicamente assunto dalla “modernità” in America Latina. Tanto nelle lotte in difesa delle risorse naturali quanto nella resistenza alle politiche neo-liberali si è così faticosamente affermata l’allusione a un orizzonte comune da costruire, a una “altermodernità” per continuare a usare le categorie di Hardt e Negri. Ed è questo orizzonte comune che continua a riemergere come nei conflitti più recenti, riaprendo continuamente le esperienze di governance post-neoliberale in direzione di una tensione costituente che le rende un formidabile laboratorio politico per il presente globale. In questione, all’interno di questo laboratorio, non ci pare essere un “ritorno” – del popolo, dello Stato, della “politica” – ma piuttosto, in modo certo problematico e tuttavia determinato, un insieme di tracce su cui pensare e costruire il futuro.
Di prossima pubblicazione nel volume collettivo dedicato all’opera di Ernesto Laclau Populismo e democrazia radicale, a cura di M. Baldassarri e D. Melegari, ombre corte, Verona ↩
¿Por qué tiene que haber límites a la reelección?, intervista di Hugo Alconada Mon a Ernesto Laclau, in “La Nación”, 8 gennaio 2012. ↩
Ernesto Laclau, La ragione populista, Laterza, Roma 2008, p. 205. ↩
Riprendiamo la formula da Miguel Mellino, Il kirchnerismo come governance postneoliberista: alcune considerazioni (http://uninomade.org/kirchnerismo-come-governance-postneoliberista/). Per un dibattito su questo tema rimandiamo, più in generale, alla sezione Laboratorio America Latina di UniNomade2.0, in costante aggiornamento (http://uninomade.org/dossier-america-latina/) e al recente numero monografico (Autonomy and Emancipation in Latin America), a cura di Alvaro Reyes, della rivista “South Atlantic Quarterly”, CXI (2012), 1. ↩
Laclau, La ragione populista, cit., p. 212. ↩
Per uno sviluppo di questo punto, cfr. Sandro Chignola e Sandro Mezzadra, Fuori dalla pura politica. Laboratori globali della soggettività, in “Filosofia politica”, XXVI (2012), 1. ↩
Laclau, Ragione populista, cit., p. 211. Sintomatica da questo punto di vista è la discussione di Hobbes in Ernesto Laclau, Emancipation(s), Verso, London – New York 1996, pp. 45-46. Si veda sul tema l’importante riflessione di José Luis Villacañas Berlanga, The Liberal Roots of Populism: A Critique of Laclau, in “The New Centennial Review”, X (2010), 2. ↩
Mellino, Il kirchnerismo come governance postneoliberista, cit. ↩
Wendy Brown, Edgework: Critical Essays on Knowledge and Politics, Princeton University Press, Princeton 2005, p. 40. ↩
Si vedano a questo proposito, all’interno di una sconfinata letteratura, James D. Sidaway, Spaces of Postdevelopment, in “Progress in Human Geography”, XXXI (2007), 3, pp. 345–361, Kalyan K. Sanyal, Ripensare lo sviluppo capitalistico. Accumulazione originaria, governamentalità e capitalismo postcoloniale: il caso indiano, La Casa Usher, Firenze 2010 nonché, specificamente sull’America Latina, Giuseppe Cocco e Antonio Negri, GlobAL. Biopotere e lotte in America Latina, Manifestolibri, Roma 2006. ↩
Si vedano Miradas. Nuevo Texto Constitucional, IDEA, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz 2010 (per quanto riguarda la Bolivia) e Alberto Acosta e Esperanza Martínez (a cura di), Plurinacionalidad. Democracia en la diversidad, Abya-Yala, Quito 2009 (per quanto riguarda l’Ecuador). ↩
José Martí, Nuestra America, Editorial de ciencias sociales, La Habana 1975 (l’articolo che dà il titolo alla raccolta è del 1891 e si può leggere in traduzione italiana in Id., Cuba, USA, America Latina. Scritti politici 1871-1895, La Nuova Italia, Firenze 1972). Per la ripresa della riflessione sull’America latina nel dibattito più recente si vedano, ad esempio: Walter D. Mignolo, The Idea of Latin America, Blackwell, Malden (Ma) 2005, Arturo Escobar, Territories of Difference: Place, Movements, Life, Redes, Duke University Press, Durham – London 2008, Boaventura de Sousa Santos, Refundación del estado en América Latina: Perspectivas desde una epistemología del sur, Siglo XXI Editores, México 2009. ↩
Vamos a una polarización institucional, intervista di Javier Lorca a Ernesto Laclau, “Página/12”, 17 maggio 2010. ↩
¿Porqué tiene que haber límites a la reelección?, cit. ↩
Arturo Escobar, Una minga para el postdesarrollo: lugar, medio ambiente y movimientos sociales en las transformaciones globales, Programa Democracia y Transformación Global, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 2010, p. 39. ↩
Ibidem. Si veda anche, all’interno di un’analoga prospettiva, Sanyal, Ripensare lo sviluppo capitalistico, cit. ↩
Il ruolo centrale delle nazionalizzazioni all’interno dei governi nazional-sviluppisti è particolarmente sottolineato da Raúl Prada Alcoreza, La recreación anacrónica del imaginario desarrollista (http://uninomade.org/la-recreacion-anacronica-del-imaginario-desarrollista/). ↩
Si veda Gennaro Ascione, A sud di nessun Sud. Postcolonialismo, movimenti antisistemici e studi de coloniali, I libri di Emil, Bologna 2009. ↩
Giovanni Arrighi, Adam Smith in Beijing. Lineages of the Twenty-First Century, Verso, London 2007, pp. 384 ss. nonché Giovanni Arrighi e Lu Zhang, Dopo il neoliberismo. Il nuovo ruolo del Sud del mondo, in Giovanni Arrighi, Capitalismo e (dis)ordine mondiale, Manifestolibri, Roma 2010, pp. 181-217. ↩
Cocco e Negri, GlobAL, cit., p. 34. ↩
Álvaro García Linera, La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia, Clacso-Prometeo, Buenos Aires 2008, p. 269 (il volume, a cura di Pablo Stefanoni, presenta una preziosa silloge di saggi scritti da Linera nell’arco degli ultimi vent’anni). ↩
Escobar, Una minga para el postdesarrollo, cit., pp. 36-37. ↩
È questa la tesi centrale della teoria delineata da Cocco e Negri in GlobAL (cit.) e ripresa successivamente da Giuseppe Cocco, MundoBraz. O devir-mundo do Brasil e o devir-Brasil do mundo, Editora Record, Rio De Janeiro – Sao Paulo 2009. ↩
Più in generale, sulla continua riproduzione dell’“accumulazione originaria” lungo l’intero arco delle politiche di “sviluppo”, cfr. Sanyal, Ripensare lo sviluppo capitalistico, cit. Per una rilettura e un’attualizzazione dell’analisi marxiana della “cosiddetta accumulazione originaria”, si veda S. Mezzadra, La condizione postcoloniale. Storia e politica nel presente globale, Verona, ombre corte, 2008. ↩
Si vedano ad esempio le raccolte di saggi: Mabel Morana, Enrique Dussel, e Carlos A. Jauregui (a cura di), Coloniality at large. Latin America and the Postcolonial Debate, Duke University Press, Durham – London 2008 e Walter D. Mignolo e Arturo Escobar (a cura di), Globalization and the Decolonial Option, Routledge, London 2010. ↩
Aníbal Quijano, Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, in Edgardo Lander (a cura di), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas, CLACSO, Buenos Aires 2000, pp. 219-220. ↩
Cfr. in particolare Cocco, MundoBraz, cit., in specie pp. 70-75 e García Linera, La potencia plebeya, cit, in specie pp. 274-288. ↩
Si vedano a questo proposito le considerazioni dell’intelletuale uruguayano Raúl Zibechi in Michael Hardt e Alavaro Reyes, “New Ways of Doing”: The Construction of Another World in Latin America. An Interview with Raúl Zibechi, in “South Atlantic Quarterly”, CXI (2012), 1, in specie pp. 175-176. ↩
Cfr. Partha Chatterjee, Oltre la cittadinanza. La politica dei governati, Roma, Meltemi, 2006 e Id., Lineages of Political Society. Studies in Postcolonial Democracy, Columbia University Press, New York 2011. ↩
Per una discussione del significato di questi termini, nonché delle tensioni tra i progetti a cui fanno riferimento, si veda Arturo Escobar, Latin America at a Crossroads. Alternative Modernizations, Post-Liberalism or Post-Development?, in “Cultural Studies”, XXIV (2010), 1. ↩
Alvaro Reyes, Revolutions in the Revolution: A Post-Hegemonic Moment for Latin America?, in “South Atlantic Quarterly”, CXI (2012), 1, pp. 7-8. È appena il caso di ricordare che molti esponenti di primo piano dei nuovi governi “progressisti” provengono dalle variegate esperienze della guerriglia latinoamericana degli anni Settanta. ↩
Ivi, p. 2. ↩
Si veda, per una prima approssimazione al problema, Marion Duval, La querelle du néo-extractivisme en Amerique Latine, in «Revue des Livres», 1, sept/oct 2011. ↩
Miguel Mellino, Buenos Aires 2001 – Tunisi 2011. La fine di una lunga notte in dieci anni, in Ambra Pirri (a cura di), Libeccio d’Oltremare. Il vento delle rivoluzioni del Nord Africa si estende all’Occidente, Ediesse, Roma 2011, p. 50. ↩
L’uso che qui facciamo del concetto di moltitudine, pur riferendosi ai contributi di autori come Michael Hardt, Antonio Negri e Paolo Virno, va inteso sullo sfondo dei dibattiti latino-americani, in cui il concetto è stato ad esempio impiegato da Linera e Gutiérrez per distinguere le soggettività politiche che si sono espresse all’interno dei movimenti e delle insorgenze degli ultimi anni da quelle egemoni in precedenti momenti di conflittualità sociale e politica. Si vedano in particolare Alvaro García Linera, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada e Luis Tapia, El retorno de la Bolivia plebeya, La Muela del Diablo Editores, La Paz 2000, Luis Tapia, Álvaro García Linera e Raúl Prada Alcoreza, Memorias de Octubre, Muela del Diablo Editores, La Paz 2004, Raquel Gutiérrez Aguilar, Los ritmos del Pachakuti. Movilización y levantamiento indígena-popular en Bolivia, Tinta Limón, Buenos Aires 2008. ↩
Cocco, MundoBraz, cit., p. 72. ↩
García Linera, La potencia plebeya, cit., 271. ↩
Ivi, 276-280. ↩
Cocco, MundoBraz, cit., p. 72. ↩
Ibidem. ↩
García Linera, La potencia plebeya, cit., p. 270. Per una ricostruzione della genealogia di quella che Linera definisce “modernità barocca”, si veda S. Rivera Cusicanqui, Democracia liberal y democracia de ayllu. El caso del Norte Potosí, Bolivia’, in C.F.T. Roca (a cura di), El Dificil Camino Hacia la Democracia, ILDIS, La Paz 1990. ↩
Cfr. S. Sassen, La Salada: The Largest Informal Market in Latina America, http://www.forbes.com/sites/megacities/2011/03/28/la-salada-the-largest-informal-market-in-south-america/, ma soprattutto V. Gago, Mutaciones en el trabajo en la Argentina post 2001. Entre la feminización y el trabajo esclavo, Tesis para optar al título de Doctor en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires 2011. ↩
Colectivo Simbiosis e Colectivo Situaciones, De chuequistas y overlockas. Una discusión en torno a los talleres textiles, Tinta Limón, Buenos Aires, p.12. ↩
Come osserva Veronica Gago, i migranti boliviani portano con sé un “capitale comunitario” che nel corso del processo migratorio si trasforma e riconfigura: “questo ‘capitale comunitario’ è caratterizzato da una profonda ambivalenza: può lavorare come una risorsa per l’autogestione, la mobilitazione e l’insubordinazione e, allo stesso tempo, come una risorsa per la servitù, la sottomissione e lo sfruttamento” (Gago, Mutaciones en el trabajo en la Argentina post 2001, cit., p. 212). ↩
La categoria di “moltiplicazione del lavoro” è al centro di S. Mezzadra e B. Neilson, Border as Method, or, The Multiplication of Labor, di prossima pubblicazione per Duke University Press, dove viene presentata sia in riferimento ai processi di intensificazione ed “eterogeneizzazione” del lavoro che si possono oggi osservare su scala globale sia dall’interno di una discussione dei limiti delle teorie della “divisione internazionale del lavoro”. ↩
Cocco e Negri, GlobAL, cit., p. 35. ↩
Reyes, Revolutions in the Revolutions, cit., p. 9 che sottolinea come non si tratti di vere e proprie “nazionalizzazioni”, quanto piuttosto della “rinegoziazione delle royalties che le corporation multinazionali devono ai singoli stati in proporzione agli introiti guadagnati attraverso la produzione e la vendita delle risorse naturali”. Si veda su questo punto anche Prada Alcoreza, La recreación anacrónica del imaginario desarrollista, cit. ↩
Reyes, Revolutions in the Revolutions, cit., p. 9. Per un’analisi comparata delle nuove politiche sociali in America Latina, delle loro potenzialità così come dei loro limiti, si veda comunque E. Gudynas, R. Guevara e F. Roque (a cura di), Heterodoxos. Tensiones y posibilidades de las polí́ticas sociales en los gobiernos progresistas de Américas del Sur, CLAES y OXFAM, Montevideo 2008 (scaricabile dal sito http://www.democraciasur.com/). ↩
Mellino, Il kirchnerismo come governance postneoliberista, cit. ↩
Ibidem. ↩
Cocco, MundoBraz, cit., pp. 93-94. ↩
Mellino, Il kirchnerismo come governance postneoliberista, cit. ↩
Alvaro García Linera, El Estado en transición. Bloque de poder y punto de bifurcación, in Álvaro García Linera, Raúl Prada, Luis Tapia e Oscar Vega Camacho, El Estado. Campo de lucha, Muela del Diablo Editores, CLACSO, La Paz 2010, p. 32. ↩
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure. ↩
Si veda Roland Denis, The Birth of an “Other Politics” in Venezuela, in “South Atlantic Quarterly”, CXI (2012), 1. ↩
Rimandiamo, a questo proposito, a Colectivo Situaciones, Notas de la coyuntura argentina (http://uninomade.org/notas-de-la-coyuntura-argentina/). ↩
Zibechi in Hardt e Reyes, “New Ways of Doing”, cit., p. 173. ↩
Si veda ad esempio in questo senso Escobar, Latin America at a Crossroads, cit., pp. 44-45. Su questi temi, in America Latina, il dibattito è davvero molto ampio: vale tuttavia la pena di menzionare i lavori dell’antropologo brasiliano Eduardo Viveiros de Castro, di cui si vedano almeno Exchanging Perspectives. The Transformation of Objects into Subjects in Amerindian Ontologies, in «Common Knowledge», X (2004), 3 e Métaphysiques cannibales, PUF, Paris 2009.e Transformation of Objects into Subjects in Amerindian Ontologies, in «Common Knowledge», X (2004), 3 e Métaphysiques cannibales, PUF, Paris 2009. ↩
Si vedano il Manifiesto de la Coordinadora plurinacional de la reconducción, Por la recuperación del proceso de cambio para el pueblo y con el pueblo (giugno 2011: il testo si può leggere all’indirizzo http://www.narconews.com/Issue67/articulo4456.html), la risposta di Alvaro García Linera, El “oenegismo”, enfermedad infantil del derechismo (O cómo la “reconducción” del Proceso de Cambio es la restauración neoliberal), Vicepresidencia del Estado Plurinacional, La Paz 2011 e la replica successiva, La mascarada del poder. Respuesta a Alvaro García Linera, dicembre 2011 (sia il testo di Linera sia la replica sono scaricabili dall’indirizzo web http://www.plataformaenergetica.org/content/3160). ↩
Il riferimento alla “società duale” è utilizzato da Pablo González Casanova per elaborare la categoria di “colonialismo interno” che avrà un’ampia e durevole influenza in America latina. Cfr. Pablo González Casanova, Sociología de la explotación (1969), Siglo XXI, México 1975. Per gli sviluppi più recenti della categoria di “colonialismo interno” è fondamentale il riferimento a Silvia Rivera Cusicanqui, Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y qhechwa de Bolivia, 1900-1980, Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, Ginebra 1986. ↩
Zibechi in Hardt e Reyes, “New Ways of Doing”, cit., pp. 175-176. ↩
Si veda a questo proposito il breve ma influente articolo di Imanuel Wallerstein, America latina e popoli nativi, contraddizioni di sinistra (uscito in italiano in “il Manifesto»”, 7 settembre 2010, e scaricabile all’indirizzo http://yabastanapoli.blogspot.it/2010/09/america-latina-contraddizioni-di.html). ↩
Michael Hardt e Antonio Negri, Comune. Oltre il pubblico e il privato, Rizzoli, Milano 2010, pp. 75-125 per la definizione dei concetti di “modernità”, “antimodernità” (una “forma di resistenza interna alla modernità”) e “altermodernità” (che “nasce dall’interno dell’antimodernità da cui però di congeda per la ragione che essa lancia la resistenza e l’opposizione al di là dei limiti dell’antimodernità”). ↩
Si veda ancora Escobar, Latin America at a Crossroads, cit., in specie p. 39. ↩