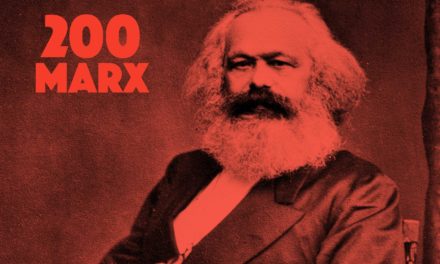di GIROLAMO DE MICHELE.
Comincio facendo, come si dice, coming out: chi guardasse nella mia libreria, vi troverebbe La distruzione del sistema di Franco Freda (l’ideatore della strage di piazza Fontana), diverse opere di Vincenzo Vinciguerra (autore della strage di Peteano), le cose più significative, in qualunque senso, di Julius Evola, tutti i cosiddetti “catechismi del fascismo”, e naturalmente La dottrina del fascismo di Mussolini (della quale sono in grado di citare interi passi a memoria), il Diario 1922 di Balbo, la Difesa della razza di Nello Quilici, la silloge degli scritti razzisti e antisemiti di Giovanni Preziosi Giudaismo, bolscevismo, plutocrazia, massoneria, una discreta raccolta dei giornali fascisti “Il Balilla”, “Il Corriere padano” e “La Gazzetta ferrarese”, e persino Il “caso” don Minzoni di Vincenzo Caputo, il più pataccaro fra i sedicenti “storici” fascisti. Altra pubblicistica dello stesso tenore l’ho in versione digitale, altra ancora l’ho consumata (una per tutte: l’intera raccolta di “La difesa della razza”) nelle biblioteche. Dunque non mi scandalizza più di tanto la ripubblicazione del Mein Kampf , che peraltro non è difficile da trovare sulle bancarelle degli usati – così come non mi scandalizza il cinismo di chi l’ha ripubblicato (uno che su “La Vita illustrata” di Preziosi al più veniva buono per procurare caffè e tabacchi). Aggiungo, per dirla tutta, che trovo inutile e dannosa la nuova legge sul reato di negazionismo, che sostituisce la battaglia politica e culturale con le aule di tribunale e la santità del diritto penale.
Ma soprattutto, trovo falsa e ipocrita l’indignazione bypartisan per la pubblicazione del manifesto hitleriano, al netto delle finalità di marketing dell’operazione.
Il Mein Kampf è un documento storico. Inutile ribattere che non fu scritto per questo, ma per altri, ignobili scopi: ce l’hanno insegnato intere generazioni di storici, a partire quantomeno da quelli delle “Annales”, cosa distingue un documento da un monumento, e cosa fa sì che qualsiasi prodotto della mente umana possa diventare un giorno documento: René Belloq, l’archeologo senza scrupoli de I predatori dell’arca perduta, non diceva nulla che non avesse già detto Giambattista Vico. E come tale dovrebbe essere oggetto di lettura, studio e critica.
Ma quale lettura, quale studio, quale critica? Si dirà: quella che tu, come docente di storia, dovresti praticare e insegnare.
Parliamone. Negli anni zero, attraverso una serie di riforme che i governi di destra hanno attuato e quelli di “sinistra” avallato e di fatto confermato, l’insegnamento della storia ha subito danni paragonabili alla distruzione del patrimonio culturale e ambientale di cui talvolta si sente parlare, per lo più da parte di inascoltate Cassandre come Montanari o Settis. Quella storia che un tempo era insegnata dapprima come racconto, forse un po’ favolistico, alle elementari, poi ripresa alle medie, e infine approfondita alle superiori, oggi nella scuola di base viene svolta in un’unica soluzione continua, dalla primaria alla secondaria inferiore, in base allo stolto preconcetto che ripetere due volte la stessa cosa è un’inutile perdita di tempo, dunque di soldi. In questo modo i contenuti di base (taccio di competenze quali il senso del tempo e la comprensione causale) non si fissano nelle menti degli studenti. Si aggiunga che la storia viene insegnata senza la sua naturale e indissociabile metà, e cioè la geografia (il fondo marino sul quale Braudel collocava il mare degli eventi): il risultato è una disciplina epilettica, nella quale nozioni aleatorie galleggiano su una geografia paragonabile a una carta che, esposta alla pioggia, ha scolorito e mescolato ogni distinzione di nazione, confine, ambiente.
In queste condizioni, gli studenti entrano nel ciclo secondario, dove nel biennio incontrano insegnanti che non provengono da studi storici, ma letterari: e che, mancando di studi specifici, spesso mancano delle competenze che dovrebbero insegnare. Una lacuna che fino a ieri era in qualche modo rattoppata da una preparazione di base che oggi, nella sua assenza, lascia aperta una voragine della quale nessuno si occupa: si aprono pagine fb e gruppi “uozzàp” per parlare delle buche delle strade che danneggiano le auto, non certo per quelle buche che danneggiano la strada dell’istruzione e della cittadinanza di domani. Faccio un esempio: fino a qualche anno fa era possibile affrontare in una certa maniera il Risorgimento, perché quantomeno sulle biografie di Mazzini e Garibaldi gli studenti c’erano già. Da un certo momento, è stato necessario cominciare spiegando chi erano e cosa sono stati Mazzini e Garibaldi, perché gli studenti, se mai li avevano studiati, li avevano e li hanno dimenticati.
Nel frattempo al triennio finale dell’istruzione superiore la storia ha subito una riduzione di orario (quasi dappertutto solo due ore a settimana, anche nell’anno terminale), mentre i programmi si gonfiavano (l’alto Medioevo è stato spostato dal biennio al triennio) e le classi crescevano del 20-25% di alunni – dunque più tempo per le verifiche, da sottrarre al già ridotto tempo della lezione. La picconata finale sono le 200 ore (400 nei tecnico-professionali), equivalenti all’intero curricolo di storia, che vengono sottratte alla didattica con la cosiddetta “alternanza scuola-lavoro” che, per dirla con le parole di Tullio De Mauro, trasforma le scuole in un serraglio di Confindustria con la pretesa di produrre non cittadini, ma lavoratori. Lavoratori che fanno apprendistato della vita che verrà facendo “stages” – parola esotica dietro la quale si celano sempre più spesso prestazioni di lavoro a titolo gratuito, ossia lavoro nero legalizzato. Tutto questo significa, com’è ovvio, meno contenuti insegnati. Ma questo è il meno.
Torniamo al Mein Kampf. Di cosa si tratta, ad averlo letto? Di un libro che, come tanti, pretende di asserire sulla storia tedesca (e di riflesso su quella europea) relazioni di causa ed effetto, di indicare fatti e strutture storiche, e di trarne inevitabili conseguenze. Non fanno cosa diversa i capolavori di Tucidide, Tacito, i cronisti senesi, Braudel, Schama, Le Goff, Dee Brown o Darnton. Dov’è allora la differenza?
La differenza è quella che passa fra due eventi che si susseguono solo perché l’autore li ha così narrati, e due eventi dei quali l’uno contiene già in nuce l’altro: che è la relazione causale. Fra una gerarchia tra i fatti storici che tiene conto del diverso grado fra strutture economiche o episteme, ed eventi afferenti al campo dell’eventuale, del sovrastrutturale, della cieca singolarità che si agita sotto la soglia delle epoche. Della differenza fra una deduzione e un’induzione – che è la forma di collegamento fra i fatti che ogni razzista istituisce enumerando casi singolari (che siano ebrei o migranti o musulmani, poco importa). Della differenza fra una fonte e una voce di seconda mano, fra un testo e una docufiction, tra un film storico e uno in costume. Della differenza fra un cumulo di affermazioni prive di riscontro (ma accattivanti e persuasive ), qual è il Mein Kampf, e una seria analisi storico-politica quale, ad esempio, la raccolta degli articoli di Piero Gobetti su “La Rivoluzione liberale”.
Tutte cose che una scuola degna di questo nome – e di qualche parola scritta nella Costituzione, per chi fosse interessato – dovrebbe insegnare prima ancora che i contenuti, che pure sono importanti: queste strutture mentali il chiacchiericcio burocratico le chiama “competenze”, sottintendendo meno il significato di cum petere, incontrarsi e andare insieme, e più quello aziendalistico di competere attraverso un compito da svolgere e mettere a valore. Ma sono quelle capacità che consentono di distinguere un ragionamento da una stronzata, un libro di storia da un opuscolo di propaganda, un fatto da una percezione, il sopravvissuto Primo Levi dal razzista Nello Quilici, Furio Jesi da Julius Evola – al limite, Michel Foucault e Walter Benjamin da Diego Fusaro e Adriano Scianca.
Ma io, insegnante di storia, in quelle due ore tosate come vecchie monete dall’alternanza scuola lavoro e da tante altre “attività”, arroccato in difesa mentre i dirigenti d’azienda reclamano il diritto di portare gli studenti ad ascoltarli magnificare l’importanza dell’andare a lavorare a 20 anni, se non già a 18 o 16, nella loro azienda (col sostegno del ministro Poletti); io insegnante, il tempo, lo spazio, l’attenzione per insegnare quelle abilità, o competenze, o come volete chiamarle, attraverso una paziente analisi comparata dei documenti – foss’anche, perché no, del Mein Kampf o la Dottrina del fascismo o la Difesa della razza – dove le ho? E quei signori che, tutti insieme, oggi si stracciano le vesti per una miserabile operazione di marketing, dov’erano, quando quelle ore nelle quali io avrei potuto insegnare a leggere il Mein Kampf mi sono state tolte? Erano lì, ben attivi a toglierle, quelle ore, con pensieri, opere e omissioni, o con la loro ignavia.
Non diceva forse Carlo Levi che Cristo gli appariva fermatosi ad Eboli, perché a Gagliano non erano arrivati né il treno “né la speranza, né il legame tra le cause e gli effetti effetti, la ragione e la Storia”? Ma in quella terra oscura dove Cristo non era arrivato, “il male non è morale, ma è un dolore terrestre, che sta per sempre nelle cose”. E se il male non è morale, è irredimibile, perché oscure e mitiche restano le sue materialissime cause, ed eternamente indistinte e indistinguibili, perché a discriminarle non c’è il giudizio critico né la lotta che muove il giudizio a sollevare dalle terra i sassi per scagliarli contro l’ingiustizia. Ed eterna e irredimibile resta la distinzione fra servi e padroni, fra cafoni e signori: che è il nostro quotidiano Mein Kampf che viene, ben più letale di quello cartaceo.
Questo articolo è stato pubblicato su Il lavoro culturale il 13/06/2016