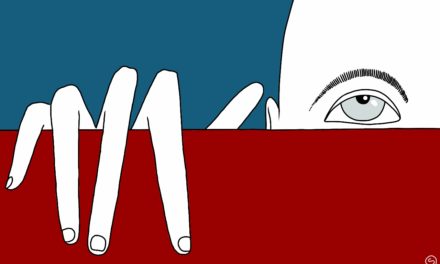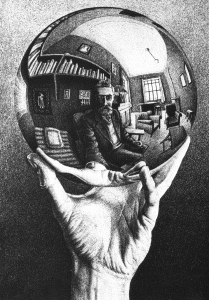di GIROLAMO DE MICHELE.
Questo testo, del quale pubblico la prima parte, è tratto da un cantiere di lavoro in corso d’opera sul significato simbolico della peste nella letteratura. Quella pubblicata oggi è una sorta di introduzione gnoseologica, e al tempo stesso un omaggio a Jean-Luc Nancy ed Elena Pulcini [la seconda parte è qui].
L’evento e l’avvento del virus si impongono come una radicale novità nella percezione globale di ciò che chiamiamo mondo. Non è una novità il virus, e non sono novità le sue conseguenze: ma lo è la forza percettiva con la quale si è imposto. E ciò che chiamiamo mondo è, in misura determinante, connesso alla sua rappresentazione.
La novità del virus consiste in primo luogo nella percezione della fine del mondo come lo conosciamo, e cioè di uno spazio abitato e determinato dalla specie umana, come un evento possibile e plausibile. È possibile e sensato istituire analogie col pericolo della fine nucleare del mondo, che l’umanità ha percepito nella fase acuta della Guerra Fredda; e con la catastrofe ambientale che, avviata dalla rivoluzione industriale, si è avvicinata nel finire del secolo scorso un punto di non ritorno. Tuttavia, la guerra nucleare era percepita come possibile catastrofe politica, che la stessa sovranità politico-statale era in grado di sovradeterminare e scongiurare: in altri termini, da ambo le parti uno sguardo dall’alto, associato a un consenso politico verso i governanti della propria fazione, compensava quel pericolo che ha trovato in almeno due casi – Il dottor Stranamore di Stanley Kubrick e A prova di errore di Sidney Lumet – adeguate rappresentazioni cinematografiche. Oggi, per diverse ragioni, quel punto di vista sovrano non domina la scena con uno sguardo dall’alto, e il suo abbassarsi nella gestione amministrativa ordinaria dell’emergenza fa venir meno l’elemento di rassicurazione. Nondimeno, ci sono elementi di riflessione di quella passata crisi, da Anders a Jaspers, che possono essere recuperati al presente.
In modo analogo, la crisi climatica (ri)propone l’eventualità della fine del mondo: ma tale crisi non era stata percepita come tale, a differenza del virus. Anche in questo caso c’è una grande riflessione, ancorché fino ad oggi minoritaria, utile a comprendere il presente in favore di un tempo futuro.
Contribuisce alla percezione del virus come evento catastrofico la sua percezione come di un qualcosa che risponde a leggi della natura indipendenti dalla volontà umana, e non come un prodotto della specie umana (di un segmento di questa). Questa percezione è in sé errata, perché coglie solo l’aspetto biologico del virus, ignorando il contesto nel quale il virus è diventato pandemico: il capitalismo. A giusta ragione, Clausi e Murri parlano di Pandemia capitale.
«Il capitalismo è il sistema che va distruggendo le nostre vite, nello stesso momento in cui si adopra per salvarle: senza le nostre vite, non c’è produzione e non c’è consumo – non c’è profitto. Nella pandemia, questa «doppia elica» del codice genetico del capitalismo è apparsa con ogni evidenza. La pandemia è il risultato della continua distruzione dell’habitat, dello smantellamento dei sistemi sanitari nazionali, di una diffusa e ininterrotta mobilità e socialità finalizzata solo alla produzione intensiva; e tutti i metodi imperfetti per farvi fronte, per «salvarci», dalle scelte di gestione dei governi ai farmaci messi in campo, sono occasioni ghiotte per profitti impensati (i guadagni delle Big Pharma e delle Big Data sono impressionanti, come il balzo delle loro quotazioni) e per accrescere ulteriormente l’accumulazione e il controllo dei nostri dati per orientare ancora meglio le nostre scelte di consumo e per “gestirci”» (Lanfranco Caminiti, Contro la forma-stato del Novecento).
In sintesi: il virus ha portato in primo piano, e costretto alla percezione, elementi di crisi preesistenti, che diventano visibili attraverso la lente degli effetti prodotti da quella che non è una semplice pandemia, ma una sindemia. Riprendendo un’affermazione di Rancière sull’invisibilità del Capitale, per quanto il virus appaia invisibile, o invisibili ai più appaiono le sue determinazioni politico-sociali, sono visibili i suoi effetti: e questi effetti sono di classe.
Per fine del mondo intendo la duplice accezione che emerge dai materiali di lavoro di Ernesto De Martino: la paura della fine del mondo, e l’attesa della fine del mondo come premessa per un mondo nuovo. I materiali raccolti nel volume La fine del mondo, che dovevano diventare un volume che avrebbe raccordato l’intera ricerca di De Martino come costituita da capitoli di un unico lavoro, evidenziano una dimensione filosofica di straordinaria ampiezza. È significativo che questa dimensione, e questo volume (pubblicato alla vigilia dell’evento pandemico), siano stai pressoché ignorati dal dibattito filosofico italiano, mentre sono stati subito tematizzati e fatti oggetto di riflessione da italianisti di valore quali Bologna e Cataldi.
In secondo luogo, la novità del virus è il fatto biologico stesso del virus. In termini propri, il virus non è un essere: non è. Nondimeno, è qualcosa. Non è dotato di vita propria, ma parassita la vita altrui: è “in potenza di vita”. Non è dotato di intelligenza, volontà, capacità di pianificazione delle proprie azioni: ma i suoi effetti si presentano come prodotti da una intelligenza perversa, che ha come scopo la sua sopravvivenza a scapito della specie che ne patisce l’affezione.
La difficoltà a pensare, dire, comunicare il virus si evidenzia nella comunicazione mediatica, quando persino virologi ed epidemiologi sono spinti all’uso di un linguaggio lamarkiano: quando parlano dell’astuzia del virus, o gli attribuiscono una volontà di sopravvivenza. Ciò dimostra, a fortiori, che lungi dall’essere diventati davvero galileiani, non siamo (in senso generale) diventati darwiniani: in generale, non riusciamo a pensare in modo quotidiano e ordinario nei termini della scienza della tarda modernità. Come annotava Gödel, dal punto di vista percettivo la relatività di Einstein non muta la concezione del mondo, perché non è traducibile in termini percettivi: continuiamo, e continueremo, a rappresentarci il mondo come se spazio e tempo fossero forme a priori.
Una serie televisiva di grande e inatteso successo, Dark, è stata percepita come di difficile comprensione, per la semplice ragione che la sua trama prendeva sul serio la concezione relativistica del tempo, invece di svolgersi nella classica sequenza passato-presente-futuro. L’inquietudine suscitata dalla difficoltà di comprensione è indice di un aspetto del tempo presente: la percezione di sé come collocata all’interno di un contesto del quale sfuggono i confini e le dinamiche. Ciò ha a che fare con la finitezza costituente (ma di questo nella seconda parte).
Il virus in potenza di essere è incomprensibile a un pensiero che mantenga il fondamento classico dell’ontologia occidentale: la distinzione fra essere e non essere.
La crisi dei fondamenti dell’ontologia comporta la crisi del concetto stesso di verità: «esaminare la verità secondo il discorso dell’onto-teo-logia equivale a esaminare la verità della metafisica occidentale. Ma non è esaminare una verità particolare, relativa, situata nella storia e nello spazio. Perché è a questa verità che commisuriamo qualsiasi “relativo”». Attraverso la verità, l’Occidente si presuppone: «è così che l’Occidente è la verità, e che la presupposizione mondiale dell’Occidente è proprio la nostra “verità”» (Jean-Luc Nancy).
Esiste un pensiero minoritario che si colloca a lato rispetto alla storia dell’onto-(teo)-logia occidentale, che ha cercato di pensare l’essere come possibilità o potenza di essere. Da questo pensiero può essere tratto un archivio sul quale impostare un ripensamento generale di ciò che impropriamente continuiamo a chiamare “essere”, o, in termini diversi, il modo, e le modalità del nostro esserci al suo interno. Questo pensare ha a che fare con la fine del mondo come attesa della sua fine e nuovo cominciamento, in radicale discontinuità con un pensiero che «si riduce a far ricorso ad espedienti fra l’analgesico e il corrivo per rassicurarsi circa le proprie garanzie di sopravvivenza nel novero dei saperi istituzionalmente riconosciuti», e «tende a quietarsi nel compiacimento di una più o meno eccellente architettonica della propria Opera» (Adone Brandalise).
La percezione dell’evento pandemico è inficiata da un duplice errore rappresentativo: tendiamo a pensare la nostra relazione col virus – al netto delle tare concettuali lamarkiane presenti nel senso comune (la cui presenza impaurisce il buon senso, secondo la celebre distinzione di Manzoni annotata da Gramsci nell’XI dei suoi Quaderni) – come un’affezione che ci giunge dall’esterno. In questa immagine, il soggetto si rappresenta come un io individuale, come il fuoco di una circonferenza oltre la quale esiste quell’esterno dal quale proviene il virus. L’uso della metafora immunitaria come strumento di dominio e assoggettamento è una causa di questa errata percezione; un’altra causa è l’incomprensione, entro certi limiti costitutiva, della concezione scientifica del mondo.
Peraltro, che il confine di quella circonferenza esprima i limiti del soggetto inteso come io dotato di un corpo è un errore, dal momento che il corpo stesso non ha come confine esterno la pelle, ma si prolunga in tutti quegli artefatti – abiti, armi, apparecchi acustici e visivi, bastoni da passeggio, apparecchi telematici, e via dicendo – che si aggiungono al corpo “naturale” (Leroi-Gourhan). La stessa “mente” non è localizzata nel solo cervello, né confinata entro i limiti del corpo individuale, ma scorre attraverso questa e quello in tutti i concatenamenti che si aggiungono, accrescendolo, al mio corpo, fino a mettere in discussione la liceità del possessivo “mio”.
L’antropocentrismo del quale non siamo ancora capaci di liberarci ha una funzione analgesica e rassicurante rispetto all’impossibilità di conciliare scienza e senso comune. Per fare un esempio, il citatissimo parametro Ro (il cui valore è peraltro indipendente dal numero delle citazioni), che esprime la virulenza di un patogeno, è un numero che non è calcolabile dal cosiddetto uomo della strada, o dalla celebre casalinga di Voghera, perché il suo calcolo comporta la quantificazione di un novero di dati non disponibili in modo ordinario. La sua sostituzione con un (spesso demenziale) esercizio di statistica, prefigurato da taluni come esercizio di scienza dal basso, è per l’appunto un esercizio di senso comune che ha a che fare con la peste del linguaggio di cui tratto nella seconda parte: il dato statistico è infatti assunto «come equivalente delle tecniche mitico-rituali della protezione della presenza di fronte alla crisi ontologica del mero esserci» (De Martino).
Una prima correzione all’immagine soggettocentrica del confine dell’Io come circonferenza è quella, resa classica da Foucault, dell’ellisse, cioè di quella curva che ruota attorno a due fuochi: il soggetto affetto dal patogeno, e il virus che lo affligge. Ma fra questi due fuochi sarebbe errato istituire una relazione di simmetria. Infatti, sul lato del soggetto umano, il virus è un evento che mi accade in quanto individuo, e questo accadere costituisce una relazione. Sul lato del virus, invece, il virus si relaziona non a me, ma all’intera specie cui appartengo, e solo accidentalmente questa affezione concerne proprio me. Il che vuol dire, recuperando un concetto kantiano, che il virus mi concerne in quanto campione del genere umano, nello stesso senso in cui il soggetto morale compie il bene intendendo l’altro verso cui agisce come campione del genere umano, cui è rivolta l’azione morale.
Questo concetto, per come lo intende Kant, presenta tuttavia due inconvenienti. Il primo è che Kant è ben consapevole che, pur essendo la facoltà di fare il bene (e quella di distinguere il bene dal male) connaturato nella natura umana – ciò che distingue l’umano dall’animalità naturale –, non tutti gli esseri umani scelgono di fare il bene: il che non costituisce un problema per il luterano Kant, per il quale l’umanità è pur sempre un legno storto che l’illuminismo può solo in parte raddrizzare (pur con la notevole eccezione delle precritiche Lezioni di etica). Il secondo è che la riflessione su come sia stato possibile Auschwitz, fra Arendt, Bauman, Anders, Canetti (solo per nominarne alcuni) ha mostrato che quella facoltà di fare il bene, ammesso ma non concesso che sia innata, è comunque passibile di assopimento, come la ragione nella celebre incisione di Goya ricalcata da Kubrick nel Jack Torrance addormentato sulla macchina da scrivere in Shining.
La seconda correzione consiste nel comprendere che il soggetto non è “interno” a una circonferenza oltre la quale ci sono “gli altri”, ma che «dovremmo pensarci come qualcosa che nasce ai bordi, che nasce lungo le linee di contatto, perché noi siamo veramente non tanto un presunto interno, in cui non stiamo in realtà mai e che rappresenta una nostra proiezione, ma siamo sempre […] in un nostro continuo “andar fuori”». In definitiva, «noi viviamo sempre lungo il nostro bordo» (Brandalise).
Nell’esperienza, reale o possibile, del contagio, io sono al tempo stesso un individuo e la specie di cui sono parte. D’altronde, come avevano compreso i medici di ispirazione neoplatonica del Cinquecento (da Leoniceno e Fracastoro ad Amato Lusitano), è la stessa dimensione comune degli esseri umani a costituire la possibilità di un contagio infraumano. Questo comune va ricompreso alla luce dello spillover come una dimensione che eccede la specie umana e si estende verso il vivente in quanto tale. Nell’evento del virus si tocca con mano il nostro “essere singolare plurale” di cui scrive Jean-Luc Nancy. Con un diverso linguaggio, non dice cosa diversa Elena Pulcini nel suo proporre un soggetto relazionale come fuoriuscita dal doppio vincolo dell’ossessione dell’Io e ossessione del Noi.
La consapevolezza del contagio pandemico ripropone la necessità di quello che, a proposito di crisi climatica, ho definito nella mia introduzione alla silloge di scritti di Chakrabarty “uno sguardo strabico”. Il mutamento climatico ha per causa e per oggetto al tempo stesso la specie umana, e le classi dominanti che, all’interno del genere umano, ne operano la segmentazione e lo sfruttamento, mettendo in atto quella signoria sul pianeta che causa il riscaldamento globale, i cui effetti si riverberano al tempo stesso sulla specie umana, mettendone in discussione l’esistenza, e in una parte più e meno altrove sui singoli, mostrando una natura classista. Lo stesso accade nella relazione fra il virus e la specie umana, con la differenza che l’azione del virus non risponde a un’intenzione né segue un télos: nondimeno, i suoi effetti si possono ricostruire a posteriori come effetto di una mente intelligente dotata di ragione strumentale, tal quale l’azione del Capitale.
Questa asimmetria rende a sua volta asimmetriche le strategie di lotta al virus: a quello presente, a quelli passati, e a quelli che verranno. Lo scopo di ogni strategia non può essere altro che, preso atto del fatto che questo virus non è troppo debole per esaurirsi da solo, né troppo forte da uccidere in tempo breve i corpi parassitati facendo venir meno le condizioni della sua propagazione, quello di rinchiuderlo in un vicolo cieco, riducendo le sue replicazioni. Per propria natura, infatti, il virus perde filamenti a ogni replica/contagio, ogni volta che, parassitando la vita altrui, passa dalla potenza di essere all’esistenza in atto, cioè in altro. Consentire al virus di moltiplicare le sue repliche, ciascuna delle quali è una variante casuale, significa rendere più probabile la comparsa di varianti più virulente, casualmente resistenti agli attuali vaccini. La vaccinazione, riducendo in modo evidente la possibilità di contagio, la virulenza del contagio, e la trasmissibilità per contagio, agisce come la Grande Falciatrice nell’immagine della natura di Jay Gould, che pota il proliferare senza scopo del vivente. Chi si vaccina agisce come se considerasse se stesso come campione dell’umanità, rivolgendo all’umanità intera il beneficio di cui è qui e ora ricettore. Riprendendo il concetto kantiano: chi si vaccina avendo questo scopo, e non per semplice paura o per una qualsivoglia convenienza, è un soggetto morale, ossia, con una terminologia a noi più consona, vive il comune nel comune. Questo vivere il/nel comune assume la forma della cura.
Al contrario, le soluzioni che privilegiano la centralità del soggetto individuale – in particolare quelle che mettono al centro la possibilità di guarigione dopo aver contratto il virus tramite l’uso di farmaci, non importa se di reale efficacia o frutto di quella peste del linguaggio che ripropone in forme pseudoscientifiche quegli esorcismi simbolici che «danno orizzonte a pulsioni inconsce e alle reazioni che esse suscitano nella coscienza individuale» (De Martino) – non agiscono sulla replicazione del virus, ma solo sul corpo del soggetto afflitto. Come che sia, si tratta di soluzioni improntate a un egoismo individualista, che ritaglia una centralità allucinatoria del soggetto dal tessuto dell’umanità e del vivente e non sente la necessità di una cura del mondo – di quel mondo nel quale esistono le altre e gli altri. Questa asimmetria rende non equivalenti e non equiparabili le possibili soluzioni che scaturiscono da una cosiddetta “libertà vaccinale”, riproponendo i paradossi etici della relazione fra il singolo e il tutto di cui è piena la tradizione liberale. Peraltro, l’individualismo egoistico, pur non essendo responsabile delle condizioni di classe che rendono la società ingiusta, nel non porsi come compito l’estinzione del virus in quanto tale si rende moralmente complice delle ingiustizie di classe che il virus, nelle attuali condizioni e in attesa di un tempo futuro nel quale queste ingiustizie saranno sovvertite o comunque sanate, perpetua e aggrava.
La cosiddetta libertà di scelta vaccinale manifesta una concezione possessiva, proprietaria della salute e del sé, percepiti come “propri”; ma soprattutto, è una concezione proprietaria della libertà, concepita come un bene di possesso. Ma la libertà, come ci ricorda Nancy (e lo ripete Di Cesare) «non è una proprietà che dobbiamo dimostrare di possedere»: «non è la libertà ad appartenermi, sono piuttosto io che appartengo alla libera invenzione di un proprio sempre a venire, sempre ad agire e a sentire tanto a lungo quanto io vivo» (Nancy). Pensare la libertà senza alcuna proprietà né semplice identità, in relazione con tutto ciò che l’idea di libertà semplice e pura esclude per potersi pensare nella sua astrazione, è un compito del pensiero filosofico a venire.
Adriano Prosperi, con un semplice tratto di penna, ha stigmatizzato certi filosofi in tempo di virus, i cui pensieri «viaggiavano ad altezza tale da non percepire il suolo del presente su cui camminava[no]». Oggi il bando per le 500 figure professionali richieste per l’attuazione del PNRR ci informa che non sono richiesti filosofi, né più in generale artisti, letterati o pensatori delle discipline cosiddette umanistiche. È una buona notizia per la filosofia e le/i filosof@: liberata dalla presunzione di poter essere utile alla ristrutturazione capitalistica in atto, forse la filosofia potrà sfruttare il tempo liberato per ripiantare i piedi in terra e alzare lo sguardo alle questioni che la sindemia pone non al presente, ma al futuro.
I paradossi del rapporto individuo/gruppo diventano ancor più evidenti se si passa al piano giuridico, cioè di quell’ordinamento che esprime, con una propria peculiare logica, l’ordine capitalistico del mondo. La compresenza di “essere singolare plurale” è infatti inesprimibile nella logica giuridica. Questa impossibilità non è un accidente o un errore della ragione calcolante, ma è connaturata all’essenza stessa del diritto, inteso come «categoria storica che corrisponde a una struttura sociale determinata, impiantata sulla contraddittorietà degli interessi privati e non già come una attinenza della astratta società umana». L’essere umano, infatti, «si muta in soggetto giuridico in forza di quella stessa necessità per la quale il prodotto naturale [e lo stesso essere umano, una volta ceduta la sua capacità di trasformare il mondo in cambio di un salario] si trasforma in merce dotata della enigmatica qualità del valore» (Pašukanis). Se Pašukanis ha osato pensare all’estinzione del diritto, è perché ha cercato di pensare la relazione infraumana al di fuori di quell’analitica del potere che si fonda sulle condizioni di produzione e circolazione delle merci, a loro volta fondate sulla ingiusta riduzione della potenzialità dell’essere umano in mero portatore di forza lavoro: cioè della riduzione dell’umano a cosa di cui si può fare scambio commerciale.
Peraltro, il diritto è in grado di pensare la prevalenza dell’interesse collettivo su quello individuale senza ricorrere alla volgarità dell’immagine pugilistica della mano che trova limite nel naso altrui. A titolo di esempio, una volta ammessa l’esistenza di diritti senza soggetto quali quelli afferibili all’ambiente, nessuna persona ragionevole sosterrebbe la limitazione della mia libera volontà nel divieto di sversare il carburante del mio catamarano in mare. Volendo volare più alto, si ricorderà che la necessità della rivoluzione era posta dall’impossibilità pratica di lasciare alla libera scelta individuale la destinazione della ricchezza sociale prodotta nella ripartizione (evangelico-marxiana) secondo le necessità di ciascuno, piuttosto che lasciarla all’espressione dei rapporti di forza esistenti.
Tornando al diritto: l’impossibilità di pensare l’essere singolare plurale fa sì che la composizione di questi termini non possa che avvenire nella forma della coercizione, cioè della normatività impositiva. Anche la soluzione di apparente buon senso (prefigurata dal documento dell’OMS COVID-19 and mandatory vaccination: Ethical considerations and caveats) che all’imposizione di un obbligo assoluto di complicata attuazione sostituisce una serie di strategie di persuasione, si configura come una forma addolcita o smussata di coercizione. A meno di non voler porre sullo stesso piano la necessità della vaccinazione e le tesi, complottistiche o negazioniste, antivaccinali – il che sarebbe l’equivalente dell’equiparazione fra evoluzionismo e creazionismo, o sfericità della Terra e terrapiattismo –, un’adeguata strategia comunicativa orientata alla persuasione deve di necessità far prevalere, con ogni mezzo retorico necessario, una tesi sull’altra.
In sintesi: il carattere comunque coercitivo, non importa di quale grado, delle diverse soluzioni consegue dall’astrazione che isola dal con-essere dell’essere singolare plurale un soggetto individuale distinto dal comune. Su questa astrazione si fonda il diritto: questo è un fatto ineludibile.
Compito della filosofia, e in generale di quella prassi che è l’esercizio del pensiero, dovrebbe allora essere non l’impiccarsi in categorie politico-giuridiche ripercorse a ritroso (peraltro con capacità nulla di influire sulle decisioni reali), ma l’esercizio di un pensiero all’altezza delle crisi in atto. Un pensiero che sappia pensare la crisi, e il collocarsi delle soggettività al suo interno, al di fuori delle categorie giuridiche. Pensare la cura e la giustizia, la relazione infraumana e interna al vivente, in forme nuove, non giuridico-normative, sulla base di una rinnovata ontologia della potenza di essere piuttosto che della coppia essere/non essere.
Un pensiero della crisi è possibile solo assumendo delle pratiche che contengano al proprio interno il riflesso di ciò che si intende pensare. Quindi pensare la cura all’interno di una pratica della cura liberata dal “lavoro di cura”, che prefiguri nuove istituzioni in soluzione di continuità con quelle esistenti (sanità per tutti, welfare sociale, reddito universale, diritto all’istruzione universale, libertà di circolazione dei corpi e delle menti, ecc.). Pur nella devastazione sociale aggravata dalla sindemia, esperienze di cura, mutualismo e sostegno si sono date, a riprova della loro possibilità.
Il fine ultimo di queste prassi deve essere posto nell’attivazione di condotte, attitudini, inclinazioni, abitudini che prefigurino un’intelligenza di specie: che all’assenza di tale intelligenza, di cui manca la specie umana che, con le sue condotte, mette a repentaglio la propria sopravvivenza sul pianeta, supplisca con l’interiorizzazione di condotte che abbiano l’effetto di un’intelligenza di specie.
Pur essendo intrecciata ad altre tre crisi – ecologica, economico-finanziaria e migratoria – la crisi pandemica ha una sua propria specificità. La peste accompagna infatti il pensiero umano da quasi 25 secoli, con una presenza simbolica all’interno dell’immaginario indipendente dai suoi aspetti medico-biologici. Come nella letteratura sul tarantismo esaminata da De Martino, una comprensione della peste ridotta a malattia amputa le manifestazioni della sua autonomia culturale. Ma un simbolo non si esaurisce nell’oggetto di cui promette l’acquisizione. Si tratta quindi di ripercorrere la storia di questa autonomia simbolica della peste in alcuni testi che, per la sola presenza di questo elemento, assumono valore di “classici”. Se ne trarrà una categorizzazione epistemologicamente afferibile agli a priori storici foucaultiani, che sottende le differenti narrazioni e, nel suo svolgersi, delinea una comprensione dell’umano all’interno della crisi del suo essere nel mondo. Questa analisi critica si configura come un esercizio di benjaminiana politicizzazione dell’estetica.