di GIROLAMO DE MICHELE.
La prima parte è qui
Si tratta dunque di mettere in fila una serie di “classici” accomunati in prima battuta dall’aver prodotto un discorso sulla peste. Ne emergerà una sorta di schema, costituito da un certo numero di categorie discorsive che ricorrono, ciascuna nella maggior parte, alcune in tutti, questi testi: (i) un discorso ammonitorio sulla fragilità e vulnerabilità dell’umano; (ii) un discorso scientifico sulla natura della peste; (iii) uno sul crollo delle fondamenta e istituzioni della vita civile; (iv) la coppia apocalisse/rifondazione, ovvero la diade, dedotta da De Martino, sul mondo che può/deve finire; (v) l’alternativa fra invarianza antropologica e metamorfosi dell’umano; (vi) un discorso sulla trasformazione delle cose, che potrebbe essere ricondotto alla coppia defunzionalizzazione/ rifunzionalizzazione dedotta dallo studio di Francesco Orlando sui resti e gli scarti nella letteratura; infine, (vii) la peste del linguaggio, che è al tempo stesso discorso e metadiscorso. Queste categorie non sono a compartimenti stagni, ma hanno rimandi interni che costituiscono una mappa complessa: poiché si giunge ai contemporanei, alcuni dei quali tutt’ora viventi, questa mappa è anche uno schema descrittivo della tarda modernità, nell’epoca che conosce la prima crisi pandemica.
Una mappa, dunque; e uno schema categoriale. Non avrebbe senso negare il debito col già citato testo di Orlando, ineguagliabile stella polare di questa ricerca. Nondimeno, lo schema che qui si cerca di tracciare non è costituito da strutture a priori, ma descrive delle trasformazioni, degli slittamenti, degli smottamenti che rimandano alle pratiche costitutive delle periodizzazioni storiche. Per fare un esempio: la defunzionalizzazione/ rifunzionalizzazione delle cose si manifesta in alcuni autori moderni (King, Atwood, McCarthy) come un discorso sulle merci che in un modo post-apocalittico perdono il loro valore di scambio e ridiventano cose a disposizione, fruibili senza scambio. Dunque, un discorso sulla società delle merci, e sulla possibilità di un diverso rapporto fra cose ed esseri umani. Un tale discorso è reso possibile solo da un certo momento della storia, quello nel quale, per citare un celebre incipit, «La ricchezza delle società nelle quali predomina il modo di produzione capitalistico si presenta come una “immane raccolta di merci”, e la merce singola si presenta come sua forma elementare» (Karl Marx, Il Capitale, vol. I, cap. 1: La merce). Una simile considerazione non sarebbe possibile in Lucrezio o Machiavelli. Si tratta allora di individuare una produzione di a priori storici, così come Foucault li ha esposti nelle pagine iniziali di Le parole e le cose, libro che, com’è noto, non parla ne delle une né delle altre, ma delle relazioni che fra loro intercorrono.
Quando instauriamo una classificazione consapevole, quando diciamo che il gatto e il cane si somigliano meno di due levrieri, anche se entrambi sono addomesticati o imbalsamati, anche se entrambi corrono come matti, e anche se fanno l’amore, qual è dunque l’elemento di base a partire dal quale possiamo sostenere questa affermazione con piena certezza? Su quale “tavola”, in base a quale spazio d’identità, di similitudini, d’analogie, abbiamo preso l’abitudine di distribuire tante cose diverse e uguali? Qual è questa coerenza di cui è facile capire immediatamente che non è né determinata da una concatenazione a priori e necessaria, né imposta da contenuti immediatamente sensibili? Non si tratta infatti di concatenare delle conseguenze, ma, di accostare e isolare, di analizzare, adattare e connettere dei contenuti concreti; nulla di più brancolante, nulla di più empirico (almeno in apparenza) dell’instaurazione d’un ordine fra le cose; nulla che non richieda un occhio più aperto, un linguaggio più fedele e meglio modulato; nulla che non esiga con maggiore insistenza che ci si lasci portare dalla proliferazione delle qualità e delle forme. Eppure un occhio non esercitato potrebbe certamente accostare talune figure simili distinguendone altre in ragione di questa o quella differenza; in realtà non esiste, nemmeno per l’esperienza più ingenua, nessuna similitudine e distinzione che non siano il risultato di un’operazione precisa e dell’applicazione d’un criterio preliminare (Le parole e le cose).
Questa storicizzazione consente non solo di parlare dello stato di cose presente nella tarda modernità, ma anche, e soprattutto, di mostrare una evoluzione delle pratiche, discorsive e non. Di mostrare che l’epoca presente non è il punto più basso di una lunga decadenza, come sostiene un certo decadentismo che riemerge periodicamente, con esiti discutibili: il principale dei quali è di mancare del tutto la comprensione di quella modernità che si vorrebbe stigmatizzare.
 Un altro esito di questa lettura è saggiare, attraverso alcuni campioni, lo stato dell’arte della fantascienza contemporanea, quantomeno nella sua variante dis-utopistica, nell’epoca in cui con diversi approcci è stata teorizzata, o quantomeno paventata, la sua impossibilità (quantomeno a partire da Antonio Caronia nel 1992). Chiedersi a cosa faccia segno la persistente presenza della fantascienza, e dunque la sua fruizione, è un interrogarsi camminando sulla strada tracciata da Mark Fisher (e Simon Reynolds): ovvero, cercare di prolungare la riflessione di Fisher oltre Fisher, di pensare con su di lui, ma come lui.
Un altro esito di questa lettura è saggiare, attraverso alcuni campioni, lo stato dell’arte della fantascienza contemporanea, quantomeno nella sua variante dis-utopistica, nell’epoca in cui con diversi approcci è stata teorizzata, o quantomeno paventata, la sua impossibilità (quantomeno a partire da Antonio Caronia nel 1992). Chiedersi a cosa faccia segno la persistente presenza della fantascienza, e dunque la sua fruizione, è un interrogarsi camminando sulla strada tracciata da Mark Fisher (e Simon Reynolds): ovvero, cercare di prolungare la riflessione di Fisher oltre Fisher, di pensare con su di lui, ma come lui.
Infine, e soprattutto: tematizzare e mettere a critica la persistenza della peste nell’immaginario contemporaneo significa provare a fare i conti con il valore simbolico della peste nelle sue mutevoli presenze. Compreso il suo essere un simbolo irrisolto che ritorna in forma allucinatoria.
Quali i criteri che delimitano a poco più di una decina i testi scelti? In primo luogo, una certa arbitrarietà, che si giustifica a posteriori nella confermata presenza delle categorie sopra indicate. Al tempo stesso, una certa ricchezza dei testi, che devono contenere un certo numero di categorie, rispetto ad altri, che mostrano un solo aspetto, anche se in modo esemplare. Elenco e contenuti si costruiscono reciprocamente, dunque. A partire da un canone che si costituisce nella classicità (Tucidide, Lucrezio, Boccaccio), per poi essere ereditato e modificato dalla modernità (inaugurata da Machiavelli). Canone che trova la sua più completa categorizzazione “classica” in Lucrezio: che ne è l’autore, il punto di origine che, con quel movimento a vortice individuato da Benjamin nel suo studio sul dramma barocco, retroagisce sul passato attirando a sé materiali preesistenti. Basti, per il momento, tener presente che la lezione epicurea, cioè il discorso scientifico, strappa il “vivere alla ventura” (eikê zên: Edipo tiranno, v. 179) di Giocasta dalla disperazione, risignificandolo in un precetto della serena saggezza stoica: opposizione della scienza, che non richiede un’arte per liberare l’animo dal dolore, alla tyche.
Accanto a Lucrezio, emergeranno Stephen King e Margaret Atwood come i soli autori capaci di contenere all’interno dei propri testi l’intera gamma delle categorie. Questa completezza, rispetto a titoli e nomi di maggiore reputazione, comporta delle conseguenze sulla collocazione di questi autori nei canoni della modernità, che si lasceranno volentieri ai patiti di classificazioni.
Madamina, il catalogo è questo, infine: La guerra del Peloponneso (II, 47-54) di Tucidide; De rerum natura (VI, 1090-1286) di Lucrezio; Decameron (I giornata, Introduzione) di Boccaccio; Epistola sulla peste e Discorsi (II, 5) di Machiavelli; I Promessi sposi di Alessandro Manzoni; La peste di Albert Camus; Cecità di José Saramago; The Stand di Stephen King; La strada di Cormac McCarthy; la Trilogia del MaddAddam di Margaret Atwood; Contagion di Steven Soderbergh; La notte si avvicina di Loredana Lipperini.
La peste del linguaggio è un enunciato che deve a Italo Calvino la sua compiuta enunciazione, nelle Lezioni americane: «Alle volte mi sembra che un’epidemia pestilenziale abbia colpito l’umanità nella facoltà che più la caratterizza, cioè l’uso della parola, una peste del linguaggio che si manifesta come perdita di forza conoscitiva e di immediatezza, come automatismo che tende a livellare l’espressione sulle formule più generiche, anonime, astratte, a diluire i significati, a smussare le punte espressive, a spegnere ogni scintilla che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove circostanze». Accanto al linguaggio, anche le immagini sembrano essere colpite dalla peste: una pioggia ininterrotta di immagini, per lo più «prive della necessità interna che dovrebbe caratterizzare ogni immagine, come forma e come significato». Una nuvola d’immagini che, dissolvendosi, lascia «una sensazione d’estraneità e di disagio», che rimanda alla condizione di vulnerabilità: la peste, conclude Calvino, non è solo nelle immagini o nel linguaggio, «è nel mondo».
Nello scrivere questo controcanto all’esattezza, Calvino tirava le fila di una lunga discussione avviata da Pasolini sulla comparsa di un’antilingua all’interno del discorso politico (1964), e proseguita negli ultimi scritti del 1975 (Il vuoto del potere, Il processo). Inizialmente, Calvino assume una posizione interlocutoria, chiedendosi se ci siano risorse da cogliere anche nell’antilingua; con posizione in apparenza defilata, Sciascia è invece concorde con Pasolini sin dalla scrittura del testo teatrale L’onorevole, e poi nei testi che ruotano attorno alla figura di Aldo Moro. Con le Lezioni americane, quindi, Calvino converge sul pessimismo pasoliniano: una conversione che porta con sé il discorso politico come manifestazione di questa pestilenza.
Il 18 maggio 2008 Javier Marías su “El País”, in un elzeviro intitolato Brutta e povera Italia, ha lanciato l’allarme sull’involgarimento del linguaggio della comunicazione politica che stava pervadendo l’Europa. Guardando all’Italia, alla Polonia, alla Francia, Marías si era accorto dell’uso di un linguaggio senza freni che tracimava dai talk show ai dibattiti politici televisivi. E commentava:
Quello che sta succedendo in Italia – e prima in Polonia, con i gemelli Kaczynski – è molto preoccupante. Siamo in presenza di politici vincenti che hanno abbattuto la frontiera tra ciò che si può e ciò che non si può dire in pubblico. Hanno scelto di parlare e comportarsi come molti dei loro elettori, con la differenza che questi possono farlo solo in privato. Una forma superiore di demagogia consiste nel non limitarsi a dire al popolo quello che questi desidera sentire, ma addirittura nell’adottarne i discorsi e il vocabolario brutale che fino a ieri erano confinati solo nel privato, e in tal modo legittimarli. “Quello che tu dici a bassa voce io lo dico ad alta voce, davanti alle telecamere e ai microfoni, e così ti autorizzo e ti adulo. Guarda: io sono in tutto e per tutto come te, e per di più non mi nascondo. Non nasconderti neanche tu: vieni fuori, e votami!”.
Questo testo congiunge Calvino all’oggi, nell’indicare il punto di arrivo di questa pestilenza.
Il testo di Calvino ha tuttavia un importante antecedente, non importa quanto consapevole. È Slavoj Žižek ad indicarcelo intitolando un suo libro del 1996 The Plague of Fantasies (in italiano La peste dell’immaginario): un sintagma tratto dal Secretum di Petrarca, «hinc pistis illa fantasmatum», quella peste dei fantasmi [=delle rappresentazioni sensibili] «che si accanisce a rovinarti, se non vi poni rimedio». A sua volta il poeta deriva questa peste delle immagini dalla meditazione sul De vera religione di Agostino:
Le rappresentazioni, a loro volta, non sono altro che immagini ricavate dalla forma corporea mediante i sensi. È facilissimo ricordarle così come le abbiamo ricevute oppure, mediante il pensiero, dividerle, moltiplicarle, riunirle, ampliarle, metterle insieme, scompigliarle o dar loro qualunque forma, mentre è difficile liberarsene completamente quando si cerca la verità (X, 18).
È plausibile che Petrarca abbia scritto il Secretum all’ombra della strage epidemica che nel 1348 gli strappa non solo Laura, ma anche diversi amici: sicché è lecito affermare che nel testo siano presenti profonde cicatrici di una meditazione della morte per peste di cui il poeta è stato testimone. Una meditazione che si congiunge al testo di Boccaccio (le «diverse paure e immaginazioni in quegli che rimanevano vivi»), e aggiunge il tema della peste del linguaggio al discorso ammonitorio sulla caducità e mortalità già presente nel magistrale Trionfo della Morte dipinto un decennio prima della Peste Nera da Buonamico Buffalmacco sul muro del Camposanto monumentale di Pisa.
Se Boccaccio recupera dai classici il tema della dissoluzione delle istituzioni civili, che in Lucrezio e Tucidide si accompagna all’oblio, è García Marquéz ad averci dato la più espressiva figurazione del nesso fra peste e oblio, con la peste del insomnio che, nel terzo capitolo di Cien años de soledad, coglie il villaggio di Macondo costringendo gli abitanti a riscrivere ogni relazione fra parole e cose, fino al momento in cui Melquíades porta al villaggio la cura. A José Arcadio il mondo al tempo dell’oblio appare come un salotto assurdo in cui gli oggetti sono vincolati alle etichette, e queste alle «solemnes tonterías» scritte sulle pareti.
Dobbiamo a Lucrezio il nesso fra l’oblio e il guazzabuglio assurdo e insensato. Lo mostra Michel Serres, nel suo studio decisivo, seppur molto discusso, al quale tuttavia non c’è ragione di non prestar fede: perché mai dovremmo credere che Lucrezio non fosse a conoscenza, se non dei testi oggi perduti, dell’epistemologia del proprio tempo, da Democrito ad Archimede, fino allo stesso Epicuro, e attribuire a casuali coincidenze la presenza di una salda episteme nel suo poema? In ogni caso, un’episteme atomista è sottesa al suo poema, e questo basta (in questa sede: bisognerà mostrare come questa visione scientifica razionalistica sia assunta dalla letteratura latina posteriore, a cominciare da Virgilio). Dunque: la caduta degli atomi è senza memoria, senza codice, perché «la natura non codifica l’universale». Parimenti, l’infinita combinazione casuale di lettere non produce (a differenza delle cifre) senso: siamo noi a selezionare, codificare, costretti a farlo per darci un linguaggio, una storia, un diritto. «La storia è una fisica e non viceversa. Il linguaggio è innanzitutto nei corpi» (Lucrezio e l’origine della fisica). Da cui, per converso (rovesciando la genesi federativa di società e linguaggio, VI, vv. 1019-1034), la possibilità di un ritorno alla natura, cioè di una disgregazione degli artefatti civili, nella pestilenza linguistica. Della quale non c’è memoria: peste e oblio sono due facce della stessa medaglia, che si esprimono nell’oblio delle consuetudini civili e nella violazione dei riti funerari (De rerum natura, VI, 1274 ss; che riprende Tucidide, II, 52-53, e ritornerà in Boccaccio, dove «la gran moltitudine de’ corpi» viene stivata «come si mettono le mercantìe nelle navi»).
È cosa notevole che Boccaccio sfiori il divenire merce dei corpi. Ma è a Machiavelli che dobbiamo una consapevole innovazione del tema della disgregazione sociale: «Le pulite e belle contrade, che piene di ricchi e nobili cittadini essere solevano, sono ora puzzolente e brutte, di poveri ripiene; per la improntitudine de’ quali e paurose strida, difficilmente e con timore si va. Sono serrate le botteghe, gli esercizi fermi, i giudicii, o le corti e fori, tolti via, prostrate le leggi. Ora s’intende questo furto, ora quello omicidio: le piazze, i mercati, dove adunarsi frequentemente i cittadini soleano, sepolcri sono ora fatti, e di vili brigate ricettaculi». Fin qui siamo sulla falsariga del Boccaccio: ma, aggiunge il Segretario fiorentino, «I ragionamenti ch’essere solevano in piazza onorevoli e in mercato utili, in cose miserabili e meste si convertono». È la civile conversazione che scompare nelle piazze fattesi sepolcri, dove «gli uomini vanno soli, e in cambio di amici, gente di questo pestifero morbo infetta si riscontra». Queste pagine sono debitrici ai Discorsi non solo dello sfondo di morte e distruzione (II, 5), ma della scoperta della moltitudine come fondamento costituente della civiltà e delle sue istituzioni: è questa scoperta che consente a Machiavelli di qualificare l’inciviltà della peste del linguaggio, comparata ai pubblici ragionamenti. Dunque, di dare una coloritura politica al caos dei segni che precipitano nel vuoto, come i corpi nelle fosse comuni: «i piacevoli ragionamenti che ad ogni ora si sentono», nei quali ricompaiono quei fantasmi («simiglianti nuove, atte con la sola immaginazione a fare Esculapio, non ch’altri, ammorbare») che assillavano Agostino e Petrarca. Dove però la distinzione fra la peste dei fantasmi e il lume della ragione non è data dalla fede, ma dalla persistenza o meno delle istituzioni pubbliche, dalle quali derivano i buoni costumi, secondo l’ordito fra i due capi tessuto dalla spola dei discorsi.
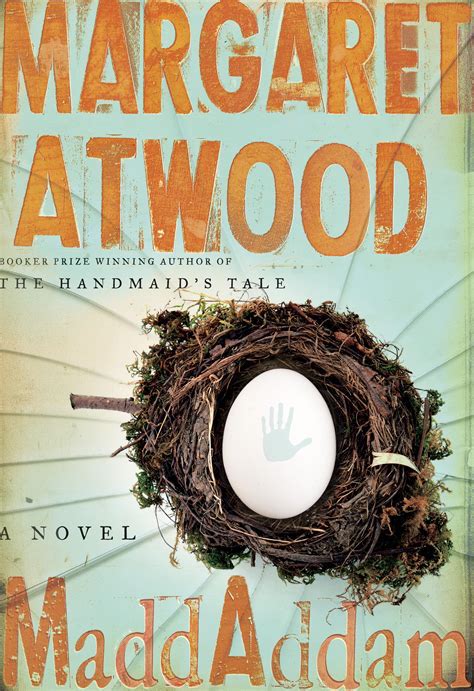 Questa doppia trama del discorso, verso l’intendersi pubblico o il precipitare nel caos, è stata scolpita in modo insuperabile da una sentenza di Manzoni, non a caso riscritta da Gramsci (i cui Quaderni sono un esercizio di meditazione di un’altra peste, e di riscrittura dei foedera naturae): «Il buon senso c’era ma se ne stava nascosto per paura del senso comune». È noto che Manzoni ha lavorato sulle cronache storiche seicentesche, Tadino e Ripamonti in primo luogo. Ma conosce anche (e le reputa le più ricche di informazioni) quelle di Lorenzo Ghirardelli, Il memorando contagio seguito in Bergamo nell’anno 1630 ecc.; laddove è riportato in dettaglio la vicenda del medico bergamasco Girolamo Piscina, che «comprobò con la morte di lui medesimo, che morì di contagio, essendone morti tutti i suoi di casa, esser fallace la sua, & veridica l’altrui sentenza». Piscina fu autore di una lettera, firmata da altri medici, nella quale si metteva in dubbio la peste: ed è possibile che dalle pagine del Ghirardelli sia venuta l’idea di don Ferrante. Come che sia, non nella sola bergamasca o a Milano, ma in ogni luogo in cui arrivò la peste del 1630 le cronache ci attestano simili dispute. Scrive dunque Piscina, al termine di un perverso esercizio di cattiva semiotica, che «nei presenti infermi, con i quali è bene che gli assistenti usino qualche cautela nel servirli, non vi sono le febbri pestilenziali epidemiche, né contagio, ma solamente febbri pestilenziali sporadiche, per le quali non si devono serrare le case degli ammalati, né proibire agli abitanti il pubblico commerciale nemmeno sospendere le robe, o condannarle in altro modo come fonte pestifere, la quale ragionevolmente non si deve temere».
Questa doppia trama del discorso, verso l’intendersi pubblico o il precipitare nel caos, è stata scolpita in modo insuperabile da una sentenza di Manzoni, non a caso riscritta da Gramsci (i cui Quaderni sono un esercizio di meditazione di un’altra peste, e di riscrittura dei foedera naturae): «Il buon senso c’era ma se ne stava nascosto per paura del senso comune». È noto che Manzoni ha lavorato sulle cronache storiche seicentesche, Tadino e Ripamonti in primo luogo. Ma conosce anche (e le reputa le più ricche di informazioni) quelle di Lorenzo Ghirardelli, Il memorando contagio seguito in Bergamo nell’anno 1630 ecc.; laddove è riportato in dettaglio la vicenda del medico bergamasco Girolamo Piscina, che «comprobò con la morte di lui medesimo, che morì di contagio, essendone morti tutti i suoi di casa, esser fallace la sua, & veridica l’altrui sentenza». Piscina fu autore di una lettera, firmata da altri medici, nella quale si metteva in dubbio la peste: ed è possibile che dalle pagine del Ghirardelli sia venuta l’idea di don Ferrante. Come che sia, non nella sola bergamasca o a Milano, ma in ogni luogo in cui arrivò la peste del 1630 le cronache ci attestano simili dispute. Scrive dunque Piscina, al termine di un perverso esercizio di cattiva semiotica, che «nei presenti infermi, con i quali è bene che gli assistenti usino qualche cautela nel servirli, non vi sono le febbri pestilenziali epidemiche, né contagio, ma solamente febbri pestilenziali sporadiche, per le quali non si devono serrare le case degli ammalati, né proibire agli abitanti il pubblico commerciale nemmeno sospendere le robe, o condannarle in altro modo come fonte pestifere, la quale ragionevolmente non si deve temere».
Le cronache del tempo attestano l’incredulità del colto e dell’incolto, vale a dire della plebe e dei nobili, e ne testimoniano le conseguenze. La penna di Manzoni ci dà una descrizione che richiama, in filigrana, l’avvenuta costituzione della società civile e della pubblica opinione nella Lombardia dell’Ottocento, retrospettivamente proiettate sulla città seicentesca. Opinione pubblica della quale Manzoni diffida: il che non gli impedisce di descriverne le dinamiche, tal quale Dante con la borghesia duecentesca. Fra la Storia della colonna infame e l’esemplare figura del propalatore di veritiere fandonie che nell’osteria racconta di Renzo davanti a Renzo senza (ri)conoscerlo, l’incredulità si fa negazione, e la negazione si rovescia nella credenza nei complotti orditi a distanza dal Richelieu («Tutte cabale ordite da’ navarrini, da quel cardinale là di Francia»): vediamo così comparire due aspetti congiunti di questa peste che di diffonderanno per tutta la tarda modernità, dall’Affaire Dreyfuss al negazionismo in tema di virus. L’accusa di Croce e Nicolini di antistoricismo del Manzoni appare, per ragioni ben diverse da quelle lanciate degli idealisti italiani (peraltro, con un piede impigliato nel garbuglio della giustificazione storica della peste fascista), fondata: la propagazione delle dicerie, e la corrività che la facilita (“corrività nel credere è facilità, ma non sempre credulità”: Tommaseo), emergono con modalità peculiari – come a priori storicamente determinati, per l’appunto – nell’epoca dell’opinione pubblica. Sicché è fuor di dubbio che Manzoni parli del Seicento, cioè del passato, perché l’Ottocento, cioè il presente, intenda:
Questa corrività a credere senza prova attentati contra il publico, contra una parte di esso, ad attribuire alle persone fatti e parole immaginarie è una piaga viva tuttodì; e dico viva nei popoli più colti, e dico anche negli uomini più colti di questi popoli. È cosa strana e trista che nelle cose contemporanee anche molti uomini colti si accontentino di ragioni che gli farebbero ridere applicate in una storia ad avvenimenti lontani. Nei nostri tempi in cui i fatti si sono affoltati con una terribile celerità, è incredibile l’influenza che hanno avuta in essi queste opinioni così leggermente ricevute: le più inverisimili son divenute spesso norma infallibile, impulso potente di condotta e di azioni: effetti terribili di cause immaginarie, furono poi cagioni di azione pur terribile, vasta, e prolungata (Fermo e Lucia, IV, IV).
Non si può fingere di non vedere l’elefante nella biblioteca – ovvero ignorare il grumo irresolubile di questioni incarnate dal primo appestatore: Edipo. Col quale bisognerà fare i conti, a partire da una doppia biforcazione che si apre a partire dalla sua figura: la pretesa di un sapere “tecnico”, moderno – il sapere di Edipo (Foucault) – di saperne di più del sapere “tradizionale”; e l’alternativa fra Seneca e Sofocle, fra «un mondo che s’illude di poter essere guarito dalla peste che ospita la violenza e tuttavia s’illude di poterne guarire come da una malattia passeggera», e «un mondo che sa di non poter espellere la propria ferita, che è violento e sa di esserlo» (Giuseppe Serra, Edipo e la peste). Ai margini – meglio, sui limiti di queste biforcazioni, nei territori intermedi delimitati dalle loro linee di fuga, trova spazio la peste del linguaggio: basti pensare, come primo esempio, alla speranza di una società guarita dalla violenza che dalla quiete interiore di Seneca si rovescia nel male dispiegato nella Las Vegas governata da Randall Flagg (The Stand).
Quanto ai limiti succitati: essi concernono il dire della posizione dell’essere umano nel mondo, ovvero la sua nuova finitezza che si apre mentre l’illuminismo è alla sua acme. Una finitezza costituente, concatenata con la nuova veste della conoscenza scientifica, che non illumina più il mondo conferendo serenità allo sguardo del sapiente, ma assume le sembianze di una novella Melancolia (e vale la pena ricordare che l’incisione di Dührer era coeva al sereno incedere dei filosofi nella Scuola di Atene): il che ripropone la necessità di un’arte (techne alypias, quale Leopardi deduce da Epitteto) per liberare l’animo dal dolore e sopportare il “caso”, “un dato di fatto al quale ogni mortale è esposto” (Susanetti, Catastrofi politiche).
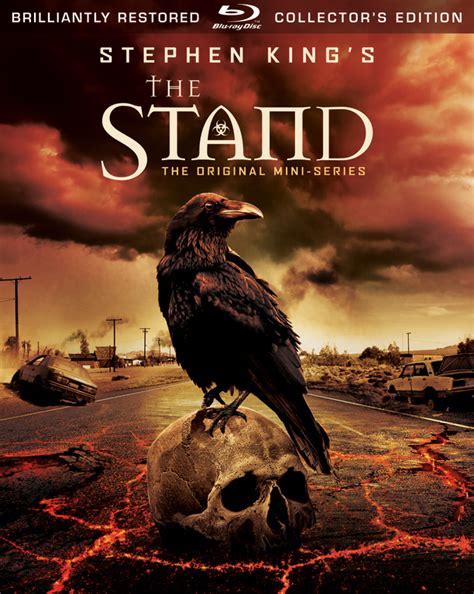 La narrazione tardomoderna della pestilenza ci offre una ricca fenomenologia delle sue manifestazioni linguistiche: non potrebbe essere diversamente, in un’epoca consapevole che l’essere linguistico è, accanto all’essere vivente e all’essere produttore di valore, una delle peculiarità che definiscono l’essere umano, e che nondimeno non gli appartengono. Fra queste, esemplare è la figura dell’appestatore come diffusore di fake news esemplificata in Contagion da Alan Krumwiede, il blogger propagatore della falsa cura a base di forsizia: il cui successo, a dispetto della comprovata falsità delle sue parole, lascia presagire una futura carriera politica. Carriera che intraprende in The Stand Harold Lauder: le cui parole hanno l’effetto di sedurre e orientare le assemblee nelle quali la comunità di Boulder avvia la ricostruzione della comunità. Harold Lauder, emissario volontario delle forze del male incarnate da Randall Flagg, resta sempre nell’ombra, senza assumere alcun incarico politico: il che ne fa un vero e proprio anello di congiunzione fra Alan Krumwiede e Greg Stillson, il politico de La zona morta che, con l’uso suadente della retorica politica, sembra destinato alla Presidenza degli USA (si ricorderà che nel periodo della presidenza Trump Stephen King ha svolto una vera e propria attività militante sul social contro l’allora presidente). Una variante solo in apparenza meno politica – a patto di dimenticare i testi di Calvino e Marías da cui siamo partiti – è quella dei personaggi femminili di La notte si avvicina: dalle madri feroci che espellono la “diversa” Maria, alla parola come strumento di controllo del paese di Vallescura da parte dell’anziana Saretta. Che invece sia una funzione pienamente politica del linguaggio, e non un suo uso privato, appare evidente se si consideri che la produzione di odio nella comunicazione immateriale presuppone l’esistenza di uno spazio pubblico, seppure social (Loredana Lipperini è co-autrice di Morti di fama, sul lato oscuro della rete); e che l’agire di Saretta ha per scopo la preservazione dello stato di cose esistente, tal quale la Concetta Cupiello della tragedia (che di tragedia, e non di dramma o commedia, si deve parlare) di Eduardo De Filippo – che col nascondimento, la mezza parola, la bugia a fin di bene cerca di preservare dalla catastrofe l’ordine patriarcale della famiglia che sta franando sotto i suoi piedi (oscillazione della fine del mondo fra la paura e la possibilità del suo accadere).
La narrazione tardomoderna della pestilenza ci offre una ricca fenomenologia delle sue manifestazioni linguistiche: non potrebbe essere diversamente, in un’epoca consapevole che l’essere linguistico è, accanto all’essere vivente e all’essere produttore di valore, una delle peculiarità che definiscono l’essere umano, e che nondimeno non gli appartengono. Fra queste, esemplare è la figura dell’appestatore come diffusore di fake news esemplificata in Contagion da Alan Krumwiede, il blogger propagatore della falsa cura a base di forsizia: il cui successo, a dispetto della comprovata falsità delle sue parole, lascia presagire una futura carriera politica. Carriera che intraprende in The Stand Harold Lauder: le cui parole hanno l’effetto di sedurre e orientare le assemblee nelle quali la comunità di Boulder avvia la ricostruzione della comunità. Harold Lauder, emissario volontario delle forze del male incarnate da Randall Flagg, resta sempre nell’ombra, senza assumere alcun incarico politico: il che ne fa un vero e proprio anello di congiunzione fra Alan Krumwiede e Greg Stillson, il politico de La zona morta che, con l’uso suadente della retorica politica, sembra destinato alla Presidenza degli USA (si ricorderà che nel periodo della presidenza Trump Stephen King ha svolto una vera e propria attività militante sul social contro l’allora presidente). Una variante solo in apparenza meno politica – a patto di dimenticare i testi di Calvino e Marías da cui siamo partiti – è quella dei personaggi femminili di La notte si avvicina: dalle madri feroci che espellono la “diversa” Maria, alla parola come strumento di controllo del paese di Vallescura da parte dell’anziana Saretta. Che invece sia una funzione pienamente politica del linguaggio, e non un suo uso privato, appare evidente se si consideri che la produzione di odio nella comunicazione immateriale presuppone l’esistenza di uno spazio pubblico, seppure social (Loredana Lipperini è co-autrice di Morti di fama, sul lato oscuro della rete); e che l’agire di Saretta ha per scopo la preservazione dello stato di cose esistente, tal quale la Concetta Cupiello della tragedia (che di tragedia, e non di dramma o commedia, si deve parlare) di Eduardo De Filippo – che col nascondimento, la mezza parola, la bugia a fin di bene cerca di preservare dalla catastrofe l’ordine patriarcale della famiglia che sta franando sotto i suoi piedi (oscillazione della fine del mondo fra la paura e la possibilità del suo accadere).
La speranza che un mondo che può finire (e forse lo merita) non finisca, risignifica modernamente l’oblio come manifestazione della peste del linguaggio. In tal senso, il linguaggio delle «cose miserabili e meste» in Camus è non un effetto, ma l’acqua stessa in cui i pesci nuotano, e le precise parole sono al più un’aspirazione che richiede una lotta continua: «j’ai compris que tout le malheur des hommes venait de ce qu’ils ne tenaient pas un langage clair. J’ai pris le parti alors de parler et d’agir clairement, pour me mettre sur le bon chemin», afferma Tarrou. Questo oblio militante che si manifesta presente nelle folle populiste, è come il bambino che gioca la manipolazione di presenza e assenza per sottrarsi all’esperienza di cui dovrebbe farsi carico: «Sostituisce alla tensione dolorosa generata dall’esperienza inevitabile della presenza e dell’assenza dell’oggetto amato, un gioco attraverso il quale lui stesso manipola l’assenza e la presenza in quanto tali e si compiace di comandarle» (Lacan, Il seminario I).
È Margaret Atwood a darci la più ampia gamma di usi del linguaggio, e fra questi della sua funzione pestilenziale all’interno di un mondo a cavallo di una pestilenza che azzera quasi totalmente l’umanità, e con essa la civiltà. La trilogia del MaddAddam può essere letta come un trattato sulla relazione fra cose e parole. Qui basti introdurre un tema esemplificato da una citazione del terzo volume:
C’è la storia, poi c’è la storia vera, poi c’è la storia di come la storia viene raccontata. Poi c’è quello che si lascia fuori dalla storia. Che fa anch’esso parte della storia (L’altro inizio, p. 82).
Qui la peste del linguaggio, intesa come possibilità di falsificazione della (narrazione della) storia, si intreccia con tutte le categorie del canone, a partire dal crollo delle fondamenta e istituzioni della vita civile, e dalla loro rifondazione. Non è detto che si debba attendere il crollo catastrofico di queste istituzioni per una loro radicale rifondazione: un compito al quale vale la pena di dedicare la vita che ci avanza, quantomeno come viatico per quella serena vecchiaia che Deleuze si augurava nel pianificare i libri per la propria restante vita, che sapeva non essere lunga.

















