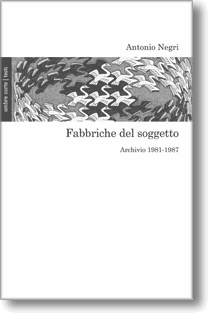di UGO ROSSI. Le elezioni amministrative del 2016, in particolare quelle di Roma e Torino, hanno consacrato definitivamente l’ascesa politica del Movimento 5 Stelle, senza dubbio la principale espressione in Italia del fenomeno politico oggi comunemente noto come “populismo”. A differenza delle formazioni politiche apertamente schierate a destra (come la Lega Nord e i partiti eredi della destra fascista) che rivendicano con orgoglio posizioni di nazionalismo identitario e perfino razzista, sin dalla sua apparizione il Movimento 5 Stelle ha preferito tenere un atteggiamento cauto e ondivago sui temi più delicati che dividono l’opinione pubblica, come l’immigrazione, in linea con il suo orientamento “bipartisan” volto a raccogliere consensi lungo tutto l’arco dello spettro politico.
Tuttavia, a dispetto della vaghezza e ambiguità di posizioni che li contraddistingue, negli ultimi mesi si è assistito a una escalation del discorso anti-immigrati da parte di esponenti di punta dei 5 Stelle. Solo poche settimane fa, il candidato premier in pectore dei 5 Stelle Luigi Di Maio non ha esitato a prendere di mira le organizzazioni non governative impegnate a soccorrere i migranti che attraversano il Canale di Sicilia, definendo sprezzantemente le loro imbarcazioni “taxi del mare”. Lo stesso padre spirituale del Movimento, Beppe Grillo, nei mesi scorsi aveva scosso l’opinione pubblica con messaggi di inedita intolleranza nei confronti degli stranieri che giungono in Italia in modo non autorizzato. In particolare, nel dicembre del 2016, all’indomani degli attacchi terroristici di Berlino, Grillo pubblica un post in cui associa senza mezzi termini il terrorismo all’immigrazione, sostenendo che “la situazione migratoria è ormai fuori controllo” e che dunque è giunto “il momento di proteggerci”. D’altro canto, l’improvviso inasprimento delle posizioni sull’immigrazione non è sorprendente: i leader “pentastellati” sono tentati dalla capitalizzazione in termini elettorali (le elezioni parlamentari sono ormai alle porte) del mai sopito razzismo di una parte significativa, probabilmente maggioritaria, degli italiani.
Gli italiani, a ben vedere, non fanno eccezione nel quadro europeo e occidentale in genere: il razzismo è un tratto costitutivo delle nazioni occidentali, una testimonianza vivente del loro passato e del loro presente coloniale, che riaffiora ciclicamente soprattutto nelle fasi più difficili dal punto di vista economico, come l’elezione di Trump negli Stati Uniti e il voto a favore di “Brexit” in Gran Bretagna hanno evidenziato. Negli Stati Uniti, d’altro canto il razzismo è rimasto soltanto sotto traccia nell’età della colorblindness, della rimozione del colore della pelle dal discorso pubblico, culminata con l’era del mandato presidenziale di Obama in cui, nonostante tutti i proclami di fine della discriminazione, la criminalizzazione degli afro-americani – in particolare la loro detenzione carceraria in massa – è proseguita inesorabilmente. Di qui l’esplosione del “populismo” all’indomani della Grande Recessione di fine anni Duemila e dei primi anni del decennio in corso, fino all’infame Muslim ban emanato da Trump poco dopo il suo insediamento che solo l’intervento di alcuni giudici federali è riuscito a bloccare, almeno temporaneamente. In quanto tale, la crisi economica del 2008 è da considerarsi un momento di svolta, una vera e propria accelerazione, nelle molteplici guerre che il capitale globale, di cui Trump e i conservatori inglesi nonostante gli asseriti disegni isolazionisti sono rappresentanti, ha intrapreso all’indirizzo di minoranze subalterne ritenute nemiche della civilizzazione occidentale come migranti, rifugiati, musulmani (Alliez e Lazzarato, 2016). Le forze populiste, sia che siano già insediate al governo o che aspirino a farlo nel breve periodo, offrono il fianco a tali guerre, ne costituiscono l’espressione apparentemente più spontanea e, ma di certo anche la più efficace nella costruzione del “senso comune” razzista.
La netta sconfitta di Marine Le Pen nel ballottaggio presidenziale segna con ogni probabilità il declino irreversibile del populismo apertamente di destra, non solo in Francia ma ovunque: l’imbarazzante passato delle destre post-fasciste ne impedisce un pieno sviluppo elettorale e le condanna al minoritarismo. Un limite che è in evidente contraddizione con la “vocazione maggioritaria” del progetto populista. D’altra parte, i leader del Movimento 5 Stelle si sono ripetutamente dissociati dalle forze della destra sovranista e nazionalista, nello stesso momento in cui le loro posizioni razziste anti-stranieri hanno cominciato ad affiorare con maggior chiarezza, come abbiamo visto.
Torniamo alle elezioni del 2016. Le “mappe del voto” diffuse all’indomani della vittoria dei due candidati 5 stelle di Roma e Torino evidenziarono un dato inoppugnabile, comune a entrambe le città: il voto per i candidati del centro-sinistra (Giachetti a Roma, Fassino a Torino) era direttamente proporzionale al livello di reddito delle circoscrizioni elettorali, mentre l’inverso valeva per le candidate 5 Stelle (Raggi a Roma, Appendino a Torino); vale a dire, nei quartieri periferici a più basso reddito – compresi quelli con orientamenti storici progressisti – il consenso calava precipitosamente per i candidati di centro-sinistra e si impennava per quelli del Movimento 5 Stelle. Si era dinanzi a una chiara dimostrazione della capacità da parte del Movimento 5 Stelle di catalizzare il voto di protesta nelle aree che hanno più sofferto gli effetti della crisi economica. La geografia del voto a Roma e Torino riproduce a una scala urbana il fenomeno di dualismo socio-territoriale che gli analisti hanno evidenziato a una scala inter-regionale (tra regioni vincenti e regioni perdenti sul piano economico) nelle elezioni presidenziali statunitensi (Trump votato negli Stati più depressi della Rustbelt e delle aree interne, Clinton nelle città più prospere della costa) e nel referendum sulla Brexit in Gran Bretagna (dove le aree deindustrializzate del centro e del Nord dell’Inghilterra hanno votato in larga maggioranza per l’uscita del Regno Unito dalla Unione Europea).
A Torino, la svolta populista era nell’aria da tempo. Negli anni Duemila, con la designazione delle Olimpiadi del 2006, la città sembrava incarnare le speranze di un’Italia che era sul punto di farcela nella difficile sfida della modernizzazione post-industriale. Nel 2010, tuttavia, giunge inattesa la doccia fredda del debito: Torino si scopre il comune più indebitato d’Italia, le politiche di austerità e privatizzazione dei servizi pubblici sono presentate come inevitabili dalla giunta in carica di centro-sinistra. Inoltre la crisi del 2008 ha forti ripercussioni sulla base manifatturiera della città, con significative contrazioni nel numero degli occupati, ma anche nei settori del commercio e dei servizi alle imprese sui quali la città aveva puntato negli anni della “rinascita” post-fordista. Il malcontento sociale che cova sotto le ceneri esplode nel dicembre del 2013. Mentre in altre città italiane le manifestazioni dei cosiddetti “forconi” portano in strada numeri per lo più insignificanti, a Torino esplode una vera e propria rivolta urbana. La città si ferma improvvisamente, senza che sia stato dichiarato alcuno sciopero generale: per due interi giorni gran parte dei negozi cittadini tengono le serrande abbassate in segno di adesione alla protesta (ma anche di paura verso i protestanti stessi), mentre le strade del centro sono attraversate da manifestazioni costellate da bandiere tricolori che sventolano qui e là. Qualche parapiglia con le forze dell’ordine attira l’attenzione dell’opinione pubblica altrimenti distratta e incapace di comprendere un’esplosione di malcontento e risentimento sociale in cui sono assenti sindacati e movimenti sociali da sempre protagonisti di manifestazioni e proteste nella città delle grandi lotte operaie degli anni Sessanta.
La politica populista dell’intolleranza sociale ha una forza di attrazione nei confronti dei partiti tradizionali che nel tempo sembra diventare sempre più irresistibile. Poche settimane dopo il ballottaggio delle comunali, non tutti prestarono la dovuta attenzione alle dichiarazioni inquietanti rilasciate alla stampa da Piero Fassino, sindaco uscente di Torino, nonché esponente di rilievo del Partito Democratico a livello nazionale, sconfitto nettamente da una candidata di fatto sconosciuta ai più: “Nell’assegnazione delle case popolari – affermava Fassino – il criterio basato sulla composizione dei nuclei familiari premia sempre più spesso le famiglie immigrate, che fanno più figli. Bisogna domandarsi fino a quando la graduatoria unica è sostenibile. Questo per non alimentare conflitti tra chi quel diritto lo esige”.
In un contesto segnato dalla diminuzione drastica della disponibilità di alloggi pubblici e dall’imperativo dell’austerità nel governo locale, i partiti politici – ormai quasi senza eccezioni tra quelli rappresentati in Parlamento: populisti doc, moderati, riformisti, conservatori, destre nazionaliste – vanno alla ricerca di consensi tra i ceti meno abbienti indirizzando il malcontento sociale contro cittadini di origine straniera, ritenuti responsabili dello scollamento sociale anche solo per il fatto di candidarsi all’assegnazione delle case popolari, come si è visto nelle dichiarazioni di Fassino. Gli episodi di intolleranza nei quartieri popolari si sono moltiplicati in questi anni di post-crisi permanente. A Roma, nel dicembre del 2016, nel quartiere popolare di San Basilio, un tempo teatro dei movimenti di lotta per la casa, residenti storici inscenano una manifestazione di strada per impedire che una famiglia marocchina si insedi nell’alloggio pubblico di cui è legittima assegnataria. L’episodio è ripreso dai principali organi di informazione senza suscitare reazioni di particolare entità.
Le manifestazioni di ostilità verso i più deboli sono diventate un motivo ricorrente delle nostre società e per questo non fanno neppure più notizia. Le grandi metropoli e città, attraversate non solo in Italia ma in tutte le economie capitalistiche da una crisi abitativa senza precedenti, offrono terreno fertile ai fenomeni di rivalità e intolleranza sociale. La crisi del 2008 si generò a partire dal collasso della bolla immobiliare, per poi estendersi al settore finanziario che con il mercato immobiliare aveva costituito un connubio indissolubile negli anni dell’affermazione dell’egemonia neoliberale sulla globalizzazione. A dispetto delle istanze ridistributive emerse all’indomani della crisi del 2008, grazie soprattutto ai movimenti di contestazione apparsi nella scena mondiale a partire dal 2011 (da Occupy Wall Street alle proteste brasiliane del 2013), i successivi eventi non solo hanno disatteso le aspettative iniziali, ma hanno fatto registrare un brusco arretramento, imponendo una vera e propria “contro-rivoluzione”: da un lato, hanno confermato il modello di sviluppo che si era imposto negli anni precedenti fondato sull’indebitamento personale e sull’imperativo della proprietà immobiliare come bene di investimento, anziché come bisogno da soddisfare, a tutto vantaggio dei ceti benestanti; dall’altro lato, hanno aperto la strada all’ascesa inarrestabile delle forze populiste-nazionaliste che hanno speculato sull’esplosione delle diseguaglianze sociali, fomentando passioni negative di inimicizia comunitaria.
I fallimenti e insieme la resilienza dell’economia neoliberale hanno dunque creato le condizioni per l’affermarsi e il riprodursi del virus populista al di là dei suoi stessi confini: un’infezione che coinvolge l’intero quadro politico e potenzialmente tutta la società. È un virus la cui caratteristica distintiva è quella di apparire debole al momento della sua apparizione ma al tempo stesso capace di evoluzioni imprevedibili. Come scrisse Karl Polanyi a proposito del crollo di fiducia dopo la grande crisi del 1929, la deriva autoritaria – al tempo in cui egli scriveva di tipo fascista, oggi nazional-populista e comunitaria – si prospetta come una “mossa” improvvisa, prima ancora che come un “movimento” razionale e prevedibile nel suo sviluppo, possibile in ogni comunità colpita dalle conseguenze della crisi dell’economia di mercato.
Se si vuole contrastare la minaccia populista è essenziale dunque riportare la “questione urbana” nell’iniziativa politica, ponendo al centro dell’agenda dei movimenti il diritto all’abitare insieme alla costruzione di luoghi di convivenza dove sperimentare una “politica gioiosa dell’incontro”, internazionalista e anti-razzista, capace di offrire accoglienza e protezione a rifugiati e migranti, di nuovo arrivo o già residenti. Una politica gioiosa dell’incontro, fondata su un’idea e una pratica della città come “spazio del comune” a disposizione di indifesi e minoranze subalterne, appare oggi la sola alternativa credibile al populismo e alle sue passioni negative.
L’autore
Ugo Rossi è membro del collettivo Euronomade. Lavora come ricercatore di geografia economica e politica nell’Università di Torino. Ha di recente pubblicato Cities in Global Capitalism (Polity, 2017).