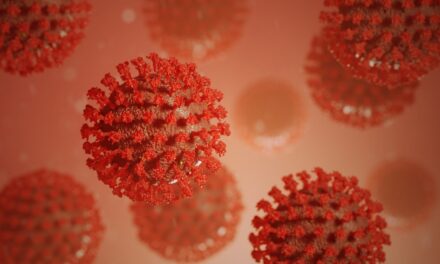Di BENEDETTO VECCHI.
Una accorta e riuscita ripresa di temi che hanno costituito il filo rosso di una riflessione sull’Italia con la dichiarata ambizione di analizzare la grande trasformazione del capitalismo dopo la crisi della grande fabbrica, la scomposizione delle classi sociali e il tramonto della forza politica del movimento operaio. Questo si prefigge La politica senza politica (Einaudi, pp. 224, euro 14), volume di Marco Revelli che tuttavia non è un semplice tirar le somme di un percorso di ricerca che lo ha occupato per quasi un ventennio. È piuttosto il tentativo di fare i conti con un fenomeno sociale prima ancora che istituzionale che si è soliti chiamare «populismo»; spesso, e a torto, viene ritenuto una parentesi, un incidente di percorso nello sviluppo capitalistico dopo la grande recessione del 2007-2008 – di cui non si vede fine – ritenuta l’avvio di una secolare stagnazione dell’economia mondiale. Il populismo non è un fenomeno contingente, bensì la dimensione politica di chi compete con le odiate élite per amministrare e gestire senza cambiare nulla del capitalismo, eletto, da populisti ed élite, a fenomeno naturale come naturale è l’avvicendarsi del giorno con la notte.
MARCO REVELLI parte dalla cronaca politica o sociale nella sua esplorazione del fenomeno populista. L’elezione di Donald Trump, la crescita di formazioni politiche xenofobe e razziste in Europa, la vittoria elettorale di Bolsonaro in Brasile, la formazione, per tornare al vecchio continente, di governi dichiaratamente populisti nell’Est Europa (il cosiddetto gruppo di Visegrad) e l’insediamento a Palazzo Chigi, in Italia, di un governo di coalizione che rivendica con orgoglio la sua natura populista.
Fenomeni descritti con dovizia di particolari individuando così il loro primo tratto comune: la retorica antiélite, queste ultime ritenute responsabili dell’impoverimento delle società capitaliste e di aver sacrificato sull’altare del business identità e sovranità nazionali, mentre i migranti sono usati come un «esercito industriale di riserva» con lo scopo di colpire al cuore i diritti sociali della cittadinanza autoctona.
C’è però un altro aspetto che accomuna Donald Trump a Victor Orbán, Matteo Salvini, Luigi di Maio, Jair Bolsonaro e Marie Le Pen: sono esponenti politici che si presentano come una risposta alla crisi della democrazia rappresentativa. Infine, il terzo elemento individuato dall’autore: il populismo è stato partorito nella scomposizione delle classi sociali immanente al mutamento del modello produttivo egemone del capitalismo. Il passaggio dalla fabbrica fordista alla produzione snella, il just in time, l’ascesa della finanza e la centralità di alcuni settori nella distribuzione e nella circolazione delle merci non ha visto solo l’eclissi e il ridimensionamento politico della classe operaia industriale ma anche una scomposizione di tutte le classi sociali, al punto da prendere sul serio l’affermazione della fine del sociale e la fine del Politico a favore di una algida amministrazione dell’esistente. Da qui il recupero da parte di Revelli delle tesi sulla postdemocrazia, che non si traduce nella cancellazione di libere elezioni, libertà di parola, sindacale e politica, semmai nello spostamento dei centri della decisione politica in contesti dove non è previsto il controllo del pubblico.
AI POPULISTI, inoltre, la postdemocrazia va bene, anche se vogliono subordinare i diritti civili e politici a una visione teologica del popolo. Non una fine della storia, dunque, ma una evoluzione della democrazia liberale della democrazia rappresentanza. Importante è anche la critica alla tesi della «ragione populista» di Ernesto Laclau. Come è noto, Laclau ha interpretato il populismo come l’innovazione necessaria del Politico dopo la crisi della rappresentanza. Il populismo consente la definizione di un interesse generale non solo come sintesi astratta dei particolari che innervano la società civile: ne costituisce semmai il superamento attraverso l’accoglienza proprio di quei particolari.
IL POPULISMO ha per Laclau, e recentemente per Chantal Mouffe nella sua proposta del necessario agonismo tra democrazia diretta e rappresentativa, la capacità di gestire le linee di frattura e di conflitto che hanno sostituito il conflitto tra capitale e lavoro all’interno di visioni geometriche e geografiche tra chi sta in alto e chi sta in basso, tra chi sta al centro e chi sta in periferia. Ha però ragione Revelli quando qualifica il populismo come un significante vuoto che può dunque essere riempito da ciò che un ambizioso e scaltro politico di turno vuole. Più che essere espressione di un «pensiero forte sul politico» o un seppur disordinato esodo dal deserto del reale, il populismo è la forma politica funzionale al mantenimento dei rapporti di potere dominanti.
L’analisi di Marco Revelli affronta anche la crescita abnorme delle disuguaglianze, il dilagare della povertà, sia nella forma dei lavoratori poveri che degli «esclusi» dalla società costituita. Il populismo trova qui il suo carburante, spesso usato non solo figurativamente in pogrom antimigranti, antirom. Già, perché il populismo è violento, è ostile all’altro, configurazione caricaturale della distinzione tra amico e nemico, dove il nemico è chiunque si discosti da quella invenzione concettuale che è il popolo.
Il problema è come contrastare la «bestia populista». Ma qui l’analisi di Revelli si ferma. L’autore ha conosciuto bene la stagione dei movimenti sociali e sa che le risposte vanno cercate collettivamente, dentro e contro le relazioni sociali dominanti. Sa quindi che quel libro è ancora tutto da scrivere.
Questo articolo è stato pubblicato su il manifesto il 13 febbraio 2019.