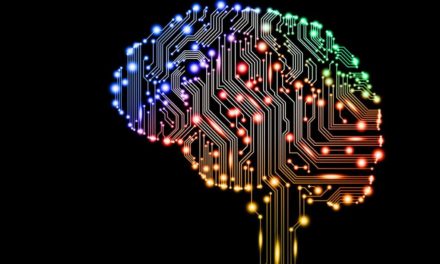di Federico Rahola. l rapporto tra poteri e resistenze è anche una partita tra luce e ombra. E non si tratta di stabilire una volta per tutte un primato tra i due ambienti, piuttosto di tracciare la loro reversibilità tattica. Ma se è vero che il controllo oggi si gioca sulla necessità di prevedere il comportamento di soggetti liberi e mobili, ciò significa che la luce su cui si fonda dovrà partire dai soggetti stessi. Da qui, forse, la necessità di un elogio dell’ombra, a quarant’anni da Sorvegliare e punire di Michel Foucault e a più di sessanta da L’uomo invisibile, unico romanzo compiuto di Ralph Ellison.
Sessant’anni potrebbero essere un tempo congruo per disperdere l’eco delle prime parole di quel libro. Eppure erano potenti, le note di un manifesto a venire, una new thing: «sono un uomo invisibile. No, non sono uno spettro, come quelli che ossessionavano Edgar Allan Poe; e non sono neppure uno di quegli ectoplasmi dei film di Hollywood. Sono un uomo che ha consistenza, di carne ed ossa, fibre e umori, e si può persino dire che posseggo un cervello. Sono invisibile semplicemente perché la gente si rifiuta di vedermi: capito?» Poche frasi e la voce si localizza, facendo di un seminterrato l’indirizzo da cui recapitare un’autobiografia a ritroso destinata a insinuarsi di piatto nelle pieghe di un secolo tagliato a metà dalla linea del colore: «vivo abusivamente in un edificio affittato solo ai bianchi, in una sezione del seminterrato che fu interrotta e dimenticata durante il XIX secolo». Dove può abitare uno squatter nero, in un condominio per soli bianchi, se non nell’ombra? A ripensarci, Ellison è stato davvero lo scrittore dell’ombra.
Shadow and Act è il titolo della raccolta di saggi che seguirà, anni dopo, il primo lavoro – quando ormai il jazz era diventato il suo nuovo condominio, un condominio black, anche se sotto costante minaccia di sfratto, e prima che le 2000 pagine del secondo infinito romanzo bruciassero insieme al tentativo disperato di riscriverle. La questione però era sempre la stessa: la condanna a vivere nell’ombra che diventa possibilità di agire nell’ombra, magari indossando maschere ad hoc, come suggerirà in Black Mask of Humanity. Forse Ellison conosceva l’etimo latino di persona, che rimanda a phaersu, la maschera funebre etrusca, e probabilmente a per-sonare, il suono che passa attraverso una maschera comica, o l’ancia di un sax.
Anonimato mainstream
Due mesi fa un gruppo di ricercatori del Queen Mary ha annunciato di aver smascherato Banksy, membro non anonimo del popolo degli invisibili – schiera eterogenea che dal passamontagna del subcomandante Marcos arriva all’ombra accecante del famigerato Jihadi John, l’aguzzino di Daesh. Le modalità di cattura aggiornano un’«arte» antica, la caccia all’uomo: geo-localizzazione, incrocio di dati, macchie di calore, hot-spot che tracciano percorsi, frequenze, profili. E poco importa che finiscano per confermare vecchie ipotesi, un’inchiesta tradizionale di un tabloid inglese pervenuta allo stesso nome e indirizzo. Piuttosto vale la pena chiedersi perché proprio Banksy. Lo spiega un articolo sull’«Independent»: «the academics made the unflattering comparison between Banksy’s street artwork and acts of criminal vandalism». Certo, Banksy è un tagger, mainstream ma pur sempre vandalo. Si è trattato dunque della prova generale di una app da lanciare altrove, nel mare magno del mercato della sicurezza.Da oggi, si annuncia, vandali, tagger ma anche molestatori oltre ovviamente a criminali e potenziali terroristi non avranno più ombra: nessuno bacerà o ucciderà nell’ombra. La stagione degli uomini invisibili sembra alle nostre spalle. Va detto però che «invisibili», in origine, nel diritto internazionale, erano gli undocumented, soggetti divenuti tali per aver perduto ogni nazionalità: in Grecia e Turchia all’inizio del Novecento, dappertutto nell’Europa a cavallo tra le due guerre, a milioni sotto il Reich e poi ancora nel dopoguerra, per esempio tra gli «sciavi» in Friuli.
La lista si potrebbe aggiornare, se non fosse che gli undocumented di oggi, una volta varcata una linea di fuga, finiscono per lo più sotto i fari di una motovedetta, un molo, una frontiera spinata. E qui diventano visibilissimi, pressoché trasparenti, attraverso hot spot (ancora), bodyscanner, rilevamenti biometrici e schedature che confluiscono in database sigillati in acronimi à la Russolo, come Sis-Eurodac. Per inciso, l’ultimo intervento di Banksy, quando ancora era invisibile (una Marianne avvolta da lacrimogeni con alle spalle un tricolore lacerato), puntava contro lo sgombero della invisible jungle di Calais e la schedatura e la deportazione degli invisibili in centri panottici.
Vite in fuga
Vale la pena chiedersi che fine abbia fatto oggi l’uomo invisibile, se si può ancora scrivere, oltre che leggere, un libro così. I suoi discendenti li ritroviamo per esempio a Philadelphia, accompagnati giorno e notte da Alice Goffman nelle pagine di On the run. Fugitive lifes in an American City per riscoprire, nelle evoluzioni statiche della linea del colore, cosa significhi avere sempre e ovunque i fari puntati addosso: animali in una riserva, prede braccate senza possibilità di ombra o di fuga e con una probabilità su 4 di finire in galera. E allora occorrerebbe chiedersi anche cosa significhi fuggire nell’epoca dei Gps, di segnali agganciati a celle satellitari, nei giorni di una caccia all’uomo che dalle tracce analogiche (un’impronta, una piuma) passa alle scie digitali che ognuno si lascia alle spalle. E magari rendersi conto che road movies come Thelma e Louise o Blues Brothers oggi non durerebbero più di un quarto d’ora, forse anche a Molenbeeck.
In queste pieghe l’invisibilità sembra svanire e lo smascheramento, consapevole o meno, volontario o meno, è all’ordine del giorno. Se la psicoanalisi, quella più easy, segnala che l’individuo «ipermoderno» (narciso/cinico/desiderante) è mosso da un’irrefrenabile pulsione scopica e narrativa (e non serve fare i nomi dei dispositivi social che la innervano), questo soggetto traslucido non lo troviamo solo seduto davanti al rumore bianco di uno schermo ma dappertutto, nelle maglie larghe di un controllo giocato sulla luce e la prevedibilità. In gioco sembra essere la possibilità di abitare i due millimetri che separano una maschera dalla pelle: una parte nascosta, sotto la superficie, che si potrebbe chiamare diritto all’invisibilità ma che è soprattutto ombra, spazio sottratto alla luce.
Chi ha letto Il cerchio di Dave Eggers (un «castello» poco kafkiano e di vetro che vale per google e in cui si dettano gli imperativi morali di una società trasparente), anche a costo di una letteralità lontana dalla scrittura di Ellison si sarà fatto un’idea delle scarse possibilità di recuperare quei due millimetri, la distanza rispetto a soi meme, espressione forse di un’altra verità, mai adiacente e identica, che diventa occasione per de-soggettivarsi, «strappare il soggetto a se stesso». Resterebbero i meandri del deep-web, ma anche lì finiremmo per scoprire che molti hacktivisti, sbandierando la trasparenza come obiettivo e la rivelazione come strategia, adottano strumenti (malware, trojan) e procedure di data-mining analoghi ai cookies di Google e del mercato estrattivo dei big-data o alle logiche di controllo di programmi governativi come Prism.
Invisibilità tattica
Certo, in questi casi un intero regime di visibilità appare ribaltato, e tra le fila di Anonymous è possibile scorgere un’invisibilità tattica che riconduce a Ellison ricordandoci come il conflitto sia sempre mimetico. Resta però un isomorfismo di fondo: il fatto che in tutti i casi (per rivelare o per controllare) le maschere saltano, l’ombra si ritrae e la luce trionfa. Si tratta di una luce che scaturisce per lo più dai soggetti stessi, che induce e soprattutto seduce. E anche qui vale la pena non farsi abbagliare: il prefisso «se-», più che a un immediato gesto riflessivo (se-ducere sta per condurre fuori) rimanda a un movente che origina dal soggetto e lo spinge a competere in primo luogo con se stesso. Del resto l’auto-imprenditorialità, cardine della sharing economy, la ritroviamo ovunque, da airbnb ai makers, e ci restituisce le traiettorie di una soggettività «dividuale», all’incrocio di profili, punti accumulati, in costante competizione e soprattutto trasparente.
«La piena luce e lo sguardo captano più di quanto facesse l’ombra, che alla fine proteggeva.» Sono quaranta gli anni che ci separano da Sorvegliare e punire, percorso che riannoda i fili di tecnologie immanenti che producono corpi docili, imprigionati in anime indotte a credere di essere sempre sotto i fari di uno sguardo disciplinante. Reclusi e osservati in una stanza: la famiglia, la scuola, l’ospedale, la prigione, la fabbrica. Gilles Deleuze ha detto che non siamo più (solo) così. E mentre videocamere e guinzagli elettronici avvicinano l’idea di un individuo portatore del proprio assoggettamento, diverse pareti saltano: l’impresa ha sostituito la fabbrica, il self-care l’ospedale, l’(auto)valutazione l’esame. Lo sguardo incorporato dello schema di Jeremy Bentham (quello del Panopticon) si fondava sull’inverificabilità, ma proveniva da una torre visibile, oggettiva, altra da sé.
Lo spazio del buio
Oggi quello sguardo sembra partire dai soggetti stessi, da dati, tracce e profili autocostruiti prima ancora di venire aggregati e messi a valore dagli algoritmi del capitale. Se governare attraverso la libertà è la bussola neoliberale, una simile libertà è fatta di luce, irretita nelle trappole della visibilità. Ed è sempre il soggetto la posta in palio: che cosa stiamo diventando?
Sulla scia di Kant e dell’Aufklarung Foucault si chiedeva soprattutto questo. In tempi di anime al lavoro, farsi carico del peso dei lumi significa vedere cosa può succedere dalle parti del buio: contro la piena luce di un’esibizione di sé, coatta o meno, sondare lo spazio di agibilità consentito dall’ombra. Edouard Glissant rivendicava il diritto all’opacità come principio di non identità rispetto a ogni sguardo o modello trasparente. Si dovrebbe partire da qui per trovare un antidoto ai fasci di luce che presidiano le professioni di sé e i confini del presente.
Questo articolo è uscito su Il Manifesto il giorno 10.07.2016