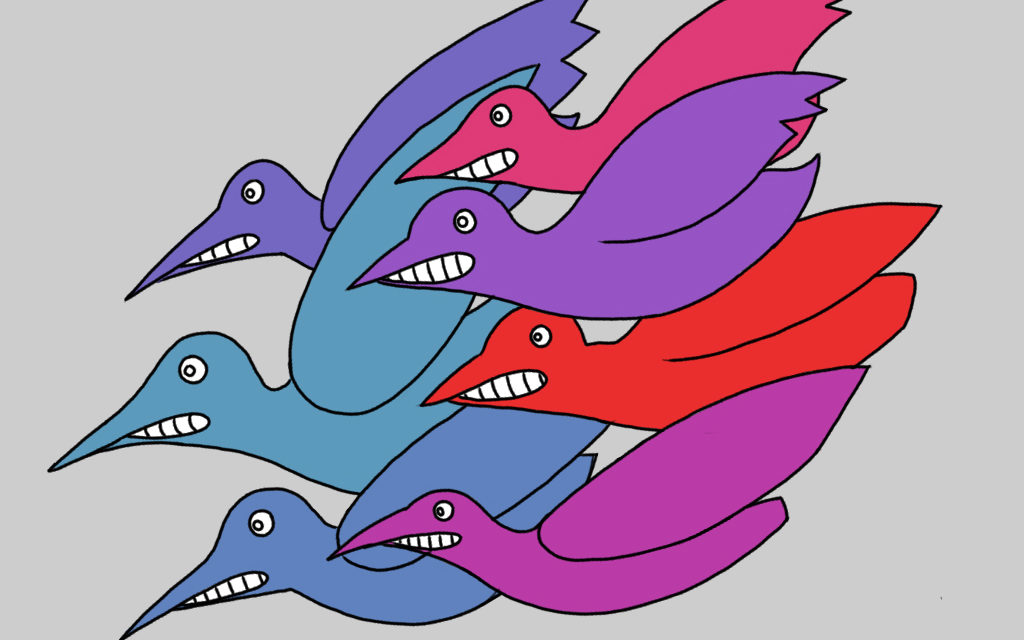di EMANUELE BRAGA.
(SEMIMARIO LE PIATTAFORME DEL CAPITALE, MILANO, MACAO, 3-4 MARZO)
Silicon Valley o fascismo?
Una settimana fa Zuckerberg, il capo di Facebook, scrive un manifesto politico. Difende l’idea di una globalizzazione fatta di comunità di utenti che interagiscono sui social. A molti è sembrato che la Silicon Valley lanciasse il suo manifesto contro l’orrido Trump. Un’idea di globalizzazione sostenibile in cui ai cittadini si sostituiscono lentamente utenti di enormi piattaforme proprietarie, su cui si possono produrre contenuti, trasferire denaro, usufruire di servizi, organizzare azioni politiche. Nel frattempo Airbnb offre stanze per ospitare i profughi, Elon Musk (capo di Tesla) ci spiega come funziona il Basic Income, mentre Google lo sta già sperimentando in una comunità di 100 (ex?) lavoratori. Bill Gates incontra Bono e discutono di automazione e post-lavoro. Ha tutta l’aria di non essere una coincidenza.
Dall’altra ci sono i reazionari populisti alla Trump, Putin, la Le Pen, Salvini… il rinascimento dei nazionalismi fascisti e protezionisti, un idea di lavoro ancora novecentesca, contro la sharing economy, anti-globalisti e razzisti.
L’idea del muro identitario e reazionario, misogeno, patriarcale e xenofobo, contro l’iperconnettività, l’innovazione tecnologica, LGBT friendly, migrants friendly, qualsiasi cosa friendly: la comunità globale post-moderna.
E tu da che parte stai?
Mi cade l’occhio su di un aspetto a prima vista marginale: entrambi questi modelli sono capitalisti e per ora entrambi adottano di fatto comportamenti neoliberali: privatizzano le risorse, si arricchiscono sul lavoro precario, e accentrano in modo aggressivo i capitali nei mercati finanziari.
Automazione o lavoro?
Circa due anni fa, l’università di Oxford fa uscire un report sul rapporto fra automazione e indici occupazionali. La notizia sembra shock! Nel giro di vent’anni la metà dei lavori attualmente in essere non avranno più senso di esistere perchè i robot lavoreranno al posto nostro. Nasce una sorta di strana distopia, da una parte gli eredi della tradizione socialista e lavorista che difendono la necessità di creare lavoro anche venendo a patti con la inevitabile distruzione progressiva dei diritti, dall’altra uno scenario sci-fi in cui gli uomini avranno un sacco di tempo libero mentre i robot producono tutto quello che occorre. Da una parte la fobia dell’automazione al grido: i robot ci rubano il lavoro! Dall’altra la speranza che l’automazione permetterà alle masse di vivere in un mondo più ecologico, sano e ricco. Con una inchiesta prodotta da Macao e Robin Hood Minor Asset Management portiamo questa questione fra i lavoratori a Milano di Expo2015. Una cosa ci appare di colpo evidente: l’ultima generazione di giovanissimi sono ancora imbevuti di una intramontabile etica del lavoro. Non concepiscono altro modo di realizzarsi se non trovare un lavoro. Emerge quella che altri hanno chiamato la couch fear, la paura di stare sul divano a guardare il soffitto. E questa miscela esplosiva crea un mostro: il free job. Migliaia di giovani che sono disposti a lavorare a gratis per delle multinazionali piuttosto di mantenere intatta un certa idea di futuro.
A me sorge una domanda sistemica: se davvero nel giro di dieci anni i tassi di disoccupazione sono destinati a salire così tanto, siamo sull’orlo di una catastrofe sociale. Davvero il capitale (chi detiene la partita dell’innovazione tecnologica) ha interesse ad una tale disfatta? Per tutto il novecento il capitalismo ha ridistribuito ricchezza attraverso il salario. C’era di certo l’interesse a tenere la forza lavoro in rapporto di sfruttamento ma c’era altrettanto il bisogno di costruire un potere d’acquisto e una certa sicurezza sociale. Il paradigma keynesiano si era in gran parte costruito su questo patto implicito fra capitale, governo e lavoro. I mercati volevano poter estrarre ricchezza, e in cambio mettevano in condizione le masse di poter essere consumatori pagando salari, sotto la sorveglianza dello stato che garantiva un certa stabilità. Ora questo patto sembra essere saltato. Enormi masse di persone sembrano diventare inutili (non più utili nemmeno in quanto sfruttati). Ma a che pro?
Come si fa a farla finita con il lavoro ma allo stesso tempo non diventare dei rifiuti umani? C’è un qualche scenario politico in cui produrre ricchezza non significa lavorare per un salario?
Basic income è di sinistra?
Due anni fa mi sveglio a Berlino nei giorni appena successivi al capodanno, accendo la radio e sento una conferenza di Brian Eno che parla di Basic Income e vita dell’artista. La cosa mi pare curiosa dal retrogusto un po’ distopico. Qualcosa si stava muovendo anche al di fuori di ristretti ambiti deputati. Ma ho l’impressione che solo dopo la recente vittoria di Hamon alle primarie del partito socialista in Francia, il BI sia diventato argomento mainstream. In uno scenario in cui non c’è più bisogno di lavorare, garantire un reddito sembra l’unica soluzione. Le persone non dovranno più lavorare per vivere, avranno un reddito garantito col quale potranno decidere come meglio spendere il tempo e produrre. In fin dei conti, il BI lo sembrano volere un po’ tutti: lo propone una certa destra sociale, lo suggeriscono alcune grandi Corporation, lo propone sempre di più la sinistra, e lo vuole la gente. Quindi dove sta il problema? Il problema credo stia principalmente in due questioni: da dove si prendono i soldi e a chi li dai. Se il Basic Income lo gestisce lo stato c’è il problema di come in questo momento lo stato abbia la forza di imporre una tassazione adeguata ai mercati per poter garantire un reddito a tutti i cittadini. Le grandi Corporation non operano in territori nazionali ma prediligono aggirare i regimi di tassazione muovendosi a livello globale. I mercati finanziari e la gestione del debito pubblico ha ormai indebolito gran parte dei servizi statali e dei sistemi di welfare pubblico. In questo scenario è difficile che gli stati nazione abbiano la forza di poter tassare adeguatamente i mercati per poter redistribuire ai cittadini un adeguata ricchezza. Una certa interpretazione più neoliberale del Basic Income rivela come un possibile programma sia quello di usarlo come pretesto per privatizzare tutti i servizi pubblici e metterli a pagamento. Infine c’è la questione: chi ha diritto al Basic Income? Se le dinamiche di cui stiamo parlando sono dinamiche globali, perchè limitare il diritto al reddito ai soli cittadini di una nazione? Che ne è dei migranti, delle grandi disparità ancora vigenti in epoca post-coloniale?
Una sfida che ci attende è ancorare il Basic Income su presupposti politici, e cioè per quale tipo di Basic Income occorre lottare. Un presupposto per pensare al BI credo sia riconoscere con forza l’autonomia della cooperazione sociale. Il BI non è un forma di ammortizzatore sociale, ma è un vero cambio di paradigma. Deve essere un riconoscimento di tutta quella produzione e riproduzione sociale che costituisce la ricchezza relazionale in cui siamo immersi. Perchè il BI abbia un valore politico dobbiamo costruire una rivoluzione culturale. BI significa riconoscere tutto il tempo che utilizziamo per creare relazioni, per tessere i processi di solidarietà, la passione che nasce dalla libertà di impiegare il proprio tempo in processi espressivi e organizzativi, per prenderci cura delle nostre vite in svariate forme. Il BI diventa una rivendicazione politica se parte da questo processo di appropriazione soggettivo della ricchezza che tutti i giorni produciamo.
Metropoli digitali?
Tre anni fa ci trovammo tutti in un convegno titolato Fare Pubblici nella nostra vecchia Italia, nella nostra piccola Milano. Era un momento di studio sul potere degli Eventi nelle città creative, costruzione dello spazio urbano e economia digitale. Volevamo dire che l’economia di una città particolarmente creativa come Milano era strettamente legata a come la gente ne parla, ne scrive, costruisce contenuti in particolar modo nei social network. Volevamo anche far notare come la profilazione dei comportamenti di questi utenti di piattaforme social fossero il principale indice per determinare il successo degli eventi. Abbiamo dimostrato attraverso una inchiesta sul campo quanto anche gli sponsors, il modo in cui gli eventi sono finanziati si basa proprio su questo tipo di indici. Il nostro scopo era capire se tutti i soldi che girano in questa industria fossero poi redistribuiti come ricchezza sociale o venissero invece capitalizzati da pochi.
Avevamo anche fatto un azione di disturbo nei social network durante un famoso evento di quella stagione, chiedendo alla comunità social di parlare dell’evento in modo meno passivo e scontato, magari attivando un punto di vista anche critico, e provocammo una violenta risposta da parte degli organizzatori dell’evento. Subimmo anche l’oscuramento di tutti i nostri canali da parte di facebook e twitter in seguito a questa azione ‘non allineata’.
Questo ci fece parecchio riflettere: gli eventi culturali e creativi di Milano non si preoccupano più tanto della costruzione di un contenuto (ciò che viene esposto nelle varie location) ma piuttosto qualsiasi cosa è un pretesto perchè il pubblico costruisca contenuti. E’ la grande massa di contenuti prodotti dal pubblico ciò che davvero interessa, i comportamenti della gente diventano il vero contenuto. Nei contenuti prodotti dalla gente ci sono un sacco di informazioni utili che riguardano soprattutto i loro comportamenti. Sapendo come la gente si comporta si può entrare nel DNA della organizzazione sociale.
Insomma avevamo toccato con mano come lo spazio metropolitano fosse il luogo deputato in cui l’economia digitale potesse attecchire, e come la costruzione di contenuti on-line avesse ricadute importanti sullo spazio economico, lavorativo, e di utilizzo dell’urbano. Da li a poco tutto sarebbe diventato più evidente con la crescita a dismisura di altre piattaforme come Uber, Airbnb, Amazon, Foodora, e decine di start up che integrano le periferiche dei nostri smartphone a servizi dei più disparti. Attraverso le Piattaforme digitali si controlla progressivamente tutto: mobilità, cibo, ospitalità, sanità, educazione, cultura…
E i movimenti?
Difronte ad un simile cambio di paradigma che coinvolge meccanismi produttivi, di controllo sociale e ridistribuzione di ricchezze, è possibile creare dei contro dispostivi alternativi a questi monopoli?
La prima cosa che c’è venuta da fare è stato decentralizzare tutto. Per riuscire a creare piattaforme dal basso, un’intuizione originaria è stata distribuire su di una rete vasta di utenti la sede fisica dei dati. Questa a ben vedere è stata una metafora che ha ispirato anche una forma di organizzazione politica. Non c’è un vero e proprio leader, un organo centralizzato delegato a decidere, un consiglio di amministrazione che determina i protocolli e gli algoritmi, non ci sono server e processori di un unica proprietà, ma tutti questi aspetti sono potenzialmente distribuiti su tanti soggetti.
In questo modo credo c’è stato un salto di qualità: in ambito di movimento si è cominciato a parlare di infrastrutture. Non ci si è solo occupati di evidenziare un agenda di rivendicazioni politiche, ma si è cominciato anche a parlare di infrastrutture organizzative e produttive alternative.
La sfida insomma è mettere al servizio le piattaforme digitali a forme organizzative alternative. Lo scopo è autogestire la produzione cooperante attraverso diversi meccanismi di governo e di redistribuzione economica.
Stanno nascendo piattaforme cooperative in cui servizi come Uber, Foodora, aribnb… posso essere garantiti da cooperative di lavoratori che si autodeterminano.
Cosi come nel campo dei media e della produzione di contenuti (musica, arte, video, grafica…) molte sono le possibilità di cogestire finanziamenti, produzione e distribuzione attraverso infrastrutture digitali auto organizzate.
Un altro campo di sperimentazione sono gli strumenti economici, come le criptomonete, cirquiti di credito, mutuo aiuto e servizi bancari.
Insomma l’idea di piattaforme collaborative distribuite sovrapposta alla possibilità di meccanismi di governance aperta e partecipata, lascia intravvedere una nuova utopia: attraverso processi di automazione possiamo autogestire la produzione sociale.
Questa utopia (sulla quale credo valga la pena scommettere) corre quotidianamente due rischi: il primo è non reggere la competizione con le grandi piattaforme del capitale, perchè queste hanno molte più risorse da investire nello sviluppo e nella diffusione. Il secondo è la difficoltà a federarsi: l’unica possibilità di scalare infrastrutture alternative sta nella loro capacità di integrarsi, di creare un ambiente avvolgente sul terreno sociale, di non chiudersi nel limitato territorio della loro funzionalità interna ma interconnettersi fra di loro.