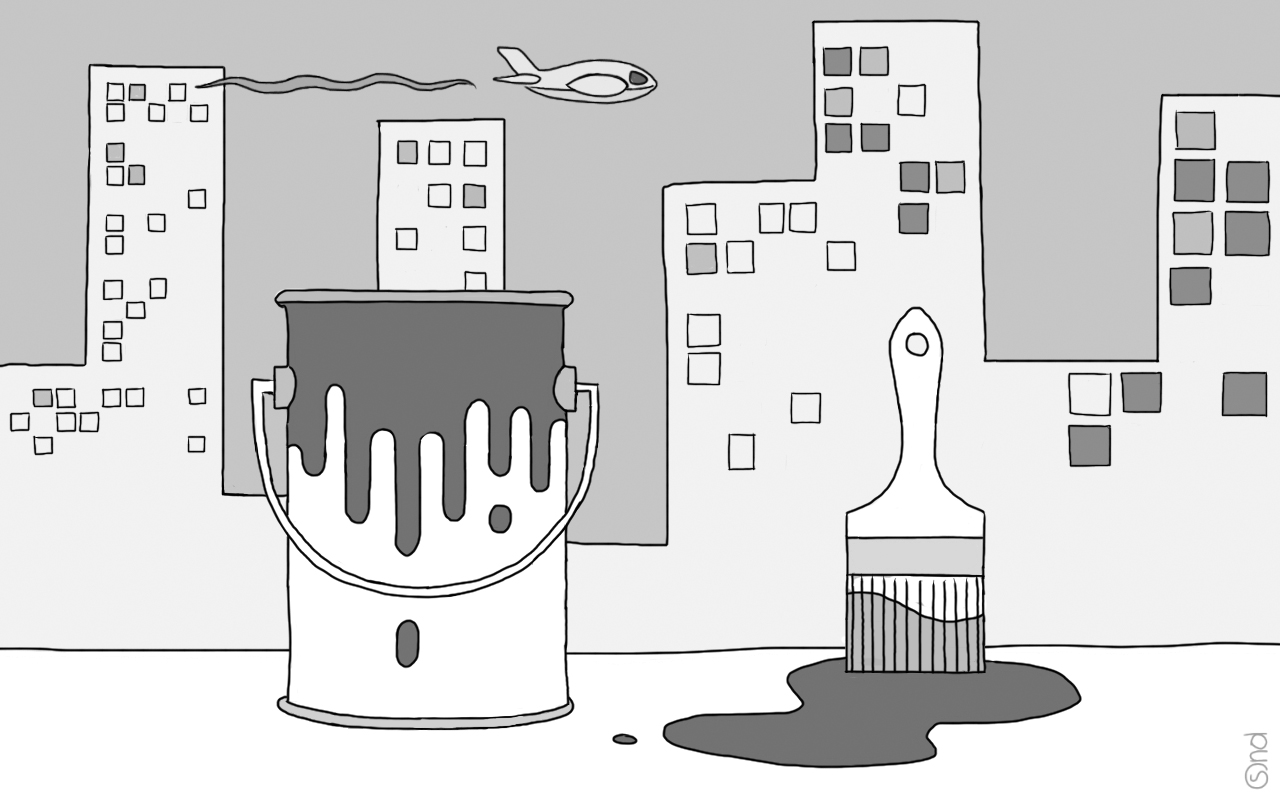Di FREDERIC JAMESON
I.
Innanzitutto permettetemi di spiegare il dibattito intorno all’utopia o, forse dovrei dire, intorno agli usi politici dell’utopia. Immagino che la maggior parte delle persone concordi sul fatto che gli utopisti della fine del diciottesimo e dell’inizio del diciannovesimo secolo fossero tutti essenzialmente progressisti, nel senso che le loro visioni o fantasie puntavano a migliorare la condizione della razza umana. Il momento che mi interessa è quello dell’analisi amplificata in cui queste utopie e i loro entusiasti sostenitori vengono imputati in quanto destinati per forza di cose ad avere esiti nefasti. In seguito, ciò arriverà a far sostenere che l’utopismo rivoluzionario porta alla violenza e alla dittatura e che tutte le utopie, in un modo o nell’altro, portano a Josif Stalin: meglio ancora, che Stalin era lui stesso un utopista, su larga scala.
Ora, a dire il vero, ciò è già implicito nella denuncia della Rivoluzione francese da parte di Edmund Burke, e nella sua idea – uno dei più geniali argomenti controrivoluzionari – che sia la hybris degli esseri umani che induca a sostituire la lenta crescita naturale della tradizione con i piani artificiali della ragione, e che questa rivoluzione rappresenti di per sé sempre un disastro. Tutto ciò rivive durante la Guerra fredda: il comunismo si identifica con l’utopia, entrambi con la rivoluzione, e tutti con il totalitarismo (A volte si insinua anche il nazismo: non è tanto la sua identificazione con l’utopia quanto l’equivalenza di Adolf Hitler e Stalin, e i dibattiti che ne derivano sul vincitore nella competizione relativa al numero di morti).
Credo che sia stato essenzialmente dopo la Seconda guerra mondiale che le generazioni più giovani abbiano ribaltato questa implicazione e trasformato l’utopia in uno slogan e in un grido di battaglia. Il capovolgimento non consiste nel rilevare una distopia emergente nascosta nell’utopia, né nel cogliere l’utopismo come una fioritura del peccato di orgoglio, ma piuttosto in una nuova convinzione: vale a dire che l’opposto dell’utopia è lo status quo. Ora, in un nuovo e minaccioso senso di stagnazione, di potere delle istituzioni e dello stato che è nato dalle necessità e dalle condizioni del tempo di guerra, l’utopia viene associata al cambiamento stesso, e le qualità statiche che spesso sembravano insite nelle tradizionali strutture utopiche vengono ignorate a favore delle finestre rotte e dell’aria fresca che l’utopismo sembrava portare con sé. Questo è il senso degli anni Sessanta, che più di ogni altro periodo rivoluzionario sono legati alla rinascita stessa dell’utopia nella sua nuova forma.
Ci sono, naturalmente, teorizzazioni di questa nuova e dinamica Utopia, in particolare l’opera enciclopedica di Ernst Bloch. Ci sono anche accesi tentativi di far rivivere le vecchie e nefaste diagnosi, in particolare dopo la fine dell’Unione sovietica. Mi sembra tuttavia che la fonte di questi significati politici antitetici dell’utopia non risieda nella convinzione filosofica, ma piuttosto in qualcosa di più vicino all’esperienza esistenziale (o fenomenologica), vale a dire il senso dei futuri possibili. Lo status quo vuole essere sicuro che il futuro rimanga essenzialmente lo stesso del presente: il suo slogan sarà allora «la fine della storia», vale a dire la fine dell’utopia, la fine del futuro e del cambiamento.
L’utopismo ha bisogno di nutrirsi della convinzione esperienziale che sono possibili futuri radicalmente diversi e che il cambiamento esiste, e questa è una convinzione che solo le circostanze e le condizioni sociali possono produrre: è soffocata dalla paralisi politica e dall’estinzione dei partiti radicali e dal modo in cui la globalizzazione incombente lascia sempre meno possibilità per qualsiasi autentica iniziativa nazionale (L’Unione europea, in cui gli stati-nazione sono stati ridotti a stati membri, è un eccellente esempio di questo processo in atto).
II.
Ma cos’è l’utopia in primo luogo? O se si tratta davvero di un «non luogo», qual è il concetto di Utopia, e qual è la sua utilità politica? È ovvio che ponendoci questa domanda ci troviamo subito di fronte a una complicazione, vale a dire la confusione dell’utopia con la politica «reale» o storica. Dobbiamo anche affrontare il fatto che non abbiamo un buon termine per l’opposto di Utopia in questo senso. Abbiamo detto che il suo contrario non è la distopia ma piuttosto lo status quo; ma sicuramente gran parte della cosiddetta politica progressista vuole semplicemente cambiare lo status quo, a volte radicalmente. Quindi, come distingueremmo tra una politica utopica e una politica radicale? Se la mettiamo così, l’opposizione che viene subito in mente è quella tradizionale tra socialismo e comunismo: questa può addirittura rivendicare le sue origini nell’opposizione tra menscevichi e bolscevichi. Tra gli intellettuali, negli ultimi anni, ci sono stati sforzi per far rivivere l’uso della parola comunismo che, giustamente o erroneamente associata allo stalinismo, è caduta in disgrazia e persino nell’oblio dopo la caduta dell’Unione sovietica. Quanto al socialismo, per le persone di sinistra, è stato contaminato dalla totale diserzione dei partiti socialdemocratici, sia in teoria che in pratica: in teoria dall’eliminazione sistematica di Karl Marx e del marxismo dai loro programmi e in pratica dalla loro vergognosa adesione alle politiche neoliberiste – privatizzazioni, austerità e simili – ogni volta che arrivano al potere esecutivo.
Tuttavia, ho trovato utile distinguere tra una politica progressista all’interno del sistema, cioè una politica che lascia intatto il quadro generale del capitalismo, e una politica che cercherebbe di modificare quel quadro e che oggi non è visibile da nessuna parte, come testimonia la ritirata di Syriza quando le cose si sono messe male. Questo non suggerisce allora che la politica utopica rimane la politica del nulla e che si trova proprio là dove è irrealizzabile? Dobbiamo, in altre parole, distinguere nettamente tra proposte politiche concrete e quelle che sono chiaramente «utopistiche», o realizzazioni di desideri irrealizzabili. Questa proposizione può essere misurata con chiarezza guardando di nuovo a una delle ultime utopie tradizionali di vero successo, l’Ecotopia di Ernest Callenbach. Ora, per prima cosa, ha scritto prima dei computer, e quindi l’integrazione di una tecnologia dell’informazione che oggi figura così massicciamente nella nostra vita quotidiana, e la sua cornice di una visione dell’utopia, non doveva essere affrontata (Il computer ovviamente figurava in modo prominente in un gran numero di visioni e speculazioni selvaggiamente utopiche al momento della sua introduzione generale nella vita quotidiana, intorno al 1982; ma è proprio il palese fallimento di tali soddisfazioni utopistiche dei desideri nell’era attuale delle piattaforme monopolistiche e del consumismo o dell’appropriazione delle merci che segna il dilemma).
Nel frattempo, Callenbach ha facilitato le cose escludendo la razza dal quadro (le utopie nere separatiste sono quindi assegnate a San Francisco, al di fuori della cornice della sua narrativa). Per quanto riguarda il genere, sì, senza dubbio la sua Ecotopia è gestita da donne, ma proprio questa specificazione ora ci sembra poco plausibile, e cioè che l’aggressività è una caratteristica del maschio (e di cui tratta attraverso i cosiddetti giochi di guerra , che dovrebbero escluderla dai sistemi degli uomini!). Intanto, diventa evidente che Callenbach sta cercando anche di anticipare altre due obiezioni generali al socialismo: vale a dire che uccide l’intrapresa e che soffoca il dibattito, la discussione, la libertà di parola e di opinione. Del resto, abbiamo un sacco di avvocati e contenziosi. La questione dell’imprenditoria e della piccola impresa è un argomento ben accetto, in quanto è sembrato sempre dettare posizioni antimonopolistiche e affini a sinistra. Ma Vladimir Lenin accolse il monopolio come via verso la nazionalizzazione (e come segno che la socializzazione stava effettivamente procedendo, come tendenza, all’interno del capitalismo avanzato). Chiaramente qui deve esserci una distinzione, nella politica attuale, tra piccola impresa e monopolio; e l’Utopia di Callenbach solleva la questione dell’innovazione in chiave positiva. Per quanto riguarda il separatismo (Utopia in un solo paese?), la stessa Ecotopia (Oregon, Washington, California settentrionale) non è una repubblica separatista? O meglio ancora, l’utopia stessa non è un fenomeno separatista? Come l’idea di utopia sta alla realtà della politica, così queste utopie immaginarie realmente realizzate sono ancora separatiste rispetto alla realtà immaginata.
Dunque, l’utopia rimane utopica fino al punto in cui può essere realizzata, in cui può essere tradotta in politiche pratiche; a quel punto ricade nella politica e cessa di essere utopia. Ma questo è un argomento piuttosto scoraggiante per l’Utopia! È, tuttavia, un’affermazione molto ovvia quando la riportiamo nell’altra nostra opposizione, quando si legge che: le politiche comuniste sono utopistiche finché non possono essere realizzate, e diventano socialdemocratiche non appena ricadono nel mondo reale del dare e avere politico. Ciò che qui ho definito ovvio è il segno della struttura stessa, o del sistema, vale a dire il capitalismo: le misure socialdemocratiche diventano semplicemente politiche di riforma quando sono progettate semplicemente per correggere, rafforzare e riprodurre il sistema, o il capitalismo in quanto tale; la politica comunista mira a trasformare il sistema e sostituirlo con qualcos’altro, vale a dire un tipo di sistema radicalmente nuovo. Ecco perché è sempre strano, ad esempio nei momenti di crisi finanziaria, trovare progressisti e persino socialisti che salvano le banche e cercano di ripristinare il funzionamento del sistema nel suo insieme, quando la loro premessa è stata la sua trasformazione e sostituzione. Il socialismo di François Mitterand è un esempio calzante: quando fu eletto nel 1981, iniziò ad attuare autentiche misure socialiste; sopravvenuta una crisi mondiale, fu convinto ad accantonare tutte quelle misure a favore di quelle palesemente capitaliste e persino neoliberiste, osservando che era avventato voler fare il socialismo nel bel mezzo di una crisi. Ma c’è sempre una crisi, e in effetti non è in tempo di guerra e depressioni, che vengono fatte le rivoluzioni? Ci stiamo perdendo un passaggio in tutta questa discussione?
III.
Ci sono due pezzi mancanti: uno si chiama rivoluzione culturale e l’altro si chiama partito. Sospendendo per il momento la discussione sull’utopismo, la tradizione ha generalmente immaginato il rapporto delle due entità – socialismo e comunismo – come un processo cronologico o evolutivo. Prima viene la costruzione del socialismo e solo dopo il comunismo diventa visibile all’orizzonte. Ma poi, la stessa domanda pratica che abbiamo affrontato in precedenza si presenta in una nuova forma: volevamo sapere come si è passati dal capitalismo al socialismo; ora vogliamo sapere come si passa dal socialismo al comunismo. In tutte queste questioni periodiche si annida un problema filosofico: la dialettica dell’identità e della differenza. È come se avessimo bisogno di un’identità fondamentale del capitalismo e del socialismo perché quest’ultimo emerga, come disse una volta Marx, «dal grembo» del primo. Questa è sempre stata la posizione socialdemocratica: dalle riforme fondamentali all’interno del sistema – regolamenti, nazionalizzazioni, ecc. – potrebbe emergere un altro sistema. Storicamente ciò non è mai accaduto, e il vecchio sistema del profitto si è sempre dimostrato abbastanza potente da assorbire quei cambiamenti e riemergere rafforzato o almeno allargato. Ciò che dunque dimostra di aver motivato questo programma o questa strategia è proprio la paura della violenza: la riforma è una rivoluzione pacifica, o vuole esserlo. Ma sembra che anche quelle rivoluzioni siano sempre fallite.
Prendiamo un’altra situazione storica concreta. Alla fine della guerra civile, l’Unione sovietica è in crisi; e in particolare i contadini non consegnano il grano alle città: Stalin affrontò una situazione analoga nel 1927. La soluzione di Lenin, però, non fu la collettivizzazione forzata ma piuttosto (come sostenevano alcuni compagni) la parziale reintroduzione del capitalismo, la cosiddetta Nuova politica economica (Nep), che sarebbe stata a tutti gli effetti abrogata dopo la sua morte. Negli ultimi anni e durante la sua ultima malattia, Lenin fu portato a riflettere sulle vie d’uscita da questa crisi, sui modi in cui i contadini, che tradizionalmente vogliono la terra e la proprietà privata, possono conciliarsi con le esigenze delle città e del nuovo regime socialista. Riflette su Robert Owen e le cooperative nel suo ultimo testo (rimasto inedito fino a molto tempo dopo).
Ma ha anche un’altra idea, ed è quella per cui inventa un nome, ovvero rivoluzione culturale. Si vede che funziona per così dire in senso opposto rispetto alla teorizzazione di Mao Zedong, che voleva conciliare gli intellettuali, e anche le città e gli operai, con la mentalità dei contadini. Lenin vuole elevare la mentalità dei contadini al livello degli operai e riconciliarli con la proprietà cooperativa; in un altro paese e in un altro momento della storia, questo è quello che Che Guevara chiamerà «incentivi morali», ma è uno slogan un po’ troppo restrittivo, così come la campagna per l’alfabetizzazione dà solo un quadro parziale del processo di rivoluzione culturale, che deve coinvolgere a pieno la letteratura tanto quanto chi è «moralmente impegnato»; deve significare cambiamento per tutti e tutte, e non solo contadini o intellettuali.
Ebbene, come sappiamo, nessuno di questi sforzi ha avuto successo e nel frattempo, con l’agrobusiness e la rivoluzione verde capitalista, i contadini sono scomparsi in tutto il mondo, e la sua ex popolazione è diventata braccianti e proletari. Ma almeno ora possiamo vedere cosa mancava nella nostra precedente discussione. È la rivoluzione culturale che era assente dalla nostra visione del passaggio dal socialismo al comunismo; era la rivoluzione culturale che mancava alla nostra teorizzazione della differenza tra politica e utopia. Pensare l’utopia in un modo concretamente significativo richiede di includere il problema della rivoluzione culturale all’interno della nostra teoria.
IV.
Ma ho detto che mancava un altro tassello, ovvero la festa stessa, qualcosa di cui nessuno vuole più parlare, ma che tutti segretamente ricordano come un dilemma da affrontare. A un certo punto all’inizio del suo governo, Gamal Abdel Nasser dichiarò l’Egitto una repubblica socialista. Tutti sono andati a letto quel giorno e si sono svegliati scoprendo che nulla era cambiato. Non c’era un partito socialista, e quindi gli uomini d’affari avevano ancora i loro affari e tutto funzionava come al solito con la possibile eccezione dei cambi di nome: questi erano ora affari socialisti, una burocrazia socialista, ecc. abbastanza gradualmente da dimenticare che ora dovevano essere chiamati socialisti.
A dire il vero, quando pensiamo oggi a un episodio come questo, la nostra prima tentazione è immaginare membri del partito armato che irrompono in quei luoghi, chiedono cambiamenti, cacciano uomini d’affari di mentalità capitalista e così via. Ma questo presume che ci siano anche abbastanza persone per costituire un partito abbastanza grande da svolgere una funzione del genere, che poi, man mano che la nostra immaginazione lo sviluppa, lentamente o meno lentamente si trasforma in esercito e polizia segreta dell’intelligence, ufficiali dell’intelligence su l’ordine della Stasi, gli uomini d’affari, ecc. E, naturalmente, è facile dimenticare che in alcuni luoghi, nella Repubblica Democratica Tedesca (Ddr) per esempio, quelli della Stasi erano i veri intellettuali della rivoluzione. Erano le uniche persone con cui potevi parlare, disse Christa Wolf.
Tuttavia, è improbabile che vorremmo includerli nelle nostre rivoluzioni culturali, figuriamoci nelle nostre utopie. In effetti, questa violenza è una componente chiave di ciò che doveva essere evitato in primo luogo dalla rivoluzione culturale. Dunque, il partito va visto come uno strumento con funzioni sia difensive che offensive: quelle difensive sono quelle che resistono alla violenza della controrivoluzione e che oppongono violenza a violenza o, se si preferisce, oppongono forza a violenza.
Ma la funzione offensiva del partito avrà allora una funzione del tutto diversa, nonviolenta, vale a dire quella di servire da veicolo della rivoluzione culturale; e quindi, nel nostro contesto attuale, fomentare e diffondere, se non l’utopia, almeno l’idea stessa di utopia. Possiamo ricordare il grande grido rivoluzionario di Louis Antoine de Saint-Just al culmine della Rivoluzione francese: «Una nuova idea sta sorgendo sull’Europa: l’idea della felicità!». Così anche qui: ma l’idea è ormai l’idea stessa dell’utopia. La sua propagazione assumerà due forme: la resistenza agli anti-utopisti, o ciò che chiamerei semplicemente anti-anti-utopismo; e la trasmissione, per esempio, per espressione, attraverso la situazione stessa, dell’anticipazione dell’utopia come esperienza.
Ricordiamo qui il dilemma filosofico: l’utopia è una posizione di differenza radicale di fronte all’identità del quotidiano, dello status quo. Ma ciò che è radicalmente diverso da noi è proprio ciò che non possiamo sperimentare, ciò che per definizione è fuori dalla portata della nostra immaginazione. Nella scala del conoscibile e dell’inconoscibile, è di nuovo virtualmente per definizione l’inconoscibile inconoscibile. E questa è naturalmente anche la radice della paura dell’utopia e della resistenza a essa: per conoscere l’utopia, presumibilmente dobbiamo liberarci di tutto ciò che sappiamo, tutto ciò che è significativo nel nostro presente, insieme a tutto ciò che è ripugnante e odioso in esso. È il salto nel vuoto di Søren Kierkegaard e una perdita di tutto ciò che è familiare che non promette nulla in cambio. Anche questa esperienza, non dell’utopia, ma dell’idea stessa di utopia, è un atto di estraniamento. È quindi chiaro quale ruolo debba svolgere il partito in tale conversione; il partito sono gli entusiasti: rappresentano persone che in un modo o nell’altro possono affermare di essersi avvicinate a quell’esperienza, l’estasi del politico, per così dire, di avere l’autorità e la legittimità se non di trasmetterla almeno di trasmetterne il sentimento, la sua promessa interiore.
Ho usato la parola conversione; e l’analogia con la religione si impone certamente, ma nello stesso tempo esige spiegazioni e una certa prudenza. Perché è stato spesso detto che il marxismo era una specie di religione, e questo è generalmente inteso, anche dai critici religiosi, come un disprezzo se non un vero e proprio insulto. Ma non si osserva spesso che questo giudizio, che ha una certa validità, è una strada a doppio senso. Diremmo piuttosto che le religioni sono anticipazioni figurali e superstiziose di un’unità di teoria e pratica che non avrebbe potuto essere disponibile nelle società in cui sono emerse per la prima volta, e che il marxismo è la loro realizzazione secolare nel primo tipo di società – il capitalismo – in cui la loro verità – l’universalismo, la salvezza, la giustizia, l’esistenza dell’Altro – potrebbe almeno cominciare a essere colta come una possibilità realistica. Quindi, le religioni offrono un primo modo in cui l’esperienza dell’utopia (o la sua idea) potrebbe essere colta in modo vago e ancora inadeguato; o, nel nostro contesto attuale, in cui la missione della rivoluzione culturale potrebbe iniziare a essere formulata.
La rivoluzione culturale è la sovrastruttura di cui il partito è l’infrastruttura. Perché no? Ammesso che teniamo dentro questa formulazione tutta la storicità che essa esige, la concretezza della nostra situazione attuale o storica, i suoi limiti unici, la natura degli ostacoli non solo della tradizione ma del qui e ora, e non ultime le inevitabili deficienze delle e degli intellettuali chiamati a fare la loro parte in quello che deve essere un esperimento politico e storico radicalmente nuovo.
V.
Forse adesso è opportuna un’ulteriore parola sulla religione. Per Alain Badiou, l’avventura storica del cristianesimo (ma potrebbe valere anche per le altre «grandi» o «maggiori» religioni) sta nel suo universalismo, nel suo successo politico nel mobilitare masse di persone e creare le proprie sovrastrutture, la propria rivoluzione culturale, intorno a sé. Sono d’accordo che questi sono esempi immensamente istruttivi e impressionanti, ma dico anche che nel mondo secolare non possono più avere la stessa efficacia.
Concordo anche sul fatto che il marxismo, o il socialismo se preferite, dovrebbe emulare quell’universalismo per affermarsi, come sembrava sul punto di fare durante la Guerra fredda. Immanuel Wallerstein, tuttavia, era abbastanza preveggente da sostenere che quest’ultima non era una lotta tra due sistemi, ma piuttosto la lotta tra l’unico sistema dominante del capitalismo e ciò che chiamava forze o movimenti «antisistemici», di cui il socialismo non era il solo.
Più avanti, troviamo il caso istruttivo di Robert Heilbroner, un economista mainstream che ha sempre avuto una certa tolleranza per il marxismo ma che, dopo la «caduta», ha suggerito che il socialismo fosse ancora possibile ma solo come una sorta di enclave religiosa come lo stato islamico, aperto ai veri credenti ma non universalmente praticabile. Così l’Utopia ritorna alle sue origini e alle condizioni monastiche dell’originaria Utopia di Tommaso Moro, essendo Moro stato un cattolico romano che o si faceva beffe delle fantasie utopistiche nel suo sforzo letterario-sperimentale oppure ne deduceva le vere origini nel monastero come forma (probabilmente entrambe le cose).
Ma la religione non è più praticabile nel mondo secolare, se non come etica – l’opposizione tra credenti e non credenti – e il consumismo o consumo come suo rituale. In tal caso, il compito dell’immaginazione utopica starà nel trovare un sostituto dell’etica nella politica e trovare un sostituto della sussunzione nell’estetizzazione della vita (su cui Herbert Marcuse e Paolo Virno hanno scritto pagine luminose).
Dell’«estetica» in quanto tale si può certamente dire che oggi, insieme a tutte le altre discipline specialistiche, come la filosofia, è lettera morta. Walter Benjamin, tuttavia, si oppose all’estetizzazione nel contesto del trionfo fascista in Europa. I marxisti del dopoguerra hanno usato l’estetizzazione come contrappeso al produttivismo e una via d’uscita da quella che vedevano come la camicia di forza della teoria e della pratica marxista orientale.
Ma mi sembra che l’estetica possa includere entrambi: è un produttivismo a sé stante, e molte estetiche moderniste hanno insistito sul processo di produzione (energeia) in contrapposizione al prodotto inerte (ergon) come verità dell’arte in primo luogo. D’altra parte, offre la possibilità di un mondo-oggetto, un mondo prodotto dall’uomo, un’età umana, come amava denunciarla Wyndham Lewis, in cui non possiamo fare a meno di renderci conto che questo mondo è la nostra produzione e la nostra prassi. La scommessa utopica qui sarebbe che in un mondo siffatto il consumismo nella sua forma di dipendenza non sarebbe più necessario e si ridurrebbe a proporzioni gestibili (Il flagello ancora peggiore delle nostre società, quello degli stupefacenti, presenta lo spettacolo di un’altra esaltazione del «naturale» – e senza dubbio dello stesso rituale religioso che un ulteriore progresso nella farmacologia e soddisfazione nell’«attività» [parola di Hegel, Tätigkeit] o la produzione – quella di Marx – potrebbe essere in grado di placare. In ogni caso, forse potremmo aggiungere la dipendenza agli argomenti più profondi di qualsiasi letteratura critica veramente socialista).
VI.
Alla luce di tutto ciò, mi permetto di dire qualche parola sul mio impegno in An American Utopia. È un testo che è stato imbarazzante presentare all’estero, in particolare in paesi in cui la brutale repressione dei regimi militari non induce i suoi ascoltatori a grande affetto o simpatia per tali istituzioni. Alcune di queste differenze interne possono essere evidenziate per sottolineare le difficoltà uniche di una politica di sinistra in quello che oggi chiamo il «superstato». Gli Stati uniti, come suggerisce questa espressione, non sono uno stato-nazione e non possono quindi attingere alle risorse affettive di un nazionalismo più antico; anzi quelle risorse, nella misura in cui mobilitano comunità distinte, tendono a lavorare a favore dei movimenti fascisti e controrivoluzionari.
Ma penso innanzitutto alla particolarità del nostro sistema federale e all’esistenza della nostra Costituzione. Tutta la legittimità dello stato è stata finora fondata su una sorta di feticismo, sia di un evento o di un leader o di un oggetto di qualche tipo: la presa della Bastiglia, la persona di Nelson Mandela, il rispetto per una capitale o un sacro campo di battaglia. La legittimità è quindi, a lungo andare, una sorta di totemismo; e Kant ha giustamente sottolineato la novità storica per cui questo feticcio fondativo si è trasformato per la prima volta in una costituzione scritta e in una documentazione di diritti oltre che di doveri e obblighi. Nessun uomo di sinistra americano intelligente vorrebbe chiedere l’abrogazione di un documento come questo che protegge noi tanto quanto il nemico di classe, e ciò nonostante sia uno dei documenti controrivoluzionari di maggior successo mai concepiti e che si proietta fino a garantire l’impossibilità della rivoluzione negli Stati uniti.
Lo fa principalmente attraverso la sua organizzazione come sistema federale; e bisogna dire, fin dall’inizio, che qualsiasi utopia deve confrontarsi con la logica e la necessità del federalismo per avere una presa sulla realtà politica di oggi. Il federalismo è la rivendicazione della Differenza, contrapposta all’uguaglianza e all’Identità della democrazia diretta, ed è lo scoglio su cui sono naufragate sia l’Unione Sovietica che la «ex» Jugoslavia.
Perché il federalismo esprime non solo l’eterogeneità delle popolazioni coinvolte, ma anche e soprattutto le disuguaglianze del territorio, della terra da cui tutti in ultima analisi dipendiamo. I territori di ogni unità nazionale sono disomogenei rispetto alle risorse naturali, alla ricchezza del suolo, all’accesso all’energia, e così via: solo un sistema federale può garantire che le aree più ricche dello Stato contribuiscano al miglioramento delle parti più sterili (questo vale tanto a livello internazionale quanto a livello nazionale, dove entra in gioco l’ecologia insieme al cosiddetto sottosviluppo, all’inquinamento industriale e simili). È poi chiaro anche perché, nelle situazioni opportune, le parti più ricche di un sindacato desidereranno ritirarsi e abbandonare quelle più povere o cercare un accordo in cui la dipendenza e il sottosviluppo possano essere sfruttati a scopo di lucro.
La Costituzione americana, anche per diverse ragioni storiche (schiavitù), assicurava come meglio poteva una certa sicurezza degli Stati più piccoli e più poveri rispetto a quelli più ricchi. Ma ciò conduce, come una sorta di danno collaterale inaspettato, alla situazione di decentramento politico odierno, in cui i movimenti di sinistra non riescono a conquistare alcun tipo di consenso o egemonia generale e sono condannati a un’efficacia locale o statale e quindi sono necessariamente negati a qualsiasi possibilità a lungo raggio.
Di fronte a questo dilemma strutturale, ho suggerito che potrebbe valere la pena considerare la disponibilità politica di una delle poche forme politiche trans-statali, un’istituzione in grado di agire oltre i confini statali senza in alcun modo sfidare le strutture poste dalla Costituzione: quelle potrebbero rimanere in vigore, allo stesso tempo, potrebbe entrare in gioco una loro trascendenza che esisterebbe su un altro piano e non sarebbe tecnicamente in conflitto con esse, vale a dire l’«universalità» delle forze armate. Da qui il linguaggio storico del doppio potere, mutuato da un momento chiave della rivoluzione russa. Questa formulazione sarebbe una terza possibilità, da aggiungere, nel caso statunitense, all’alternativa gramsciana tra le guerre di posizione e le guerre di manovra, tra la presa del potere o la lunga marcia socialdemocratica attraverso le istituzioni: Palazzo d’Inverno o urne.
Nel frattempo, l’esistenza stessa dell’esercito come istituzione – e in molti casi progettata per produrre un’omogeneità nazionale dalle molteplici lingue e identità della nazione già esistente – potrebbe servire, in un tale manifesto utopico, a trasmettere qualcosa per come una vera forma di partito potrebbe essere reinventata e in cosa potrebbero consistere i suoi nuovi poteri e capacità. Ma come tutta la politica, questa proposta si basa su una situazione contingente, sulle realtà americane (o nordamericane) chiaramente non necessariamente adattabile ad altre situazioni nazionali.
VII.
Ma la questione utopica è infinita – forse sta qui l’utilità del tema – e ci sono sempre altri problemi da notare, dilemmi da sottolineare, contraddizioni da dimostrare «trionfalmente». Sì, ho cercato spesso di insistere sulla paura dell’utopia, in quanto il passaggio dal noto all’ignoto, il sacrificio di tutto ciò che abbiamo inventato per rendere vivibile la vita al di qua dell’utopia, la prospettiva di una profonda trasformazione esistenziale del sé e delle sue relazioni con gli altri e con la natura: sono davvero questioni spaventose. E, naturalmente, perché cambiare qualcosa se ti senti abbastanza a tuo agio nella tua esistenza? Il che è sicuramente il caso di una parte sostanziale del pubblico statunitense.
Supponendo, tuttavia, che siamo motivati a varcare questa soglia epocale sia da fattori interni – disagio soggettivo – che esterni – povertà, disastro ecologico – cosa dobbiamo affrontare dopo quella che è stata chiamata «la fine della storia», che nel nostro contesto significa semplicemente l’egemonia globale americana, il trionfo del libero mercato e del suo sistema rappresentativo di «democrazia» elettorale; o quella che Marx chiama «la fine della preistoria», intendendo una forma di socialismo o comunismo che sta attento a non definire mai?
Molte di queste domande non fanno altro che riprodurre quelle fondamentali: la questione dei sindacati, per esempio, non fa altro che riprodurre l’antagonismo tra interessi individuali e interessi sistemici – il sistema, nel capitalismo, essendo le esigenze dell’accumulazione e la conservazione dei meccanismi del profitto, mentre nel socialismo prenderebbe la forma di quello che ho chiamato federalismo, cioè la necessità di conciliare l’inevitabile disuguaglianza delle varie parti e partecipanti. Entrambi, paradossalmente, sono forme di potere duale: il sindacato nel capitalismo pretende di occupare lo spazio di una democrazia dei lavoratori, mentre nel socialismo, idealmente, è il partito che, sostituendosi al management, pretende di rappresentare gli interessi di un diverso tipo di totalità rispetto alle esigenze individuali. Ecco perché Solidarnosc (con un piccolo aiuto della Chiesa cattolica romana) è diventata una forza reazionaria non appena ha vinto; e perché, nel meraviglioso romanzo di Francis Spufford L’ultima favola russa, il partito non è in grado di utilizzare il suo nuovo magico sistema informativo per aderire alle richieste dei lavoratori.
Ma questo è un conflitto che non può essere risolto filosoficamente, vale a dire, in astratto e per sempre, come una specie di nuova legge. Ciascuno di questi conflitti sarà contingente e potrà essere risolto solo su una base storica unica. Questo è ciò che si intende per persistenza dell’antagonismo nell’utopia, o meglio, per trasferimento degli antagonismi della lotta di classe a quelli dell’ontologia stessa.
Ho detto che ogni utopia si scrive contro certe obiezioni culturali correnti; e questo è stato certamente il caso di An American Utopia, dove il nemico apparente era la prospettiva della noia e di un mondo ricoperto di caramelle in cui non ci sono più conflitti e tutto si presenta in tonalità pastello. Ma ovviamente e per definizione, c’è sempre un conflitto generazionale: è il principale pericolo interno per qualsiasi tipo di sistema utopico; e poi ci sono questioni come quella dei sindacati che illustrano una tensione tra gli interessi individuali empirici e quelli della totalità.
E poi c’è la burocrazia: che dire della sua critica? E tutti i giudizi negativi sul socialismo non sono in definitiva obiezioni alla burocrazia? (Quindi, il terrore stesso, gli arresti, i processi e simili, sono sicuramente a lungo termine da attribuire alla rigida burocrazia dello Stato e della sua polizia?). Ma ho cercato di sottolineare altrove che ciò che abbiamo chiamato «i dissidenti» sono dissidenti socialisti e una parte organica di ogni genuina cultura socialista.
L’argomento fondamentale di ogni letteratura propriamente socialista è la critica della burocrazia; il compito fondamentale di una cultura socialista sta proprio nella sua attenzione alle debolezze e al malfunzionamento del sistema.
Tutto ciò equivale a quella che sia Antonio Gramsci che György Lukacs chiamavano «la fine del Capitale», o, in altre parole, del libro e della critica del sistema che metteva in scena. È ciò che Jean-Paul Sartre intendeva, credo, quando disse che a questo punto della storia (la fine della preistoria, come direbbe Marx), il marxismo lascerà il posto all’esistenzialismo e all’ontologia. I dilemmi che fino ad allora erano politici ora vengono combattuti a livello ontologico.
Così le relazioni individuali e le loro incompatibilità non scompaiono ma entrano a far parte dell’avventura esistenziale della vita individuale. Per quanto riguarda gli antagonismi di gruppo, forse Callenbach ha ragione, e la secessione è una soluzione che qualsiasi federalismo deve prevedere (a condizione che sia in qualche modo integrata nello stesso stato globale in modi nuovi). Ci viene detto che vari tipi di persone vogliono vivere da e tra di loro: se non si tratta di conflitti per la terra – una delle questioni primarie dell’attuale politica mondiale, come ho cercato di mostrare altrove – una forma di autonomia all’interno del federalismo sembra offrire una soluzione soddisfacente (e probabilmente una soluzione che alla lunga si dissolverà da sola).
Per quanto riguarda il conflitto con la Natura, il paradosso deve essere questo: che per avere un degno antagonista, per restituire alla Natura ciò che è stata tradizionalmente, cioè il nemico fondamentale di un genere umano autonomo, la Natura stessa deve essere ripristinata dal suo stato avvelenato, indebolito, o in altre parole dalla condizione in cui gli esseri umani moderni l’hanno lasciata, e resa di nuovo adatta a essere il mondo in cui solo noi possiamo esistere. Il paradosso sta nel modo in cui, come specie naturale all’interno di una totalità organica, ci siamo resi semiautonomi e capaci di vivere indipendentemente da quel sistema, all’interno del quale, però, solo noi possiamo esistere. Potremmo, ovviamente, diventare completamente autonomi e separati da quel sistema, ma ciò significa autoannientamento. Come specie, quindi, rievochiamo il dramma di tutti i separatismi, ma su una scala che è quella terminale per noi.
Sì, ho insistito, forse troppo, sulla «morte del soggetto» (vecchia e logora melodia strutturalista) e sul nulla sartriano della coscienza, ecc. dunque cerco di correggere altri fraintendimenti dell’utopia, del comunismo, della politica e, a lungo andare, immagino, dell’esistenza stessa. Come tante altre cose, ciò può essere facilmente scambiato per nichilismo, o forse dovrei dire, riconosciuto per il nichilismo che in parte è. Ma ancora una volta, voglio sottolineare un’ambiguità di fondo nell’argomentazione: la vita può benissimo non avere significato, oppure il suo significato è che come specie abbiamo una funzione fondamentale, dopo di che siamo del tutto inutili e da scartare come una scarpa logora. Il mio punto, tuttavia, sarebbe che siamo noi stessi a dare un significato a quella vita senza senso e che non abbiamo bisogno che la natura lo faccia per noi.
Questo testo è uscito in originale su JacobinMag. La traduzione italiana è a cura della redazione di Jacobin Italia.