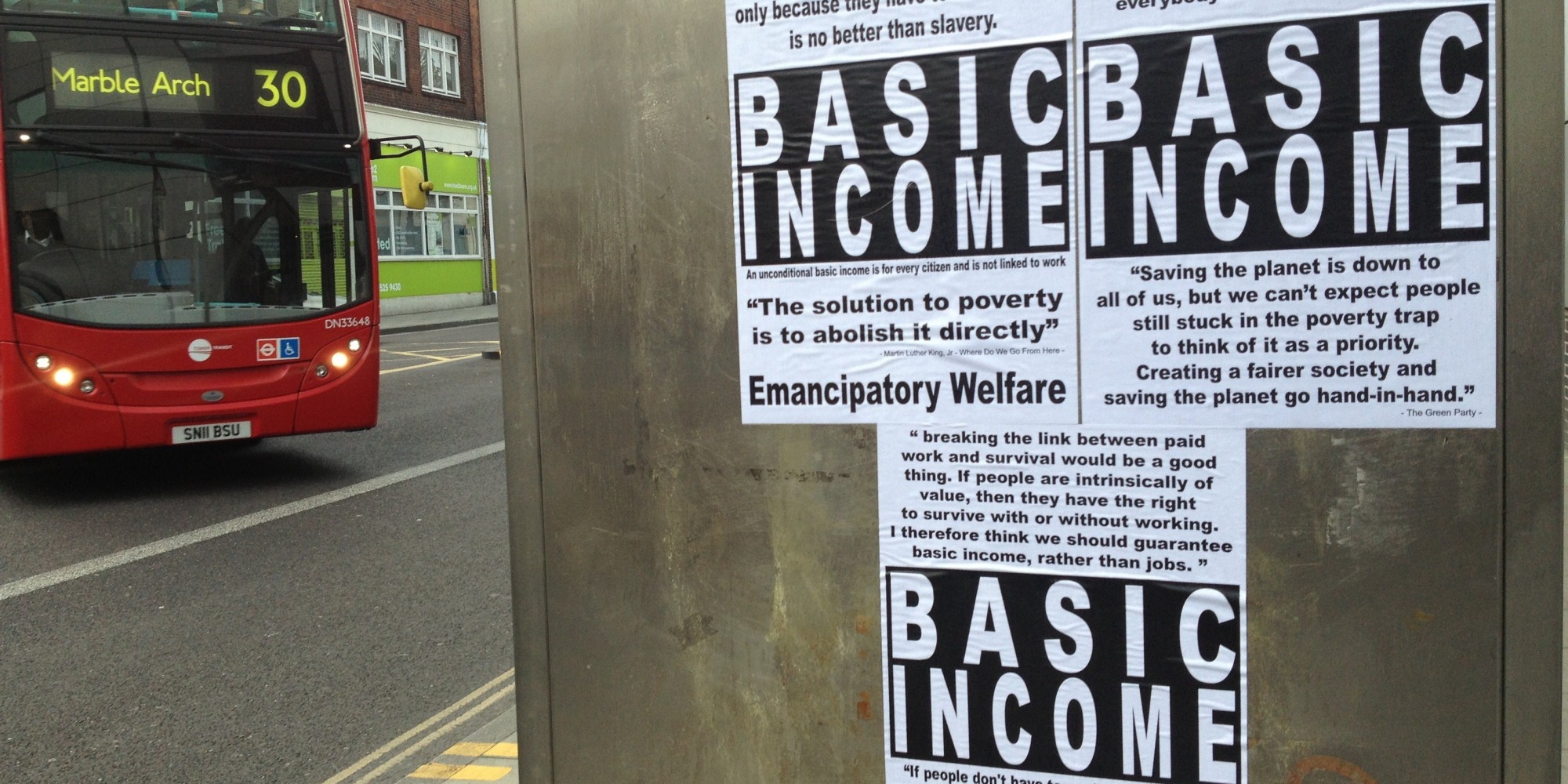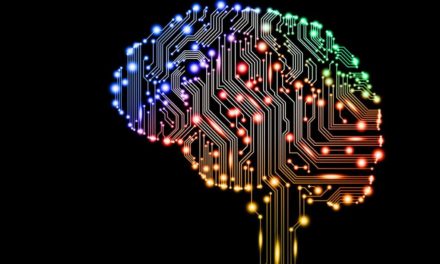di GIROLAMO DE MICHELE.
La speranza è una passione triste che rimuove la realtà del presente, diceva Spinoza. È una trappola: «una cosa infame inventata dai padroni», dice Mario Monicelli nel suo videotestamento spirituale.
È la trappola nella quale è caduta Taranto con la fabbrica, come riconosce uno degli operai intervistati da Marta Vignola nel suo La fabbrica. Memoria e narrazioni nella Taranto (post)industriale (Meltemi, pp. 214, € 16): libro d’inchiesta, ma anche di denuncia del paradigma dello sviluppo e del progresso. Libro che mette al lavoro la memoria, attraverso interviste narrative incrociate con un’accurata conoscenza dei documenti e dei fatti; ma che fa, anche, della memoria oggetto d’indagine, come riconosce Paolo Jedlowski nella presentazione, perché «la formazione di una memoria collettiva è un processo sociale». E anche, perché l’accumulo delle voci dell’inchiesta decostruisce la memoria apparente e consolante, il falso ricordo di un’età dell’oro pre-Italsider nella quale distese di ulivi e fiumi e mari cristallini si sposavano in una sorta di Arcadia.
In realtà, il rapporto di servaggio della città verso la fabbrica, che come il mostruoso Alien la tiene in vita, ma al tempo stesso la sfrutta finché non la uccide, era già precostituito alla fine dell’800, con la costruzione di Arsenale militare e cantieri Tosi che, al tempo stesso, fanno “progredire” la città verso la modernità, ma al prezzo di bloccarne lo sviluppo, impedire la formazione di un ceto imprenditoriale dinamico e svincolato dal clientelismo, e creano le condizioni di sistema per spuntare la forza della nascente classe operaia. a condizione, mistificata nella “vocazione militare” di Taranto, germinò il conseguente scivolamento verso la fascistizzazione.
Lo stesso dispositivo si concretizza nel dopoguerra, attraverso l’intervento pubblico che favorisce lo sviluppo industriale del Meridione, ma lo incanala al servizi delle esigenze e degli interessi dei gruppi capitalistici e industriali del Nord, come riconosce un Rapporto Svimez del 1991 citato nel libro, che sembra parafrasare quanto avevano scritto Ferrari Bravo e Serafini già nel 1972 in quello Stato e sottosviluppo che resta tutt’ora imprescindibile.
Vignola è puntuale nel mostrare la costruzione dei falsi miti della «retorica sviluppista» che accompagnarono la creazione dell’Italsider, coprendo di fiori le catene di un «colonialismo assistenziale che considerò territorio e società come oggetto di esperimento e sfruttamento ad opera di tecnocrati aziendali e presunti riformatori», attraverso una clientelizzazione dei rapporti sociale della quale il sindacato è stato complice consapevole. Le voci dell’inchiesta scandiscono così, attraverso la costruzione di una memoria sociale, le fasi che portano Taranto a divenire colonia che si interpreta come “capitale dell’acciaio”, fino alla crisi del modello industriale, alla devastazione sociale che ne fa la «Beirut del Sud», e all’esplodere della questione ambientale, con la progressiva consapevolezza dell’essere una città di guerra, con le sue prime linee, i coprifuoco, i caduti e le morti che un tempo si dicevano bianche: «un’identità ferita e resa fragile ma anche pienamente consapevole dai danni che un modello di sviluppo ha prodotto sui propri corpi».
Fino all’ultima illusione: quel fermento che si diffonde con l’avvento di una nuova classe dirigente – i Vendola, gli Stefàno, i Fratoianni: le “buone pratiche pugliesi” – che generano una presa di coraggio e la percezione che il vento possa cambiare.
Fino al tradimento della “legge di interpretazione autentica” (Legge n. 8/2009: Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 44) che recepisce il protocollo d’intesa fra Regione, governo, Ilva e sindacati; con le parole di uno degli intervistati, operaio Ilva:
Poi c’è stata la presa per il culo della legge antidiossina. Ne parlavano tutti i giornali, sembrava che finalmente qualcuno era interessato alla nostra aria ma poi come si dice partono tutti incendieri e poi tutti pompieri. Insomma accordi protocolli col Governo sicuramente con l’azienda e alla fine viene fuori l’ennesima legge che non serve a niente e lo sappiamo tutti e lo sanno pure loro!.
La legge 8/2009, infatti, svuotava la “legge antidiossina” 44/2008, rendendola «una normativa assolutamente inefficace a contenere l’inquinamento dell’Ilva», una scatola vuota nella quale l’azienda poteva mettere i numeri che voleva:
Si scelse, infatti, di effettuare i controlli solo in tre fasi durante l’anno, a settimane alterne e per otto ore diurne. Si rinunciò al campionamento continuo, l’unico strumento unanimemente riconosciuto per tenere sotto controllo le emissioni di diossina e salvaguardare la salute dei cittadini. [Inoltre], la Regione concordò una proceduta che consentiva che tali fumi potessero essere diluiti aggiungendo aria, risultando in questo modo una maggiore percentuale di ossigeno in grado di falsare i valori di diossina eventualmente riscontrati.
Non basta: il numero delle centraline rimase del tutto insufficiente al bisogno; le misurazioni dei fumi vennero effettuate all’uscita dalle canne, e non alla base, nonostante la dispersione di fumi (visibile a occhio nudo e documentata da numerosi rilievi fotografici) nel passaggio dovuta alla vetustà dei camini; infine, «il valore di emissione derivato da ciascuna campagna è ottenuto operando la media aritmetica dei valori misurati, previa sottrazione dell’incertezza pari al 35 per cento per ciascuna unità di misura (corsivo mio)» [L. 8/2009, art. 1, comma 2, c].
È il momento in cui la classe dirigente pugliese si schiera nel conflitto fra padrone e ambiente col padrone – i “comuni valori cristiani” che Vendola rivendicò fra sé ed Emilio Riva (si veda il magazine dell’Ilva Il ponte, n. 2, 2011, p. 22, scaricabile qui):
Chiesi ad Emilio Riva, nel mio primo incontro con lui, se fosse credente, perché al centro della nostra conversazione ci sarebbe stato il diritto alla vita. Credo che dalla durezza di quei primi incontri sia nata la stima reciproca che c’è oggi.
Il momento delle telefonate per “frantumare” il direttore dell’ARPA, e dei divertiti complimenti al factotum dell’Ilva che aveva impedito a un giornalista di porre una domanda ad Emilio Riva strappandogli di mano il microfono; il momento dell’opposizione al referendum popolare, fianco a fianco con Emma Marcegaglia (oggi interna alla cordata proprietaria dell’Ilva), che alla presenza di Vendola e Riva poteva affermare senza contraddittorio che
Se le imprese perseguissero solo ed esclusivamente i criteri ambientali sparirebbero nel giro di poco tempo, ma soprattutto resterebbero aziende che non fanno il loro mestiere. Ecco perché all’Ilva va riconosciuto il merito di aver saputo coniugare ambiente e competitività. Il referendum è una follia.
Fino a quel 26 luglio 2012 nel quale tocca alla magistratura affermare, in una città in cui «un morto o un malato in casa non è la singolarità, ma una narrazione condivisa», che salute e vita umana sono “beni di rango costituzionale” non assoggettabili ad alcun compromesso.
 «Le verità che si costruiscono nel processo penale sono forme di verità che abbracciano l’intero corpo politico e sociale», scrive Vignola citando Foucault: verità senza redenzione per una città che fatica a esprimere un’identità comune, al di là di alcune manifestazioni effimere – l’amore per un mare che è anch’esso inquinato, per una birra che di locale mantiene solo il nome, il tifo per una squadra precipitata nelle serie minori. «Il postindustriale, lascia in eredità, come è evidente dai racconti, una forte mancanza di valori collettivi e una fragilità di legami sociali che conduce il più delle volte a non riconoscersi come comunità». È in questa nostalgia di una impossibile memoria condivisa che si radica, nella condivisione di un «destino mortifero», il «ricordo comune legato all’affetto per la figura di Erasmo Iacovone», il giovane centravanti che con i suoi goal stava portando in serie A una squadra abituata a lottare nei bassifondi della classifica, la cui vita fu stroncata da un incidente d’auto. La vera e propria venerazione per la sua figura, da parte di generazioni che non lo hanno mai visto giocare, è anch’essa il segno di «memorie ferite che esprimono ciò che poteva essere»: memorie del futuro tradite.
«Le verità che si costruiscono nel processo penale sono forme di verità che abbracciano l’intero corpo politico e sociale», scrive Vignola citando Foucault: verità senza redenzione per una città che fatica a esprimere un’identità comune, al di là di alcune manifestazioni effimere – l’amore per un mare che è anch’esso inquinato, per una birra che di locale mantiene solo il nome, il tifo per una squadra precipitata nelle serie minori. «Il postindustriale, lascia in eredità, come è evidente dai racconti, una forte mancanza di valori collettivi e una fragilità di legami sociali che conduce il più delle volte a non riconoscersi come comunità». È in questa nostalgia di una impossibile memoria condivisa che si radica, nella condivisione di un «destino mortifero», il «ricordo comune legato all’affetto per la figura di Erasmo Iacovone», il giovane centravanti che con i suoi goal stava portando in serie A una squadra abituata a lottare nei bassifondi della classifica, la cui vita fu stroncata da un incidente d’auto. La vera e propria venerazione per la sua figura, da parte di generazioni che non lo hanno mai visto giocare, è anch’essa il segno di «memorie ferite che esprimono ciò che poteva essere»: memorie del futuro tradite.
Resta, nel presente, lo strazio biopolitico della negazione delle più elementari manifestazioni del vivere – una fra tutte, la maternità negata al corpo delle donne sottoposte alla spada di Damocle di tassi tumorali superiori dal 20 al 100% rispetto alla media, del rischio di tumori infantili nei nascituri sin dai primi anni, dell’obbligo si sostituire il latte materno, che trasmette diossina, col latte artificiale: sottoposte al potere del patriarcato e del capitale, ben esemplificato da quel «due tumori in più all’anno, che vuoi che siano? Una minchiata» col quale i Riva, i padroni dai “comuni valori cristiani”, irridevano nelle loro telefonate i morti; né libere né uguali, con buona pace delle accorte correzioni semantiche che vorrebbero sublimare la tragedia nella tragedia dell’essere donna a Taranto.
Resta l’orrore di un deserto chiamato progresso, che ancora non ha trovato riparazione simbolica né vede possibilità di riscatto, se non in alcune pratiche “dal basso”, nate dalla presa di coscienza dell’essere diventati i diritti sociali, nell’età del neoliberalismo, «una variabile dipendente dall’economia», e dalla rottura con i paradigmi interpretativi riformisti che vagheggiavano una fabbrica pulita (e un padrone buono) – cui fa da contraltare la frantumazione dell’ambientalismo locale che ha riconsegnato la città nelle mani del partito dell’ILVA.
Soffia, al termine del libro, un vento gelido, nel quale il possibile paragone di Taranto con la città calviniana di Zenobia che «riesce a dar forma ai desideri» non può nascondere che l’alternativa è che, Taranto sia città di quelle, per riprendere l’immagine di Calvino, «in cui i desideri o riescono a cancellare la città o ne sono cancellati». E allora Taranto finisce per assomigliare a Leonia, la città che accumula montagne di rifiuti, fino ad esserne travolta.
una versione più breve di questa recensione è stata pubblicata sul manifesto del 7 novembre 2017