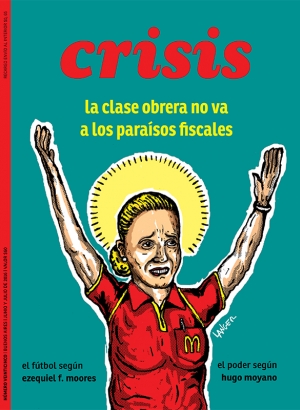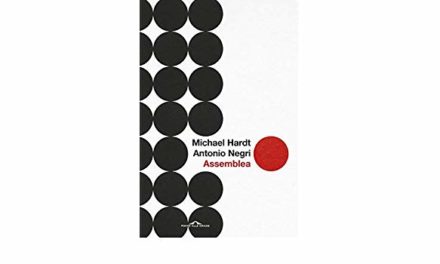di JACOPO SERMASI.
20/05/2012
1. Introduzione: nascita del fenomeno, caratteristiche e dati empirici
Sebbene risulti alquanto complicato determinare una data alla quale fare risalire l’inizio della crisi argentina (per le cui origini occorre risalire alle politiche socio-economiche della dittatura militare verso la fine degli anni ‘70), possiamo affermare che il 1999 è l’anno in cui questa venne ufficialmente dichiarata, esplodendo tanto in ambito economico che istituzionale.
Alcune cifre possono aiutare a comprendere la gravità della situazione toccata dal paese tra il 1999 e il 2002. In 4 anni, ben 7 persone occuparono il seggio presidenziale. Di queste, 5 in appena 3 settimane. In seguito a una rapida ascesa, il tasso di disoccupazione arrivò a superare il 25% della popolazione attiva (dato al quale va aggiunto la incalcolabile mole di sotto-impiegati), e il debito internazionale superò i 140.000 milioni di dollari (2001), rappresentando cioè il 164% del PIL argentino. Nel 2002 l’amministrazione decise quindi di porre fine alla fittizia parità tra il peso e il dollaro stabilita negli anni ’90 dall’allora governo di Carlos Menem, senza dubbio il principale responsabile del collasso economico-istituzionale del paese. La disuguaglianza sociale e l’aumento della distanza tra ricchi e poveri si convertì presto nella nota dominante della crisi. Al contempo che la classe media più importante dell’America Latina sprofondava nella povertà, coloro che poveri lo erano già si trovarono completamente emarginati e senza alcun mezzo di sussistenza. Tra il maggio del 2001 e l’ottobre del 2002, il salario medio si ridusse del 65%, il numero di cittadini al di sotto della linea di povertà passò dal 35,9% al 61,3% con quasi il 30% della popolazione dichiarata indigente (fonte: INDEC). Il panorama industrialmente risentì ugualmente dalla gravità della crisi.
Risulterebbe difficile comprendere il fenomeno delle imprese recuperate senza inserirlo in questo preciso contesto storico. Sebbene siano conosciuti casi di occupazioni già a partire dagli anni ’70, solamente nella seconda metà degli anni ’90 iniziano a prodursi quei processi di recupero che porteranno alla nascita dei movimenti di Fabbriche e Imprese Recuperate. Tra questi vanno sicuramente ricordati i più significativi come il caso dell’impianto frigorifero Yaguané S.A. (recuperato presso La Matanza nel 1996), la fabbrica metallurgica IMPA (1998, Buenos Aires) e le cooperative dell’area di Rosario. Seguiranno dopo poco fabbriche conosciute anche a livello internazionale per la radicalità politica che ha caratterizzato le rispettive esperienze di lotta e produzione: l’impresa di ceramiche Zanón (Patagonia) e la tessile Brukman (Buenos Aires). Tra il 2001 e il 2002, infine, sorgeranno i principali movimenti, capaci a loro volta di incentivare, coordinare e tutelare la quasi totalità dei successivi processi di recupero: il Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), la Federación de Cooperativas de Trabajo (FECOOTRA) e infine il Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores (MNFRT). La nascita di queste organizzazioni precede di pochi mesi l’esplosione del fenomeno, elemento che evidenzia il ruolo fondamentale svolto da questi movimenti (senza perdere di vista la crisi stessa come principale fattore catalizzatore).
La principale sfida per chi si avvicina al fenomeno delle imprese recuperate è senza dubbio quella di tracciare i confini che lo delimitano. La definizione stessa di impresa o fabbrica recuperata risulta in parte aleatoria dal momento che l’elemento che maggiormente caratterizza questo insieme di realtà produttive è proprio la loro eterogeneità. Risulta difficile spingersi oltre una definizione di impresa recuperata in quanto attività produttiva gestita da quel gruppo di lavoratori che si sono impossessati dei mezzi di produzione in seguito a un processo fallimentare dichiarato dalla precedente proprietà (e nella maggior parte dei casi di carattere fraudolento). Se a questo aggiungiamo, specie nelle prime fasi del processo di recupero, l’assenza di registri ufficiali circa il numero di addetti, le quantità di introiti e le tipologie di pagamento, ci troviamo di fronte alle classiche difficoltà di analisi dei sistemi economici informali. L’appartenenza a una delle organizzazioni prima citate semplifica in parte questo problema.
2. Il processo di recupero: un’ approssimazione alle fasi principali
Così come avviene nel cercare una definizione di “impresa recuperata”, tracciare uno schema di un processo idealtipico di recupero può risultare una compito assai arduo dal momento che sia le dimensioni dell’impresa che, soprattutto, l’atteggiamento dei proprietari variano significativamente per ogni esperienza, determinando conseguentemente strategie reattive e creative di volta in volta diverse. Quel che in generale si può osservare è che maggiore è il livello di conflitto con l’antico apparato dirigente, tanto più le soluzioni organizzative adottate dai lavoratori tendono a essere caratterizzate da alti livelli di eguaglianza (soprattutto retributiva) e di orizzontalità nei processi decisionali.
Se tuttavia vogliamo riassumere le fasi principali di un ipotetico processo di recupero, possiamo inizialmente affermare che nella maggioranza dei casi i lavoratori non ricevono da mesi uno stipendio o vengono pagati mediante dei buoni (cheques), con la costante promessa da parte dei proprietari che tutto verrà retribuito non appena finisca la crisi. Questa situazione continua fino a quando un giorno i proprietari (e generalmente il personale amministrativo), non si presentano alla fabbrica. I lavoratori, dopo aver cercato di prendere contatti con la gerenza chiedendone il ritorno (e con essa la promessa di vedere pagati gli arretrati), hanno infine accesso ai documenti contenuti negli uffici abbandonati, rendendosi conto della realtà dei fatti: questi documenti testimoniano nella maggior parte dei casi la totale assenza di versamenti contributivi (sebbene la quantità sia stata regolarmente sottratta dal conteggio dei salari), la deviazione di fondi alle case madri all’estero e una situazione finanziaria che non poteva che portare al fallimento dell’impresa. È in questo contesto di confusione e abbandono che, anche grazie ai consigli di esponenti dei movimenti, inizia solitamente a germinare l’idea dell’occupazione e dell’espropriazione.
La prima sfida è quella di garantirsi la sospensione del processo fallimentare e impedire il saccheggio dei macchinari1 da parte della precedente proprietà. Per ottenere ciò i lavoratori devono muoversi su due piani completamente distinti: da un lato organizzando picchetti e turni di vigilanza all’interno della fabbrica, col proposito di evitarne il saccheggio e resistere a possibili tentativi di sgombero da parte della polizia; dall’altro, muovendosi sul piano legale con l’intento di portare il curatore fallimentare a sospendere la liquidazione dell’impresa e ottenere l’affidamento in custodia della stessa. Tale possibilità si basa sulle potenzialità aperte dalla Legge 24.522 de 1995 (Ley Nacional de Concursos y Quiebras – in particolare Art. 180 e 190 e successive modifiche). Proprio la revisione, nel maggio del 2002, dell’articolo 190 della Legge, è stato letto come uno dei principali successi politici dei movimenti di fabbriche e imprese recuperate. Secondo il nuovo testo infatti:
“Nella continuità dell’impresa si prenderà in considerazione la richiesta formale dei lavoratori in rapporto di dipendenza che rappresentino i due terzi del personale in attività o dei creditori con rapporti lavorativi, che dovranno operare nel periodo di continuità sotto la figura della cooperativa di lavoro”
L’organizzazione dei lavoratori in cooperativa di lavoro, risulta pertanto fortemente incoraggiata dal testo legislativo e sebbene non sia l’unico cammino possibile per raggiungere l’espropriazione, questa figura è stata adottata (anche per ragioni di carattere politico ed economico) in circa il 90% dei casi di recupero.
La durata di questa fase non è determinabile a priori. Il potere di decidere la liquidazione dell’impresa rimane in mano al giudice e la consegna in custodia dello stabilimento ha sempre carattere temporale, in genere di 2 anni, passati i quali i lavoratori dovranno lottare per il suo rinnovo, obbligandoli nel frattempo a una precarietà produttiva e lavorativa che rischia di compromettere il rapporto fiduciario nei confronti dei fornitori e dei clienti2.
Una seconda opzione, probabilmente la più interessante per le conseguenze sia pratiche che teoriche che comporta, è la richiesta di espropriazione dell’impresa da parte del potere legislativo e la sua consegna al collettivo di lavoratori. Affinché questo avvenga, la continuità dell’attività produttiva deve essere riconosciuta in quanto processo di utilità pubblica, come si deduce dalla Legge 21.499 del 1977, Art.1:
“ La pubblica utilità che deve essere il fondamento legale per l’espropriazione, include tutti i casi in cui si procuri la soddisfazione del bene comune, sia questo di natura materiale o spirituale”3.
Trattandosi di una decisione presa dal governo locale competente, ovvero dal potere politico, il fatto di dichiarare un’attività produttiva (e il mantenimento dei posti di lavoro necessari per portarla a termine) un elemento di utilità pubblica in antitesi al diritto di proprietà dei padroni originali, dà luogo a una molteplicità di conseguenze: innanzi tutto si rende evidente un potenziale contrasto tra il diritto al lavoro (che a sua volta si collega con il diritto ad una esistenza dignitosa) e quello alla proprietà, oltre ovviamente a valutare esplicitamente una attività produttiva in funzione della propria utilità pubblica (dimensione generalmente dimenticata dai sistemi economici capitalisti che individuano come principale e talvolta unica condizione la competitività-redditività dell’impresa).
La scelta di questa strategia, che non garantisce affatto ai lavoratori la definitiva tranquillità e la prosecuzione del lavoro in condizioni di normalità, ha come principale obiettivo la semplificazione delle variabili che intervengono nel processo di recupero: se la richiesta di espropriazione si conclude positivamente, i lavoratori si troveranno da quel momento a dover dialogare con una sola e definita proprietà (lo Stato, che facendosi carico dei beni in stato fallimentare si è automaticamente impegnato a saldare i debiti), il cui principale interesse consiste nel trovare nuovi acquirenti, rispetto ai quali i lavoratori vantano diritti di precedenza.
Tralasciando la ragnatela legale che accompagna il complicato processo di appropriazione dei mezzi di produzione da parte dei lavoratori, passiamo direttamente alla fase di riattivazione della produzione e di mantenimento del ciclo produttivo. Nella maggior parte dei casi, occorre innanzi tutto garantire allo stabilimento l’approvvigionamento dei servizi basici (acqua, luce, gas) e riallacciare i contatti con clienti e fornitori. La principale sfida per i lavoratori è a questo punto portare a termine un primo ciclo produttivo grazie al quale ottenere una base di capitale da reinvestire. Oltre ad utilizzare i resti di stock di produzione e le materie prime che giacciono abbandonati nei magazzini, vengono generalmente organizzati diversi tipi di eventi volti all’auto-finanziamento (cene sociali, spettacoli teatrali e musicali, eventi culturali, etc…). È infatti in questa fase che l’impresa recuperata inizia ad aprirsi all’esterno, trasformandosi in qualcosa di assolutamente distinto dalle tradizionali unità produttive. Nell’arco di pochi anni, alcune delle fabbriche visitate (tra queste la metallurgica IMPA, il panificio Grissinopoli e l’Hotel BAUEN), avevano visto nascere al proprio interno scuole pubbliche di quartiere, centri di salute, centri culturali e dedicavano alcuni spazi degli stabilimenti alle attività di numerose associazioni: in un contesto di completo discredito del mondo politico, economico e giuridico, la società civile entrava così nelle esperienze di recupero come unico e reale elemento capace di legittimarne l’esistenza.
I primi cicli produttivi, caratterizzati da incarichi su commissione, rappresentano un arma a doppio taglio. Da un lato infatti garantiscono ai lavoratori (e di solito in anticipo sulla produzione) somme di denaro chiave per la sopravvivenza del progetto di recupero, in parte risolvendo le difficoltà di accesso al credito che soffrono queste realtà. Dall’altro, rischiano di vincolare l’intera produzione a questo tipo di sistema, creando così forme di dipendenza nei confronti di attori esterni che possono arrivare a ricoprire ruoli molto simili a quelli dell’antico proprietario.
Se finalmente i lavoratori riescono a assicurarsi la gestione dell’impresa, vincere le dispute legali e accumulare un capitale sufficiente a saldare i debiti arretrati e pianificare nuovi investimenti, l’impresa recuperata raggiungerà una fase che potremmo definire avanzata, durante la quale la grande incognita è se il modello organizzativo e distributivo si manterrà coerente con gli ideali che avevano animato l’occupazione e la lotta iniziale.
Prima di approfondire quest’ultimo punto, risulta utile tracciare uno schema sintetico degli elementi che caratterizzando i modelli organizzativi adottati dai lavoratori durante il processo di recupero. Senza dimenticare che non esiste esperienza identica ad un’altra, possiamo osservare come nella maggior parte dei casi venga costituita una assemblea generale alla quale partecipano tutti i lavoratori senza distinzione alcuna di ruolo o potere decisionale. Da questo organismo, che si riunisce solitamente con cadenza mensile, dipende il funzionamento reale e l’orientamento politico-economico dell’impresa: è sua prerogativa, per esempio, l’approvazione del bilancio annuale4. Le decisioni vengono prese di norma per maggioranza assoluta e viene generalmente eletto un Consiglio di Amministrazione con poteri limitati la cui funzione è garantire il mantenimento delle funzioni primarie dell’impresa (come per esempio il pagamento delle utenze) e risolvere piccoli problemi (riparare elementi usurati). I ruoli (presidente, segretario, etc.) sono di solito di carattere temporale e soggetti al principio di rotazione5, sebbene quest’ultimo sia spesso uno dei primi fattori a venire meno. Il suo progressivo abbandono, infatti, risulta essere uno degli indicatori più significativi in relazione al rischio di involuzione delle dinamiche organizzative verso logiche di tipo capitalista (differenziazione dei compiti e delle retribuzioni, concentrazione del potere decisionale, etc.). Questa struttura organizzativa risulta certamente suggerita (ma non imposta) dalla forma cooperativa adottata dalla maggior parte delle imprese e al contempo facilitata dall’assenza di grandi differenze settoriali all’interno della fabbrica viste le piccole o medie dimensioni delle stesse. In tutti i casi, le ragioni profonde a cui si deve questo sistema gestionale vanno ricercate nel processo stesso di recupero dell’impresa e nel substrato etico e politico a cui i lavoratori hanno dato vita. È infatti il principio di eguaglianza sviluppato e vissuto attraverso la lotta che porta all’assenza di distinzioni distributive. L’abbandono dell’impresa in seguito al fallimento da parte del personale amministrativo6 a sua volta catalizza questo processo di decostruzione del sistema gerarchico: la partecipazione alla lotta di recupero si impone così in quanto unico elemento capace di legittimare la partecipazione alla gestione dell’impresa.
Il principio su cui si fonda l’intero processo di recupero, ovvero l’autonomia, così come la sua conseguenza organizzativa, l’autogestione, trovano nel percorso formativo di ogni lavoratore una legittimità etica prima ancora che pratica: emergono come necessario riflesso del processo di emancipazione dalla forma di lavoro dipendente e come tale risultano inizialmente condivisi dall’intero collettivo di lavoratori che hanno vissuto detto processo. La radicale ridefinizione del rapporto tra capitale e lavoro avvenuta attraverso la lotta avviene parallelamente allo sviluppo di una nuova cultura del lavoro, fondata su una nuova scala di valori al cui vertice non risiede più il principio di efficienza e competitività, bensì il mantenimento dei posti di lavoro e, per questo fine, l’organizzazione secondo principi di solidarietà e reciprocità.
3. Potenzialità e limiti del fenomeno
Non trattandosi né del primo caso di autogestione della produzione da parte dei lavoratori, né della prima volta che questi si organizzano in cooperative (ridefinendo quindi il rapporto tra capitale e lavoro), risulta legittimo chiedersi se il caso argentino si distingua dai precedenti e per quali ragioni, almeno per chi scrive, rappresenti in campo lavorativo uno degli scenari più interessanti e ricchi di potenzialità analitiche.
La risposta va cercata nelle dimensioni del fenomeno e nel contesto storico-economico nel quale si produce. Con circa 10.000 lavoratori e più di 200 imprese coinvolte (Ruggieri, 2011), i movimenti di fabbriche e imprese recuperate hanno raggiunto quella massa critica capace di trasformarli in un importante attore sociale e politico, tanto da entrare con forza nel dibattito nazionale e capace di influenzare altre esperienze di autogestione sulla scena internazionale7. In secondo luogo, si tratta molto probabilmente del primo caso di autogestione di massa in un contesto di capitalismo avanzato. Quest’ultimo aspetto implica importanti ripercussioni sia a livello pratico che teorico.
La forte rottura che queste esperienze hanno operato nei confronti della logica taylorista che domina la maggior parte dei processi produttivi contemporanei risulta evidente: i lavoratori pongono fine alla frammentazione della conoscenza riguardante il ciclo produttivo, sia mediante il sistema di rotazione degli incarichi sia, soprattutto, condividendo la totalità dell’informazione durante le assemblee generali. Le profonde controtendenze rispetto alle attuali logiche di mercato segnano una significativa distanza rispetto alle tradizionali dinamiche capitaliste: la polivalenza funzionale si sostituisce alla sempre più marcata divisione dei compiti, la garanzia di un impiego fisso si contrappone alla crescente precarietà lavorativa e si mantiene la produzione all’interno dei confini nazionali durante una fase di crisi economica, congiuntura che generalmente catalizza e viene usata come giustificazione per la messa in atto di processi di delocalizzazione produttiva.
Senza mai dimenticarsi che il principale merito e successo di queste esperienze di lotta è senza dubbio il recupero di migliaia di posti di lavoro e di conseguenza del diritto a una vita dignitosa (vida digna, per utilizzare un lemma dei propri lavoratori) di altrettante famiglia, i movimenti di fabbriche e imprese recuperate hanno contribuito attivamente a tracciare nuovi scenari nel panorama dei rapporti di lavoro, sia argentini che globali. L’occupazione, o la sola minaccia di occupazione, da parte dei lavoratori, è divenuta una nuova ed efficace arma sindacale, capace di frenare o bloccare operazioni attraverso le quali molti imprenditori portavano le proprie imprese al fallimento (fraudolento) con l’obiettivo di comprarle successivamente a prezzi ridotti per mezzo di prestanomi: un sistema che in Argentina godeva di ampi margini di impunità (e connivenza con i poteri politici), permettendo grandi guadagni e la sistematica violazione dei diritti dei lavoratori8.
Al contempo, il ruolo assente o negativo svolto dalla maggior parte dei sindacati esistenti, contrari ai processi di occupazione proposti dai lavoratori, hanno reso evidente il rischio della creazione di sistemi istituzionalizzati di “concertazione” tra le parti, nei quali le forze sindacali hanno abbandonato qualunque tipo di logica (e di pratica) di conflitto nei confronti del patronato, trasformandosi così in semplici conciliatori in contese nelle quali, come il buon senso insegna, chi possiede più potere ha più possibilità di vincere. Le imprese recuperate hanno affermato pertanto la necessità di ripensare le dinamiche lavorative, mettendo in dubbio non solo, per esempio, il rapporto tra salario e inflazione nazionale o la durata dell’orario di lavoro, bensì il rapporto stesso tra capitale e lavoro.
Attraverso un importante processo di rottura e decostruzione dell’intero apparato concettuale sul quale si fondava il precedente sistema produttivo, mediante la costituzione di una differente cultura del lavoro e di un nuovo sistema di valori, i lavoratori hanno messo in atto una profonda ridefinizione delle categorie, dei meccanismi e degli spazi fisici, riappropriandosene materialmente e intellettualmente.
Questo processo di riappropriazione risulta a sua volta inserito nel più amplio contesto delle mobilitazioni del 2001, durante le quali una parte significativa della popolazione ha recuperato quell’apparato concettuale e terminologico di lotta e di protesta che la dittatura militare, con i suoi 30.000 desaparecidos, aveva cercato di seppellire insieme a una intera generazione di giovani politicizzati.
Come si era evidenziato in precedenza, i lavoratori hanno elaborato nozioni giuridiche ed economiche in modo innovativo, reinterpretando leggi di espropriazione o dando vita a nuovi concetti come nel caso del “costo dirigenziale”, idea sviluppata con il fine di mettere in discussione l’idea del costo del lavoro come principale variabile di aggiustamento9.
Uno dei principali meriti di questi movimenti è stato probabilmente esplicitare (ancora una volta) la potenziale contraddizione esistente tra due dei diritti fondamentali delle democrazie occidentali, il diritto al lavoro (a sua volta fondamento dei principali diritti sociali di cui godiamo anche in quanto contribuenti) e il diritto di proprietà, chiedendo a tutti gli attori sociali e politici di prendere una posizione nel momento in cui tale potenziale contraddizione diventa reale.
Infine, merita dedicare alcune righe a un interessante ragionamento elaborato dai lavoratori in sede giudiziaria, carico di possibili conseguenze: i lavoratori sottolineavano infatti il proprio diritto di prelazione nel processo di rimborso dei debiti (nel loro caso i salari e le liquidazioni non percepite) e pertanto il diritto a essere considerati attori privilegiati nel rilevare la gestione. Nel fare questo evidenziano, con una logica difficilmente attaccabile, come loro, a differenza di fornitori e investitori, non partecipavano ad alcun tipo di rapporto che potesse essere definito commerciale e pertanto non accettavano nemmeno implicitamente la possibilità dell’esistenza di un margine di rischio che, in ogni attività commerciale, giustifica il guadagno (plusvalore) che ottiene chi la intraprende.
A più di 10 anni dall’esplosione del fenomeno, il mondo delle fabbriche e delle imprese recuperate si presenta ancora come un eterogeneo ventaglio di potenzialità. Il principale rischio al quale si trova a far fronte qualunque esperienza di organizzazione ed economia alternativa, ovvero la sussunzione da parte del sistema capitalista nel quale si trovano immerse, rimane reale e tangibile. A proposito di questo rischio da parte delle organizzazioni cooperative merita riportare un passaggio, sebbene lungo, della famosa polemica di Rosa Luxemburg con il socialdemocratico Eduard Bernstein (1899):
Per ciò riguarda le cooperative, e soprattutto le cooperative di produzione, esse rappresentano per la loro stessa natura qualche cosa di ibrido in mezzo all’economia capitalistica: una produzione socializzata in piccolo in un contesto capitalistico di scambio. Ma nell’economia capitalistica lo scambio domina sulla produzione e, tenuto conto della concorrenza fa sì che uno sfruttamento spietato, cioè i predominio assoluto degli interessi del capitale sul processo produttivo, sia condizione di vita dell’impresa. Praticamente questo si manifesta nella necessità di render il lavoro il più possibile intensivo, abbreviarlo od allungarlo a seconda della condizione del mercato, assumere forza di lavoro oppure licenziarla e metterla sul lastrico, a seconda delle richieste del mercato di smercio, in una parola applicare tutti i ben noti metodi che mettono un’impresa capitalistica in grado di sostenere la concorrenza. Ne deriva nella cooperativa di produzione la necessità contraddittoria per i lavoratori di reggere se stessi con tutto l’assolutismo richiesto, e di rappresentare verso se stessi la funzione dell’imprenditore capitalistico. Per questa contraddizione la cooperativa di produzione va in rovina, trasformandosi in impresa capitalistica, o, se gli interessi dei lavoratori sono predominanti, sciogliendosi. (Luxemburg: 1973, pagg. 95 – 96)
Il cammino ancora da percorrere per quelle imprese recuperate che sono finalmente riuscite ad uscire dalle difficoltà delle fasi iniziali rimane ancora arduo e pieno di sfide: con la riattivazione dell’economia argentina (con tassi di crescita del Pil che toccavano l’8% prima dello scoppio della crisi economica globale nel 2008-2009) , i processi di recupero hanno sofferto una dura battuta d’arresto. Gli antichi attori istituzionali ed economici hanno riacquistato legittimità, riducendo l’influenza dei lavoratori in sede giudiziaria e politica. La concorrenza è ritornata ad essere feroce e capace di attrarre i soggetti più capaci (e soprattutto il personale specializzato), offrendo a questi compensi maggiori. Insomma, in una impresa che funziona, sia o non sia questa recuperata, il principale elemento legittimatore e motore tende sempre a essere la produzione di guadagni, a discapito di qualunque altro elemento di carattere meno veniale. Se la comune partecipazione alla lotta per il recupero aveva rappresentato nelle prime fasi l’elemento sul quale si fondava la uguaglianza tra i lavoratori, questo si trasforma in un’arma a doppio filo nel momento in cui, se l’impresa ha avuto successo e necessita di nuovi lavoratori, questi ultimi, non vantando alcun merito di lotta, risultano esposti a possibili discriminazioni (“perché dovrebbero guadagnare come me se non hanno sofferto per mesi la durezza non retribuita del recupero?”- può essere portato a chiedersi un lavoratore presente sin dall’inizio del processo).
Nonostante quanto appena detto, il pericolo maggiore rimane di carattere interno: la tendenza alla burocratizzazione intrinseca ad ogni organizzazione democratica10 è probabilmente il vettore attraverso il quale il processo di sussunzione da parte delle logiche capitaliste può fare breccia nelle imprese recuperate, sempre in continua tensione tra volontà di autonomia e necessità di integrazione, spostando definitivamente l’equilibrio in direzione di quest’ultima.
In conclusione, dopo aver studiato il processo attraverso il quale si è sviluppata la crisi argentina e le sue conseguenze, una domanda rimane aperta: sebbene la quasi totalità della letteratura accademica parli di questa fase storica come probabilmente il più eclatante fallimento economico del sistema economico neoliberale e delle sue politiche (in attesa di valutare le conseguenze della crisi apertasi in Europa dal 2008), numerosi dati evidenziano come i settori più alti dell’economia argentina e in particolare quelli relazionati a capitali transnazionali, sono risultati beneficiati dall’intero processo. Nemmeno il default (il crack del dicembre 2001) ha rappresentato una perdita per i grandi gruppi speculativi che si sono potuti avvalere di informazioni riservate per fare investimenti oculati e mettere in salvo i propri patrimoni. Sembra legittimo chiedersi dove risieda per questi il fallimento del modello. Nell’economia globalizzata un paese prosciugato dai propri patrimoni può essere visto da chi dispone di altri molteplici mercati da sfruttare come un campo agricolo che, dopo un grande raccolto che ha impoverito il suolo, venga lasciato a maggese nell’attesa che ritorni produttivo. E se invece che di fronte ad un fallimento ci trovassimo davanti al più grande successo di un modello di economia predatoria, di una gestione economica elitista che presuppone strutturalmente fasi di crisi le cui conseguenze negative vengono “esternalizzate” sui settori meno ricchi della popolazione? Nell’Europa dei tagli sociali e delle politiche di austerità risulta indispensabile domandarselo.
Bibliografía
Abelli, Josè entrevistado por Marco Calabria: Autogestione. Occupare, resistere, produrre in Argentina. Publicado en CARTA Etc., anno1, numero1, luglio 2005;
Briner M.A. e Cusmano Adriana: Las empresas recuperadas en la Ciudad de Buenos Aires: Una aproximación a partir del estudio de siete experiencias. Ciudad de Buenos Aires, 2003;
Fajn, Gabrièl: Fábricas y empresas recuperadas: protesta social, autogestión y rupturas en la subjetividad, Centro Cultural de la Cooperación, Argentina, 2003;
Fajn, Gabriel e Rebón, Juliàn: El taller ¿sin cronómetro? Apuntes acerca de las empresas recuperadas, rivista “Herramienta”, Buenos Aires, mayo 2005, consultabile su http://www.herramienta.com.ar
Fajn, Gabriel: Fábricas Recuperadas: la organización en cuestión, 2004, consultabile su http://www.iisg.nl/labouragain/documents/fajn.pdf;
Gracia, María Amalia: Fábricas de resistencia y recuperación social. Experiencias de autogestión del trabajo y la producción en argentina, Ed El Colegio de México, D.F., México, 2011;
Lavaca: Sin Patrón. fábricas y empresas recuperadas por sus trabajadores. Una historia, una guía, Ed. Lavaca, Buenos Aires, 2004;
Luxemburg, Rosa: Riforma sociale o rivoluzione? Editori Riuniti, 1973;
Magnani, Esteban: El cambio silencioso: empresa y fábricas recuperadas por los trabajadores en la Argentina, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2003;
Rebón , Juliàn: Desobedeciendo al desempleo: la experiencia de las empresa recuperadas, Ediciones Picaso/La Rosa Blindada, Buenos Aires, 2004;
Rizza, R. Sermasi, J. Il lavoro recuperato – Imprese e autogestione in Argentina, Bruno Mondadori, 2008
Ruggieri, A.; Universidad de Buenos Aires. Programa Facultad Abierta: Las empresas recuperadas en la Argentina, 2010 : informe del tercer relevamiento de empresas recuperadas por sus trabajadores. Ediciones de la Cooperativa Chilavert, Buenos Aires, 2011. Scaricabile in: http://www.workerscontrol.net/es/autores/las-empresas-recuperadas-en-la-argentina-2010
Secretaría de Desarrollo Económico, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Empresas Recuperadas. Ciudad de Buenos Aires, Buenos aires, 2003. Consultabile su www.cedem.org.ar o www.buenosaires.gov.ar.
Internet
Portal de comunicación e discusión sobre temas sociales. Realizzato dagli editori e autori del libro “Sin Patròn”: http://www.lavaca.org;
Sito web personale di Esteban Magnani, autore de “El cambio silencioso”: http://www.estebanmagnani.com.ar.
Películas y documentales
Grissinopoli [Darìo Doria, 2005];
La Toma [Avi Lewis, Naomi Klein, 2004].
Dal momento che in fase di liquidazione i macchinari (e tutto quanto presente all’interno degli stabilimenti falliti) vengono venduti dal tribunale per pagare i debiti contratti, i proprietari cercano generalmente di sottrarre tutto il materiale possibile dagli stabilimenti prima che intervenga il potere giudiziario, per poi venderlo nel mercato nero. ↩
Per uscire da questa difficile condizione, i movimenti di imprese recuperate hanno sviluppato diverse strategie tra le quali troviamo la partecipazione a progetti di sostegno a piccole e medie imprese, (come per esempio il Programa Trabajo Autogestionado del Ministerio del Trabajo argentino) o a iniziative di microcredito (si veda l’esempio della ONG La Base), entrambi finalizzati a permettere ai lavoratori l’acquisto della totalità o almeno di parte dei mezzi di produzione. ↩
Va fatto notare come questa legge, promulgata in Argentina dalla giunta militare e presente nella maggior parte delle legislazioni mondiali, ha come principale obiettivo l’espropriazione delle terre e dei beni privati con il fine di costruire strade e infrastrutture pubbliche. Si può pertanto osservare come questi lavoratori abbiano operato una interessante re-interpretazione in senso estensivo del testo di legge, trasformandolo così facendo in uno strumento di lotta. ↩
Motivo per il quale i lavoratori lo definiscono un “bilancio dal basso” (Abelli: 2005). ↩
Uno studio risalente ai primi anni del fenomeno e avente come base 17 imprese, ha evidenziato che il 38% dei lavoratori impiegati in ruoli direttivi e amministrativi proveniva da altri settori e che in totale il 72% dei lavoratori svolgevano funzioni mai praticate precedentemente (Rebón, 2005). ↩
Si calcola che durante il processo di lotta lascia l’impresa circa l’80-85% del personale dirigente e il 55-67% del personale amministrativo (Fajn: 2003). ↩
Si vedano i casi di recupero in paesi come l’Uruguay, il Brasile o il Venezuela (in ogni caso con proprie caratteristiche, e in taluni godendo perfino del pieno appoggio del potere statale). ↩
Si può notare a questo proposito un significativo parallelismo tra i movimenti di fabbriche e imprese recuperate e i movimenti squatter delle principali città occidentali: in entrambi i casi infatti l’occupazione diventa uno strumento di lotta e deterrenza nei confronti dei tentativi di speculazione economica, si tratti del fallimento fraudolento di una impresa o di operazioni di speculazione immobiliaria (aumento dei prezzi degli affitti o delle case provocati dal non affitto dei locali inabitati). In entrambi i casi, la lotta rivendica un rapporto con il bene (alloggio – spazio – impianto produttivo) che dia priorità a logiche sociali e d’uso rispetto a quelle puramente economiche. ↩
Secondo questa idea, l’eliminazione del costo dirigenziale, ovvero del plusvalore che rimane nelle mani della dirigenza e dei quadri di alto livello, rappresenta un importante elemento per la competitività delle imprese recuperate. ↩
Per un’ampia e completa dissertazione del tema si vedano gli scritti relativi alla chiamata Legge ferrea dell’oligarchia, elaborati da Robert Michels e l’importante dibattito che ne è alla base e che da questi è scaturito. ↩