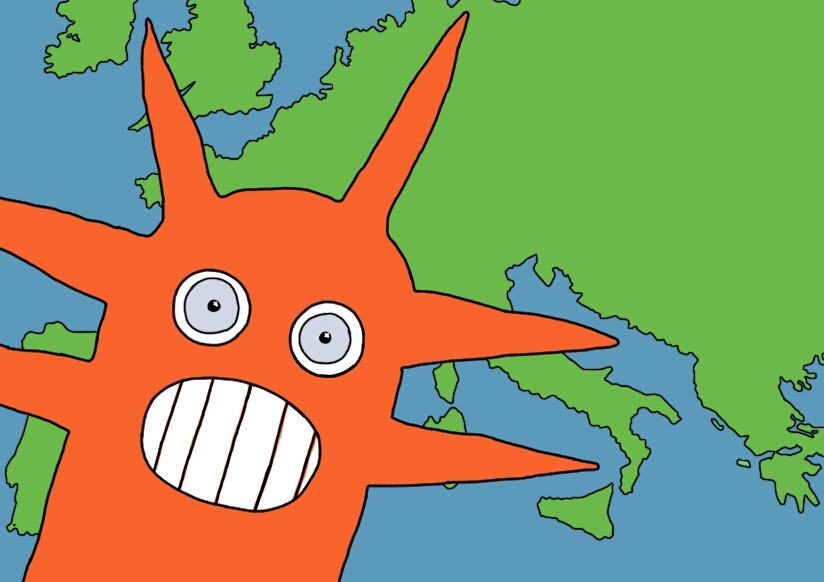di MARCO BASCETTA.
Guardare alle vicende dell’Europa contemporanea e della crisi che la affligge con occhi tedeschi. Perchè no? È senz’altro un utile esercizio quello cui ci invita Angelo Bolaffi nel suo Cuore tedesco (Donzelli editore, pp 265, euro 18). Esercizio tanto più necessario, quello di comprendere le ragioni di Berlino e i rapporti tra la Germania e il resto d’Europa, quanto più in diversi paesi dell’Unione vanno diffondendosi sentimenti antigermanici, non di rado combinati con posizioni astiosamente antieuropee, grondanti risentimenti e pregiudizi che ricalcano stereotipi spesso ancora più antichi dell’eredità catastrofica della seconda guerra mondiale. Sentimenti che vanno inoltre ad alimentare formazioni populiste e neonazionaliste in preoccupante espansione. A onor del vero, tuttavia, soprattutto nell’imminenza delle elezioni tedesche che si svolgeranno tra poche settimane, esponenti politici e diversi media germanici non mancano di ricambiare, quanto a stereotipi e giudizi tagliati con l’accetta non sempre scevri dai toni del populismo, i malumori dell’Europa mediterranea. Due indebite semplificazioni finiscono così col fronteggiarsi sulla scena pubblica europea, conquistandosi numerosi accoliti. Da una parte la posizione che imputa agli interessi particolari della politica economica tedesca e all’arroganza del governo di Berlino l’aggravarsi della crisi nell’area mediterranea e la pesantezza delle sue conseguenze sociali, dall’altra l’accusa rivolta agli «spendaccioni meridionali», quelli che «vivono al di sopra dei propri mezzi», di essere la principale causa della crisi dell’eurozona e della sua moneta comune, nonché di mettere le mani nelle tasche dei risparmiatori tedeschi.
Da questo secondo punto di vista Bolaffi evita, tuttavia, di prendere un’opportuna distanza. In definitiva la forza stessa dell’economia tedesca starebbe a dimostrare che alla fine dei conti Berlino ha avuto ragione, che la Germania ha capito e agito la «sfida della globalizzazione» prima e meglio degli altri. Ma per continuare a sostenerla ha bisogno dell’Europa (in mancanza della quale tutti gli stati che la compongono, Germania compresa, sarebbero condannati all’irrilevanza), ma di una Europa che della competizione globale abbia interamente assunto lo spirito e compiuto tutte le rinunce e i sacrifici necessari ad approntare gli strumenti in grado di fronteggiarla sull’esempio tedesco. L’ottica assunta è essenzialmente quella geopolitica, la quale, come ogni grand’angolo eccessivo, distorce e offusca gli elementi che rappresenta. E, nello stesso tempo, non riesce mai ad abbracciare l’intera scena.
Da questo secondo punto di vista Bolaffi evita, tuttavia, di prendere un’opportuna distanza. In definitiva la forza stessa dell’economia tedesca starebbe a dimostrare che alla fine dei conti Berlino ha avuto ragione, che la Germania ha capito e agito la «sfida della globalizzazione» prima e meglio degli altri. Ma per continuare a sostenerla ha bisogno dell’Europa (in mancanza della quale tutti gli stati che la compongono, Germania compresa, sarebbero condannati all’irrilevanza), ma di una Europa che della competizione globale abbia interamente assunto lo spirito e compiuto tutte le rinunce e i sacrifici necessari ad approntare gli strumenti in grado di fronteggiarla sull’esempio tedesco. L’ottica assunta è essenzialmente quella geopolitica, la quale, come ogni grand’angolo eccessivo, distorce e offusca gli elementi che rappresenta. E, nello stesso tempo, non riesce mai ad abbracciare l’intera scena.
Il punto di svolta nel rapporto tra l’Europa e la Germania, nonché dell’idea e della funzione stessa dell’Unione europea, è, c’è poco da discuterne, il 1989 e la riunificazione tedesca che avrebbe seguito con sorprendente rapidità la caduta del muro. Nondimeno, senza indulgere alle ricorrenti baruffe sulle scansioni e i passaggi della storia, si può affermare che già prima della caduta del muro di Berlino la guerra fredda avesse decretato un vincitore e un vinto e a quel punto il resto era più o meno scritto. Almeno a partire dal disastro sovietico in Afghanistan che, non a caso, ha funzionato da incubatrice del conflitto che di lì a breve avrebbe sostituito quello tra i due blocchi, per essere battezzato con il nome tanto roboante quanto improprio di «scontro di civiltà». Un conflitto tutt’altro che irrilevante per il vecchio continente e non solo per la sua sponda mediterranea. La «provincializzazione» dell’Europa non è iniziata ieri.
Con la fine della guerra fredda, dunque, e con la sottrazione dei paesi dell’est alla lunga dominazione sovietica, l’unione europea, con il suo ombrello atlantico, cessava di essere l’unico e obbligato garante della pace e della libertà che le nuove condizioni non mettevano più a repentaglio, mentre la moneta unica, fabbricata in gran fretta e a scapito dei suoi presupposti sociali e politici, vincolava nuovamente la Germania riunificata ai partner europei calmandone timori e diffidenze. A questo punto il nuovo scopo dell’Unione diventava quello di raggiungere un grado di potenza tale da consentirle di competere con successo sullo scacchiere globale. E a tal fine, sostiene Bolaffi, la Germania, ripresasi dalla sua iniziale debolezza e dallo sforzo della riunificazione, ridimensionando il welfare e rimondulando a favore dei profitti i rapporti tra capitale e lavoro, imponendo ad ogni costo la stabilità monetaria e la sacralità della rendita finanziaria, avrebbe raggiunto un livello di eccellenza competitiva che ne avrebbe fatto il «modello» meritevole di essere imitato da tutti i paesi europei. Un modello diverso dal neoliberismo anglosassone, che vuole la concorrenza affidata alle sole forze spontanee del mercato, ma in linea di discendenza con quell’«ordoliberalismo» tedesco che, invece, intendeva fornire artificialmente alla competitività le condizioni ottimali. Per ottenere le quali non si doveva esitare a comprimere i diritti e le garanzie del lavoro, ad accrescere il potere di ricatto sulle scelte dei singoli e il controllo sulla produttività delle loro vite, non molto diversamente dai liberisti d’oltremanica, intenti a trasformare il loro welfare in un workfare.
Berlino non è l’Atene di Pericle, seppure abbia saputo attrarre cospicui flussi di produzione immateriale al prezzo di una «gentrificazione» che ha fatto le sue vittime. Le troppe briglie imposte al conflitto sociale, nel nome di una cogestione decisamente asimmetrica, finiscono col colpire duramente il benessere di molti. Tanto più che, almeno per il momento, le opportunità della competizione non sembrano in grado di mantenere la promessa di compensare la sempre più accentuata rinuncia alle politiche redistributive di stampo socialdemocratico e la restrizione dello stato sociale. La concentrazione della ricchezza è un fenomeno globale che non risparmia la Germania.
Con la fine della guerra fredda, dunque, e con la sottrazione dei paesi dell’est alla lunga dominazione sovietica, l’unione europea, con il suo ombrello atlantico, cessava di essere l’unico e obbligato garante della pace e della libertà che le nuove condizioni non mettevano più a repentaglio, mentre la moneta unica, fabbricata in gran fretta e a scapito dei suoi presupposti sociali e politici, vincolava nuovamente la Germania riunificata ai partner europei calmandone timori e diffidenze. A questo punto il nuovo scopo dell’Unione diventava quello di raggiungere un grado di potenza tale da consentirle di competere con successo sullo scacchiere globale. E a tal fine, sostiene Bolaffi, la Germania, ripresasi dalla sua iniziale debolezza e dallo sforzo della riunificazione, ridimensionando il welfare e rimondulando a favore dei profitti i rapporti tra capitale e lavoro, imponendo ad ogni costo la stabilità monetaria e la sacralità della rendita finanziaria, avrebbe raggiunto un livello di eccellenza competitiva che ne avrebbe fatto il «modello» meritevole di essere imitato da tutti i paesi europei. Un modello diverso dal neoliberismo anglosassone, che vuole la concorrenza affidata alle sole forze spontanee del mercato, ma in linea di discendenza con quell’«ordoliberalismo» tedesco che, invece, intendeva fornire artificialmente alla competitività le condizioni ottimali. Per ottenere le quali non si doveva esitare a comprimere i diritti e le garanzie del lavoro, ad accrescere il potere di ricatto sulle scelte dei singoli e il controllo sulla produttività delle loro vite, non molto diversamente dai liberisti d’oltremanica, intenti a trasformare il loro welfare in un workfare.
Berlino non è l’Atene di Pericle, seppure abbia saputo attrarre cospicui flussi di produzione immateriale al prezzo di una «gentrificazione» che ha fatto le sue vittime. Le troppe briglie imposte al conflitto sociale, nel nome di una cogestione decisamente asimmetrica, finiscono col colpire duramente il benessere di molti. Tanto più che, almeno per il momento, le opportunità della competizione non sembrano in grado di mantenere la promessa di compensare la sempre più accentuata rinuncia alle politiche redistributive di stampo socialdemocratico e la restrizione dello stato sociale. La concentrazione della ricchezza è un fenomeno globale che non risparmia la Germania.
 Che l’uscita dalla crisi possa essere conseguita attraverso l’adeguamento generale a un «modello» precostituito è assai discutibile. Tanto più che nemmeno la grande famiglia delle politiche neoliberiste in tutte le sue modulazioni possibili è stata in grado non solo di prevenire, ma neanche di arginare l’evoluzione della crisi e i suoi effetti più devastanti. Francoforte non è lontana da Londra e da New York e le ragioni della rendita finanziaria parlano lo stesso linguaggio e dettano legge con la medesima forza indisponibile a qualsivoglia compromesso. Tra le sponde del Reno e quelle del Tamigi si impone una logica non molto diversa. Il processo di accumulazione bloccato sui terreni più consueti ne sperimenta sempre di nuovi, colonizzandoli alle proprie condizioni. Che senso ha, allora, prendersela con Martin Lutero o con il ben noto terrore dei tedeschi per lo spettro dell’inflazione? Ma anche con la cedevolezza meridionale di fronte alla domanda sociale dei troppi esclusi o emarginati? Laddove all’inasprirsi delle politiche di austerità fa da beffardo contrappunto la crescita del debito pubblico, la moltiplicazione della rendita e una recessione di cui non si vede la fine, malgrado la ricorrente, e ricorrentemente smentita, annunciazione della ripresa. Del resto, i ripetuti errori compiuti nel tempo dai sacerdoti della cosiddetta Troika, in non poca parte per ragioni squisitamente ideologiche, sono ormai visibili a tutti
Che l’uscita dalla crisi possa essere conseguita attraverso l’adeguamento generale a un «modello» precostituito è assai discutibile. Tanto più che nemmeno la grande famiglia delle politiche neoliberiste in tutte le sue modulazioni possibili è stata in grado non solo di prevenire, ma neanche di arginare l’evoluzione della crisi e i suoi effetti più devastanti. Francoforte non è lontana da Londra e da New York e le ragioni della rendita finanziaria parlano lo stesso linguaggio e dettano legge con la medesima forza indisponibile a qualsivoglia compromesso. Tra le sponde del Reno e quelle del Tamigi si impone una logica non molto diversa. Il processo di accumulazione bloccato sui terreni più consueti ne sperimenta sempre di nuovi, colonizzandoli alle proprie condizioni. Che senso ha, allora, prendersela con Martin Lutero o con il ben noto terrore dei tedeschi per lo spettro dell’inflazione? Ma anche con la cedevolezza meridionale di fronte alla domanda sociale dei troppi esclusi o emarginati? Laddove all’inasprirsi delle politiche di austerità fa da beffardo contrappunto la crescita del debito pubblico, la moltiplicazione della rendita e una recessione di cui non si vede la fine, malgrado la ricorrente, e ricorrentemente smentita, annunciazione della ripresa. Del resto, i ripetuti errori compiuti nel tempo dai sacerdoti della cosiddetta Troika, in non poca parte per ragioni squisitamente ideologiche, sono ormai visibili a tuttiLa Germania resta, nondimeno, il cuore della questione europea, il paese più popoloso e sviluppato del vecchio continente, indissolubilmente intrecciato con la sua drammatica storia e con ogni ragionevole proiezione nel futuro. Pensare l’Europa prescindendo da questo non ha molto senso. Ma dobbiamo necessariamente identificare la Germania con il Modell Deutschland, e cioè con la concezione dello sviluppo economico e della stabilità finanziaria che oggi vi prevale? E anche laddove quel modello non presentasse in sé alcun inconveniente, fino a che punto sarebbe esportabile in paesi con una storia economica, un tessuto produttivo e una pratica delle relazioni sociali decisamente differenti? Peggio ancora sarebbe poi prendere a modello per il rafforzamento dell’unione europea a guida germanica lo schema severamente pedagogico adottato da Bonn per integrare i territori della ex Repubblica democratica tedesca.
Il problema è che il punto di vista geopolitico ragiona per generalizzazioni e per modelli, non molto diversamente dalla «grande politica» dei vecchi stati nazionali. Le potenze politico-economiche emergenti, Cina, Russia, Brasile, India, sono prese in considerazione solo quanto al poderoso tasso di crescita che le contraddistingue e dunque come blocchi omogenei che rivestono un certo peso sullo scacchiere globale e dispongono della corrispondente capacità competitiva. Mai, invece, quanto alle furiose contraddizioni che le attraversano e le incertezze che gravano sul loro futuro. Basti citare il numero e l’intensità dei conflitti sociali in Cina, di cui raramente ci perviene notizia, o le recenti insorgenze brasiliane contro le «grandi opere» sportive finanziate a scapito della spesa sociale. Ne consegue, nel pensiero dominante, che per fare fronte a questa concorrenza l’Europa e i singoli paesi che la compongono dovrebbero realizzare al proprio interno l’omogeneità immaginaria imputata agli altri grandi attori dello scacchiere globale. Inutile dire che questa aspirazione si realizza attraverso l’incremento di un meccanismo messo al bando dal novero del nominabile: quello dello sfruttamento. Nonché attraverso la repressione di ogni forma non immediatamente integrabile di conflittualità sociale.
Così, per quanto riguarda il Modell Deutschland, e ancora di più la sua imitazione nel resto d’Europa, converrebbe esaminarne le contraddizioni, i costi sociali, tracciare la mappa dei perdenti e dei vincenti, degli esclusi e degli integrati, piuttosto che rimanere estasiati di fronte all’exemplum virtutis berlinese o strepitare contro la presunta aggressività genetica del «popolo germanico».
Può darsi invece che il «tramonto dell’occidente» europeo appartenga a quei grandi corsi e ricorsi storici di natura fatidica, dal vagabondare dello «spirito del mondo», dal conto che un pianeta spietatamente sfruttato avrebbe prima o poi presentato al vecchio continente. Ma, in questo caso, non ci sarebbe molto da fare, converrebbe godersi il crepuscolo senza agitarsi, accomodandosi in una pittoresca periferia da pensionati della storia o da guardiani di uno straordinario museo.