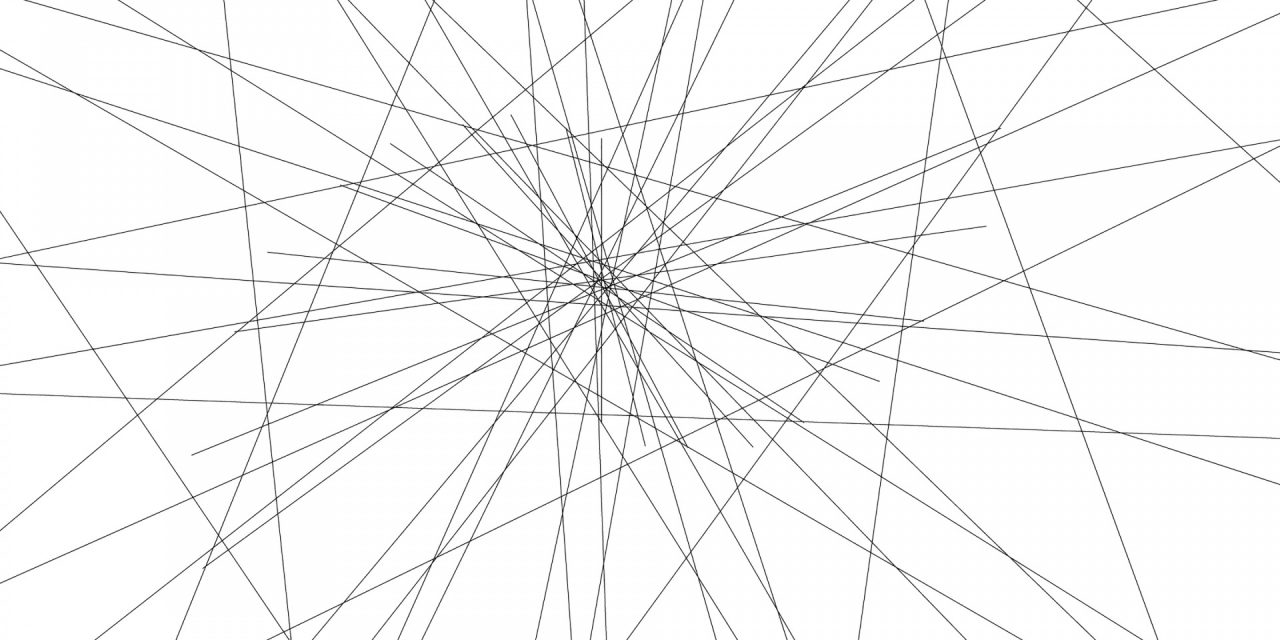Di SANDRO MEZZADRA
1. Identità e classe
Se l’identità è una categoria fondamentale nella filosofia europea almeno da Aristotele in poi, la sua politicizzazione è un fenomeno molto più recente. Si potrebbe dire che è solo nella seconda metà del XX secolo che lo sviluppo dell’antropologia culturale e della sociologia pone il terreno teorico per tale politicizzazione, che non può essere pensata senza tenere conto dell’emergere in molte parti del mondo dei movimenti femministi così come di una panoplia di lotte contro la dominazione razziale e per i diritti delle “minoranze”. Dibattiti così importanti, come quello sul multiculturalismo, hanno contribuito a promuovere la politica dell’identità e, più in generale, ad alimentare una codifica della politica in termini di identità (culturale). Le rivendicazioni basate sull’identità hanno giocato un ruolo importante nel denunciare la presunta “neutralità” e persino l’universalismo delle istituzioni politiche e nel far luce sulla continuità dei passati di conquista e dominazione. Questo è stato per esempio il caso di paesi coloniali come l’Australia, il Canada e gli Stati Uniti per quanto riguarda la condizione dei popoli indigeni. Più in generale, l’identità ha fornito un linguaggio per l’articolazione delle rivendicazioni e dei desideri di liberazione di una molteplicità di soggetti la cui oppressione era basata su specifici sistemi di oppressione che non erano considerati tali dalle tradizioni consolidate di politica emancipatoria. Le lotte delle persone razzializzate o delle minoranze sessuali sono buoni esempi in questo senso, così come le rivendicazioni che proliferano all’interno del femminismo lungo le linee che fratturano le figure unitarie della “donna” e della “sorellanza universale” (basta pensare ai dibattiti che circondano il “femminismo postcoloniale” dagli anni ’80).
Da questo punto di vista, non sorprende che uno dei primi bersagli polemici della politica dell’identità siano stati i concetti di classe e di politica di classe. Se si prende la classe come un soggetto collettivo (e anche come un’identità collettiva) la cui unità e omogeneità sono immediatamente date come un risultato “oggettivo” dei rapporti di produzione, è facile vedere che non c’è spazio per una politica capace di cogliere rivendicazioni e movimenti articolati in termini specifici – siano questi sulle linee del genere o della razza. Non mancano esempi storici di tali conflitti e scontri all’interno del movimento operaio. Prendiamo ad esempio B.R. Ambedkar, il grande portavoce dei Dalit nell’India coloniale. Alla fine degli anni ’20 discusse più volte con i dirigenti del Partito Comunista dell’India, sempre mettendo in evidenza la peculiarità della posizione dei Dalit e la diffusione delle pratiche di intoccabilità nel mondo del lavoro e sottolineando la necessità di dare priorità a queste questioni nella politica del lavoro. Questo è proprio ciò che i leader comunisti non volevano accettare, cosa che portò alla rottura con Ambedkar (Roy, 2016: 110). Quest’ultimo, nel suo The Annihilation of Caste (1936), fece il punto su quei dibattiti scrivendo che la casta è “una divisione dei lavoratori“, e che, più precisamente, “è una gerarchia in cui le divisioni dei lavoratori sono classificate una sull’altra” (Ambedkar, 2016: 233-234). La questione della casta viene qui affrontata direttamente dal punto di vista di quella che potremmo chiamare la composizione del lavoro, della rottura della sua unità come fattore sociologico e come soggetto politico. E Ambedkar sottolinea la rilevanza dei conflitti all’interno dei ranghi dei lavoratori – conflitti che hanno giocato un ruolo importante altrove nel mondo, per esempio nel rapporto tra le lotte afroamericane e il movimento operaio negli Stati Uniti[1].
In questo saggio analizzo una nozione specifica che è diventata particolarmente rilevante per inquadrare la discussione sull’identità e la politica dell’identità: l’intersezionalità. Mostrerò che la formulazione originale di questa nozione si è intrecciata in modo cruciale con i dibattiti sulla classe e la politica di classe. Allo stesso tempo, la mia argomentazione è mossa da una preoccupazione teorica e politica per le principali forme di politica dell’identità contemporanea, che sono alimentate da nozioni come “privilegio bianco” e da un linguaggio e teorie “decoloniali” (Mezzadra, 2021: 30-33). Mentre rimango diffidente nei confronti dei toni moralistici delle politiche identitarie di oggi, ciò che mi preoccupa di più è la tendenza ad affermare semplicemente un’identità subalterna come chiusa e delimitata (spesso nel quadro di una competizione per stabilire la propria identità come la più oppressa e umiliata). Questo rende le alleanze, le convergenze e le coalizioni – così come l’opposizione – in definitiva impossibili (Haider, 2018: 40). È contro questo contesto che nell’ultima sezione del saggio mi chiedo se sia possibile, e persino necessario, ripensare il concetto stesso di classe per aprire una prospettiva politica diversa a lotte e movimenti come quelli che sono al centro delle teorie dell’intersezionalità. Inutile dire che questo richiede un andare oltre al concetto tradizionale di classe che ho abbozzato sopra, lo ammetto, facendone una sorta di caricatura.
2. Intersezionalità, e allora?
C’è qualcosa di importante da sottolineare all’inizio di questa sezione. Negli ultimi anni, la nozione di intersezionalità, originariamente forgiata negli Stati Uniti, ha cominciato a viaggiare. E come spesso accade con le “teorie itineranti” (Said, 1983, 1994), ha acquisito nuovi significati ed è stata in un certo senso anche reinventata prima di tutto nelle strade, fuori dal mondo accademico. Questo è accaduto in particolare nel quadro della nuova ondata di movimenti femministi in America Latina e nell’Europa del Sud, che spesso hanno utilizzato lo slogan Ni Una Menos (“Non una di meno”). In Argentina e in Brasile, il concetto di intersezionalità è usato per articolare e connettere i movimenti e le rivendicazioni delle donne indigene e nere, delle comunità rurali e metropolitane, delle minoranze sessuali e delle donne che vivono nelle favelas e villas, senza perdere di vista la loro specificità, mentre in Italia e in Spagna permette di affrontare le questioni della migrazione, del colonialismo e della sessualità. In un certo senso, si può dire che questa appropriazione e questi usi dell’intersezionalità hanno provocato una ri-politicizzazione del concetto, dove ciò che è in gioco, per citare le parole di Angela Davis, è “non tanto l’intersezionalità delle identità ma l’intersezionalità delle lotte” (Davis, 2016: 144). È interessante notare come questa nozione di intersezionalità abbia giocato un ruolo di primo piano anche nei dibattiti all’interno del massiccio movimento per le vite nere e contro la brutalità della polizia negli Stati Uniti nell’estate del 2020[2]. È interessante notare come l’intersezionalità abbia giocato un ruolo di primo piano anche nei dibattiti all’interno del movimento Black Lives Matter e contro la brutalità della polizia negli Stati Uniti nell’estate del 2020.
Ho parlato di una ri-politicizzazione dell’intersezionalità perché negli ultimi anni negli Stati Uniti la nozione era diventata una sorta di riferimento accademico standard e la sua originale impronta politica era stata in qualche misura neutralizzata (il che non significa naturalmente che non ci siano molti studiosi che continuano a fare un lavoro molto interessante e persino radicale nel quadro dell’intersezionalità[3]). È per questo che è necessario risalire all’origine della nozione, e anche al di là di questa, per ricostruire brevemente la sua genealogia. Come anticipavo prima, il riferimento al mondo del lavoro è fondamentale per l’intersezionalità. Kimberlé Crenshaw, alla quale solitamente viene attribuito il merito di aver “inventato” il concetto, lo definisce come segue. L’intersezionalità, scrive, designa “i vari modi in cui razza e genere interagiscono per modellare le molteplici dimensioni delle esperienze lavorative delle donne nere” (Crenshaw, 1991: 1244). Discutendo il caso De Graffenreid contro General Motors del 1977, in cui la corte respinse l’accusa di cinque donne nere di discriminazione nel sistema di anzianità dell’azienda, Crenshaw scrive, come è noto, che il rifiuto della corte di riconoscere “la discriminazione combinata di razza e sesso” si basava sul presupposto “che i confini della discriminazione di sesso e razza sono definiti rispettivamente dalle esperienze delle donne bianche e degli uomini neri” (Crenshaw, 1989: 143). L’interazione di questi confini di fatto oscura e cancella una specifica esperienza soggettiva tra le fila dei lavoratori, quella delle donne nere. Concentrandosi su una differenza così trascurata, l’intersezionalità si propone di far luce sul funzionamento parallelo dei sistemi di oppressione e dominazione che gerarchizzano la classe operaia.
Scrivendo nel 1989, Kimberlé Crenshaw era consapevole del fatto che la nozione di intersezionalità da lei creata a partire da una specifica prospettiva di pensiero giuridico critico era stata a lungo in gestazione nel pensiero femminista nero così come nella fatica e nelle lotte delle donne lavoratrici nere negli Stati Uniti[4] . Nei tumulti degli anni ’70 possiamo trovare per esempio nella “Dichiarazione” del Combahee River Collective (1977) una formulazione sorprendente della problematica dell’intersezionalità. Il collettivo, il cui nome richiamava il raid di Harriet Tubman sul fiume Combahee nella Carolina del Sud durante la Guerra Civile, che liberò 750 persone in schiavitù, il collettivo era un’organizzazione nera radicale femminista e lesbica formata nel 1974 (Taylor, 2017). Come scrivono, la loro politica è definita da un impegno attivo “nella lotta contro l’oppressione razziale, sessuale, eterosessuale e di classe” e vedono come loro “compito particolare lo sviluppo di analisi e pratiche integrate basate sul fatto che i principali sistemi di oppressione sono interconnessi” (ibidem: 15). Questa nozione di sistemi di oppressione “interconnessi” prefigura chiaramente l’intersezionalità. Allo stesso tempo, richiama l’attenzione proprio sul momento dell'”incastro”, cioè sulle giunzioni e sulla loro articolazione. “Troviamo anche difficile”, scrive il collettivo, “separare l’oppressione razziale da quella di classe da quella sessuale, perché nelle nostre vite sono molto spesso vissute simultaneamente” (ibidem: 19). Il concetto di “politica dell’identità” che il lettore può trovare in uno dei suoi primi usi nella “Dichiarazione” del Combahee River Collective ha di conseguenza significati molto diversi da quelli che sono diventati abituali in seguito. Questo concetto è qui un grido di battaglia, che esorta le donne nere a concentrarsi sulla loro “propria oppressione” e a lottare per la propria liberazione, che sarebbe necessariamente una liberazione generale in quanto “la nostra libertà richiederebbe la distruzione di tutti i sistemi di oppressione” (ibidem: 23).
Anche molto prima degli anni ’70, l’esperienza dell`“incastro” dell’oppressione razziale, sessuale e di classe aveva messo in forma l’esperienza di vita di una moltitudine di donne nere negli Stati Uniti. Ed è stata contestata in molti modi attraverso le lotte e l’organizzazione, prima contro la schiavitù e poi contro il linciaggio e la segregazione. Mentre gli scritti della prima fase del pensiero femminista nero (che includono nomi importanti come Sojourner Truth e Ida B. Wells-Barnett) compongono un archivio importante per chiunque sia interessato alla genealogia e alla preistoria dell’intersezionalità (Gines, 2014), vorrei qui soffermarmi brevemente sui dibattiti sulla condizione della donna proletaria nera nel Partito comunista degli Stati Uniti negli anni ’30 e negli anni ’40. Negli scritti di Louise Thompson e Claudia Jones le questioni di razza e sesso sono infatti discusse dal punto di vista del concetto di sfruttamento, in seguito marginalizzato nel dibattito intersezionale. Scrivendo nel 1936, Louise Thompson fornisce in Toward a Brighter Dawn un’incredibile analisi della condizione delle donne nere, concentrandosi su una “strada del Sud”, sulle “piantagioni del Sud”, e sul “Bronx Park, New York”. L’eredità della schiavitù attraversa tutto l’articolo, che trova un apice drammatico nella descrizione della situazione dei lavoratori domestici neri nel Bronx. Thompson parla di un “mercato degli schiavi” nel Bronx, e lo descrive come un “monumento grafico all’amaro sfruttamento di questa sezione più sfruttata della popolazione lavorativa americana – le donne negre”[5]. E questo perché esse “incontrano questo triplice sfruttamento – come lavoratrici, come donne e come negre”[6] (Thompson, 1936).
Più di un decennio dopo, Claudia Jones, nata a Trinidad e condannata a vivere e lavorare nel Regno Unito dopo essere stata deportata dagli Stati Uniti nel 1955, sviluppa ulteriormente tale analisi. Il suo An End to the Neglect of the Problems of the Negro Woman! (1949) inizia sottolineando la crescita della partecipazione militante delle donne nere “in tutti gli aspetti della lotta per la pace, i diritti civili e la sicurezza economica” (ibidem). È di fronte a questa militanza intensificata che Jones esorta a una nuova comprensione del ruolo delle donne nere e alla fine del disinteresse per quel ruolo che permea il movimento operaio. Jones si sofferma sulla posizione delle donne nere in diverse sfere sociali, dalla famiglia alle organizzazioni di massa. Analizza attentamente in particolare la condizione delle lavoratrici domestiche nere, concentrandosi sulle ragioni che portano alla relegazione delle donne nere a “lavori domestici e lavori umili simili”, sottolineando la loro “miseria insopportabile” (ibidem). Fa eco a Thompson scrivendo che i lavoratori domestici neri “soffrono l’ulteriore indignazione, in alcune aree, di dover cercare lavoro in virtuali “mercati di schiavi” per strada dove vengono si tengono delle aste, come fossero degli schiavi, per i lavoratori più resistenti” (ibidem). È interessante notare che lei analizza anche le ragioni che dividono le donne bianche e nere anche all’interno della classe operaia. Lo “sciovinismo bianco” funziona come un confine a livello sociale, un confine che attraversa e divide anche la composizione della classe operaia. Anche l’esperienza dello sfruttamento è gerarchizzata, come dimostrano chiaramente le donne nere. Come scrive Jones, “non uguaglianza, ma degradazione e super-sfruttamento: questa è la vera sorte delle donne negre!”[7] (ibidem).
3. Figure dell’oppressione
“Triplo sfruttamento” e “super-sfruttamento”, i concetti introdotti da Linda Thompson e Claudia Jones, sono chiaramente tentativi di usare un linguaggio marxista per venire a patti con la condizione specifica delle donne lavoratrici nere. La diversificazione proposta e persino la gerarchizzazione dello sfruttamento sollevano tuttavia diversi problemi. Questo è particolarmente il caso quando la nozione di sfruttamento è intesa in termini puramente economicistici e strettamente connessa ad una stretta interpretazione del “lavoro produttivo”. Una tale concezione economistica dello sfruttamento è stata a lungo prevalente nel marxismo, anche negli Stati Uniti, e ha permesso una subordinazione di tutte le forme di oppressione (per esempio, nelle parole di Thompson, l’oppressione “come donne, e come negri”[8]) allo sfruttamento stesso (“come lavoratori”) e alla relativa politica di classe. Di conseguenza, molti attivisti e studiosi hanno cominciato a sottolineare l’autonomia di quei sistemi di oppressione (ad esempio, sessismo e razzismo) e a dare priorità alle lotte contro di essi, in molti casi oscurando completamente la rilevanza dello sfruttamento. Questo è ciò che caratterizza il mainstream dei dibattiti sull’intersezionalità, che sono spesso modellati da un’opposizione concettuale tra oppressione e sfruttamento (Bohrer, 2019).
L’importante libro di Patricia Hill Collins, Black Feminist Thought (pubblicato originariamente nel 1990), si unisce a una lunga tradizione di riflessione teorica sulla perdurante eredità della schiavitù nel definire la condizione delle donne afroamericane utilizzando la nozione di oppressione come principale riferimento concettuale della sua analisi. Vale la pena citare interamente il libro della Collins su questo punto. “L’oppressione”, si legge: “descrive qualsiasi situazione ingiusta in cui, sistematicamente e per un lungo periodo di tempo, un gruppo nega ad un altro gruppo l’accesso alle risorse della società. La razza, la classe, il genere, la sessualità, la nazione, l’età e l’etnia, tra le altre, costituiscono le principali forme di oppressione negli Stati Uniti. Tuttavia, la convergenza dell’oppressione di razza, classe e genere caratteristica della schiavitù statunitense ha plasmato tutte le successive relazioni che le donne di discendenza africana hanno avuto all’interno delle famiglie e delle comunità nere americane, con i datori di lavoro e tra di loro. Ha anche creato il contesto politico per il lavoro intellettuale delle donne nere” (Collins, 2000: 4).
La teoria di Collins delle “oppressioni intersecanti” è stata molto influente nello stabilire il campo dell’intersezionalità (o “matrice di dominazione” come ha preferito definirla nel 1990). È facile vedere che la maggior parte delle “forme di oppressione” menzionate da Collins (razza, genere, sessualità, etnia…) sono aperte a processi di moltiplicazione dall’interno, e una proliferazione di figure di oppressione caratterizza infatti i dibattiti sull’intersezionalità. Il femminismo Chicana, per esempio, ha introdotto nuove prospettive in una discussione nata dalla condizione e dalle lotte delle donne nere[9], mentre i temi dell’oppressione sessuale e dell’eteronormatività hanno guadagnato importanza negli scritti sull’intersezionalità. Questo ha portato a una sorta di esplosione del campo, che ha permesso molteplici processi di espressione e costituzione soggettiva, facendo luce su forme di dominazione rimaste a lungo invisibili, e ampliando produttivamente il terreno delle lotte di liberazione. Allo stesso tempo, ha sollevato problemi specifici per una teoria dell’intersezionalità.
È sicuramente vero che, come scrive Ashley Bohrer, i teorici intersezionali “hanno argomentato contro i modelli additivi e moltiplicativi per la loro incapacità di evidenziare la costituzione reciproca delle strutture di dominazione” (2019: 102). Tuttavia, è importante ricordare che la nozione di oppressione nei dibattiti intersezionali è caratterizzata da un’enfasi sull’“irriducibilità” (dei singoli sistemi di oppressione), che va di pari passo con un’enfasi sulla “simultaneità”, e cioè con l’affermazione che quei sistemi “sono vissuti simultaneamente e sono inseparabili” (Carasthatis, 2016: 57). Qui c’è una tensione evidente, e mentre la critica al pensiero “monoasse” è un momento costitutivo per le teorie dell’intersezionalità, si può dire che il principio di “irriducibilità” ha spesso teso a oscurare quello di “simultaneità”. La posta in gioco è il rischio di una politica identitaria che assume la specificità di un sistema di oppressione come quadro esclusivo non solo per l’analisi ma anche per il processo di costituzione del soggetto. Il punto non è proporre come alternativa una gerarchizzazione delle oppressioni e di conseguenza delle lotte e delle rivendicazioni, un anatema per le teorie dell’intersezionalità. Si tratta piuttosto di spostare l’attenzione sul momento unitario nel funzionamento dei sistemi di dominazione e oppressione e di lavorare per la creazione di spazi di convergenza per soggetti diversi ed eterogenei. Il focus su uno specifico sistema di oppressione può essere un momento importante in un processo di soggettivazione, e può essere persino necessario per rompere i processi di emarginazione e per aprire nuove prospettive di liberazione. Tuttavia, quando l’“identità” forgiata da tale focus viene congelata, rischia paradossalmente di replicare i confini dello specifico sistema di oppressione che si propone di contestare. E diventa un ostacolo a più ampi processi di soggettivazione.
All’interno dei dibattiti intersezionali questo problema viene spesso affrontato dal punto di vista di una teoria della coalizione. “È passato un po’ di tempo”, scrive Audre Lorde, “prima che arrivassimo a capire che il nostro posto era la casa stessa della differenza piuttosto che qualsiasi differenza particolare” (1982: 226). Queste parole racchiudono bene l’osservazione che ho appena fatto sull’identità e sulla politica dell’identità. La “casa della differenza” può essere un’immagine potente per descrivere una coalizione intersezionale, intrecciando solidarietà e resistenza verso una politica capace di portare “in essere i mondi di cui abbiamo davvero bisogno” (Bohrer, 2019: 257). Una tale coalizione, come giustamente sottolinea Bohrer (ibídem: 256), è necessariamente diversa dall’essere ciò che è tradizionalmente inteso come il minimo denominatore tra gruppi diversi. Mentre in questo caso la soggettività e l’identità dei collettivi coinvolti rimangono intatte, una coalizione intersezionale è uno spazio di convergenza per una moltitudine di persone diverse ed eterogenee, all’interno del quale vengono continuamente fabbricate nuove soggettività e persino identità in una comune lotta di liberazione. Inutile dire che l’unità stessa di una coalizione non è data in anticipo, è essa stessa in gioco in questo processo di soggettivazione.
4. La classe, reloaded
La critica alla nozione economicista di sfruttamento che ho abbozzato sopra ha portato a una marginalizzazione della classe, e persino del capitalismo, in molti dibattiti sull’intersezionalità. Come è successo negli studi culturali e postcoloniali (Mezzadra, 2011), il capitale e il capitalismo sono stati confinati nel regno dell’“economia”, mentre la classe è stata spesso identificata con lavoratori bianchi, maschi ed eterosessuali in un rapporto di lavoro standard. I sistemi differenziali di oppressione come il sessismo e il razzismo erano considerati all’opera ai margini del capitalismo, che poteva sicuramente strumentalizzare i processi di gerarchizzazione da essi generati senza smettere di rimanere un potere fondamentalmente omogeneizzante. Sono convinto che una tale comprensione del capitalismo sia profondamente sbagliata, e che un modo diverso di guardare alla storia e al funzionamento contemporaneo del capitalismo potrebbe fornirci un modo efficace per affrontare la questione della “simultaneità” dei sistemi di oppressione sollevata dalle teorie dell’intersezionalità.
In gioco c’è innanzitutto la questione del rapporto del capitale con la “differenza” (Mezzadra e Neilson, 2019: 32-38). Si tratta di una questione che è stata riformulata negli ultimi anni da storici del colonialismo e storici globali del lavoro, da studiosi postcoloniali e da ricercatori critici che lavorano sul tema dello sviluppo. C’è un consenso emergente sul fatto che quella che Lisa Lowe chiama la “produzione sociale della ´differenza`” (1996: 28) è un momento distinto e cruciale nelle operazioni del capitale, che lavora in tandem con (e permette) la produzione di “lavoro astratto” come norma per la riproduzione del capitalismo in generale. Nel mio lavoro con Brett Neilson (2013, 2019) ho sostenuto che l’interazione tra differenza e astrazione, o omogeneità ed eterogeneità, è particolarmente evidente nel funzionamento del capitalismo globale contemporaneo. Questa interazione riguarda in particolare la questione del lavoro. A partire dalla definizione di Marx della forza-lavoro come “l’aggregato di attitudini e capacità” contenuto nel corpo, “la personalità vivente di un essere umano” (Marx, 1976: 270), sostengo che c’è bisogno di sottolineare lo scarto tra l’elemento delle attitudini e delle capacità e il loro “contenitore”, il corpo (Marx usa la parola tedesca Leiblichkeit, la cui materialità assoluta non è adeguatamente resa dalla traduzione inglese con “forma fisica”).
Una tale enfasi sul corpo apre nuovi orizzonti per la comprensione della forza lavoro e della sua produzione come merce. Ciò che è in gioco qui è ciò che possiamo chiamare la produzione di soggettività che è richiesta per l’esistenza stessa di quella merce. La fabbricazione differenziale di corpi gerarchizzati, dove i sistemi di oppressione come il sessismo e il razzismo hanno un ruolo di primo piano, emerge come un momento cruciale nella produzione della forza-lavoro come merce, che secondo Marx è la pietra angolare su cui si basa non meno che l’esistenza del capitalismo. Il confine stesso tra produzione e riproduzione, così come tra lavoro produttivo e improduttivo, appare messo in crisi e sfumato da questo punto di vista. Ed è facile vedere che una comprensione meramente economicistica del capitalismo e dello sfruttamento diventa insostenibile. Il momento che ho chiamato di “una produzione di soggettività” ha piuttosto molteplici dimensioni che devono essere riconosciute come interne allo sfruttamento. Ci troviamo di fronte a una panoplia di figure soggettive (sfruttate), la cui esperienza di oppressione e sfruttamento è decisamente mediata da diverse posizioni del soggetto (dove, per esempio, possono prevalere il razzismo, il sessismo o l’eteronormatività) mentre la loro “simultaneità” è orchestrata dalle operazioni del capitale.
La classe è oggi composta da questa moltitudine di differenze che vivono, lavorano e lottano sotto la pressione dello sfruttamento del capitale. La molteplicità è il segno distintivo della classe. Mentre sottolineo la rilevanza di una nozione non economicistica di sfruttamento per ripensare la classe oggi, è necessario aggiungere che la politica di classe oggi richiede una panoplia di movimenti e lotte che vadano ben oltre i confini della classe. Una volta che riconosciamo la rilevanza costitutiva per il funzionamento dello sfruttamento, per esempio, del razzismo e del sessismo, le mobilitazioni contro di essi, che possono anche includere persone che non sono “sfruttate”, sono della massima importanza – e non possono mai essere considerate come rivolte a una sorta di contraddizione “secondaria”. Parallelamente a queste lotte trasversali è necessario forgiare e praticare nuove forme di solidarietà e spazi di convergenza, dove l’intersezionalità diventa un metodo per una molteplicità di incontri e per contrastare l’ossificazione delle politiche identitarie. Quest’ultima può sicuramente giocare un ruolo positivo nell’aprire nuovi campi di lotta, ma è sempre a rischio di diventare un ostacolo per processi più ampi di soggettivazione – per costruire una base più efficace per le lotte contro lo sfruttamento e l’oppressione. La nozione di classe, una “classe moltitudinaria” o una “classe intersezionale” per dirla con Michael Hardt e Toni Negri (2019: 84), fornisce un nome soggettivo a quella base e apre nuove linee di indagine e di intervento politico. E la reinvenzione dell’intersezionalità di cui ho parlato sopra (come “intersezionalità delle lotte”, per ricordare le parole di Angela Davis) sembra prefigurare una nuova politica della solidarietà e persino nuove politiche di classe.
Bibliografia
Ambedkar, B.R. (2016). The Annihilation of Caste. Ed. and annotated by S. Anand, London – New York: Verso.
Bohrer, A.J. (2019). Marxism and Intersectionality. Race, Gender, Class, and Sexuality Under Contemporary Capitalism. Bielefeld: Transcript.
Carasthatis, A. (2016). Intersectionality. Origins, Contestations, Horizons. Lincoln and London: University of Nebraska Press.
Collins, P.H. (2000). Black Feminist Thought. Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment, second edition. New York and London: Routledge.
Crenshaw, K.C. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics. University of Chicago Legal Forum, 140, 139-167.
Crenshaw, K.C. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. Stanford Law Review, 43(6), 1241-1299.
Davis, A. (2016). Freedom is a Constant Struggle. Ferguson, Palestine, and the Foundations of a Movement. Chicago: Haymarket Books.
Gines, K.T. (2014). Race Women, Race Men and Early Expressions of Proto-Intersectionality. In N. Goswami, M. O’Donovan & L. Yount (Eds.). Why Race and Gender Still Matter: An Intersectional Approach (pp. 13-26). London: Pickering & Chatto.
Haider, A. (2018). Mistaken Identity. Race and Class in the Age of Trump. London – New York: Verso.
Hardt, M., & Negri, T. (2019). Empire, Twenty Years On. New Left Review, 120, 67-92.
Jones, C. (1949). An End to the Neglect of the Problems of the Negro Woman! In New Frame: https://www.newframe.com/from-the-archive-an-end-to-the-neglect-ofthe-problems-of-the-negro-woman/.
Lorde, A. (1982). Zami: A New Spelling of My Name. A Biomythography. Berkley, Calif.: The Crossing Press.
Lowe, L. (1996). Immigrant Acts: On Asian American Cultural Politics. Durham, NC: Duke University Press.
Marx, K. (1976). Capital, Vol. 1. New York: Vintage Books.
Mezzadra, S. (2011). Bringing Capital Back In: A Materialist Turn in Postcolonial Studies? InterAsia Cultural Studies, 12(1), 154-164.
Mezzadra, S. (2021). Challenging Borders. The Legacy of Postcolonial Critique in the Present Conjuncture. Soft Power, 7(2), 21-44.
Mezzadra, S., & Neilson, B. (2013). Border as Method, or, the Multiplication of Labor. Durham: Duke University Press.
Mezzadra, S., & Neilson, B. (2019). The Politics of Operations. Excavating Contemporary Capitalism. Durham: Duke University Press.
Nash, J.C. (2019). Black Feminism Reimagined After Intersectionality. Durham: Duke University Press.
Roediger, D. (1991). The Wages of Whiteness: Race and the Making of American Working Class. London – New York: Verso.
Roy, A. (2016). The Doctor and the Saint. In B.R. Ambedkar (Ed.). The Annihilation of Caste (pp. —). London – New York: Verso.
Said, E.W. (1983). Traveling Theory. In The World, the Text, and the Critic (pp. 226–247). Cambridge: Harvard University Press.
Said, E.W. (1994). Traveling Theory Reconsidered. In Reflections on Exile and Other Essays (pp. 436-452). Cambridge: Harvard University Press.
Taylor, K.-Y. (2017). How We Get Free. Black Feminism and the Combahee River Collective. Chicago: Haymarket Books.
[1] Si veda per esempio Roediger (1991).
[2] Si veda per esempio Thompson (2020).
[3] Si veda per esempio Nash 2019.
[4] Si veda Carasthatis (2016, capitolo 1) e Bohrer (2019, capitolo 0).
[5] ndt: si legge nel testo di Thompson: “graphic monument to the bitter exploitation of this most exploited section of the American working population – the Negro women.”. Abbiamo mantenuto l’aggettivazione “negre” decidendo di attenerci il più possibile al testo originale.
[6] ndt: nel testo originale: “meet this triple exploitation – as workers, as women, and as Negroes”.
[7] ndt: nel testo originale: “not equality, but degradation and super-exploitation: this is the actual lot of Negro women!”.
[8] ndt: nel testo originale: “as women, and as Negroes”.
[9] Si veda per esempio Garcia (1997).
Traduzione in italiano di Clara Mogno. La versione originale del testo è stata pubblicata in Papeles del Ceic, 2021/2.