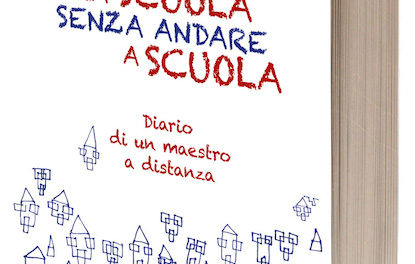di ANGELA MAURO.
Cosa significa questo premio per la sua generazione?
Riaccostando le due notizie di oggi, la morte di Dario Fo e quella del Nobel a Dylan, viene da dire che quella dell’accademia di Stoccolma è una bella dimostrazione di intelligenza, visto che anche Fo è un premio Nobel. Si dimostra che l’accademia svedese, malgrado il suo accademismo estremo, è capace di questi colpi di testa.
È un gesto politico?
Sì, direi che è un colpo politico molto bello da leggersi anche contro Trump. È un gesto pieno di politica e dimostra che anche accademia può essere… like a rolling stone…
Come canta Dylan. Ma come giudica il fatto che il mondo in cui Trump potrebbe diventare presidente degli Stati Uniti è lo stesso in cui il Nobel della Letteratura va a Bob Dylan? Cioè a colui che cantò la rivoluzione del ’68 prima che accadesse, che iniziò nel ’62 da The ballad of Emmett Till, la sua prima canzone di protesta sull’assassinio di un giovane afro-americano che aveva osato fischiare ad una donna bianca, per poi cantare sullo stesso palco dove Martin Luther King parlò del suo sogno, I have a dream, alla marcia per i diritti civili nel ’63…
Ci sono due aspetti che sottolineerei. Da un lato, c’è il Bob Dylan rivoltoso, il ribelle, l’allievo di Woody Guthrie. Cioè l’interprete di quella rabbia ribelle, di quella capacità ribelle che è stata propria di un certo proletariato americano. Soprattutto nel primo Dylan c’è una continuazione degli anni ’30 americani, lui ha scritto pagine che somigliano molto a Steinbeck, vero furore e tradizione classica ribelle americana in cui c’è una violenza di risposta che è pari alla violenza e brutalità del capitale americano.
Steinbeck che tra l’altro è anche lui Premio Nobel per la Letteratura nel 1962.
Esatto. La parabola di Dylan mi ha sempre affascinato negli anni ’60. Anche perché il sentimento che animò il ’68 lui ce l’aveva già prima. Fin dai primi anni ’60, appariva come interprete di quello che stava succedendo in una società americana aperta e piena di speranza, oltre che di rabbia.
 A un certo punto però lui rifiutò di essere il cantore dei ribelli, prese le distanze dai movimenti, sempre combattuto tra la protesta collettiva e l’ambizione di artista e a questo punto diremmo di “intellettuale” tout court, tra il noi e l’io, insomma. Ma accennava ad un secondo aspetto sul Nobel a Dylan: quale?
A un certo punto però lui rifiutò di essere il cantore dei ribelli, prese le distanze dai movimenti, sempre combattuto tra la protesta collettiva e l’ambizione di artista e a questo punto diremmo di “intellettuale” tout court, tra il noi e l’io, insomma. Ma accennava ad un secondo aspetto sul Nobel a Dylan: quale?
Il secondo aspetto assolutamente importante è il fatto che probabilmente l’accademia comincia ad assaporare quello che sta passando un po’ nell’arte. C’è un elemento formale dell’apprezzamento estetico per il canto di Dylan. Ormai parlare di arte è parlare di forme di vita, non semplicemente descrivendola ma vivendola e proiettandola in avanti. L’arte sta diventando sempre di più una performance e Dylan è davvero il prototipo di questa interpretazione formale del fare artistico. Si può dire che c’è una vita ribelle, una vita buona e una vita bella: lui riesce a metterle insieme tutt’e tre.
Pensa che la morte di Dario Fo abbia influenzato la scelta dell’Accademia?
Non ne ho idea, ma può darsi. Potrebbe darsi che, pur essendo dei vecchi barboni, magari sono riusciti comunque a sviluppare un po’ di immediatezza e intelligenza nascosta (ride). Ma penso che la scelta fosse già maturata.
Ad ogni modo, il Nobel a Dylan riconosce un po’ le ragioni del ’68, anche se cade in una fase storica percorsa da forti e insolute disuguaglianze?
Sì. Direi che questa scelta corrisponde un po’ alla stanchezza del neoliberismo, una stanchezza che si sta diffondendo proprio per via di queste disuguaglianze. Per dirla con Dylan: The Times They Are a-Changin. Ecco, è una scelta che si inserisce in questo clima.
Anche se non si vedono forti movimenti sociali oggi.
Rispondo con una battuta: in Svezia stanno in alto, è possibile che dall’alto vedano di più…
questa intervista è stata pubblicata sul sito dell’Huffington Post il 13 ottobre 2016