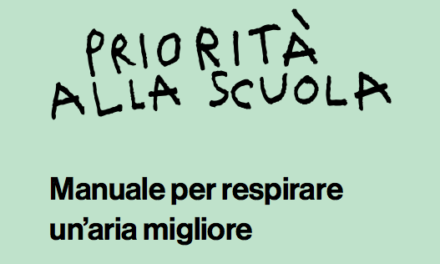di MIGUEL MELLINO.
Parma: “Le nostre vite, valgono più dei vostri soldi”
Nei giorni scorsi altri due migranti sono stati assassinati in Italia. Del primo, Mohamed Habassi, trentatreenne tunisino, ucciso ferocemente a Basilicagoiano, un borgo vicino Parma, da due (a prima vista) insospettabili cittadini parmensi, con il concorso di quattro migranti rumeni assoldati come parte della brutale spedizione punitiva, non si è praticamente parlato. Se non fosse stato per Annamaria Rivera (http://ilmanifesto.info/squadroni-della-morte-a-parma), da tempo impegnata nella denuncia di quelle scene di quotidiano “microrazzismo”, l’episodio, pur nella sua eccezionalità, dovuta alla violenza con cui Habassi è stato pestato e infine ucciso dai suoi carnefici, sarebbe rimasto confinato nelle pagine della cronaca nera locale, già pronto a una rapida e autoassolutoria “rimozione”.
E tuttavia, stando agli statuti oramai acquisiti della criminologia classica, le modalità efferate e l’accanimento contro il corpo di Habassi, ci dicono molto sia dell’omicidio che dei suoi autori, ma soprattutto dell’odio, della rabbia e della violenza che cova in alcuni segmenti della società italiana contro i migranti e contro tutto ciò che rappresentano. Habassi sarebbe stato ucciso perché la proprietaria di casa, compagna di uno degli assassini, era stanca di chiedergli in vano di pagare l’affitto e di ricevere in cambio (secondo quanto hanno riportato i giornali) risposte “strafottenti”. E’ in questo clima di “giustizia fatta con le proprie mani contro lo straniero” che ha preso corpo il brutale omicidio. E’ chiaro che questa violenza razzista trae linfa da diversi elementi: dallo stato di separazione-segregazione in cui vive buona parte dei migranti in Italia (forse senza paragone alcuno in Europa); dalla loro riduzione a meri “corpi da estrazione”, per stare a un’espressione di Achille Mbembe, da parte dell’attuale regime di controllo delle migrazioni sia europeo che nazionale; dal razzismo istituzionale, ovvero sia dalle molteplici pratiche di repressione e di sorveglianza quotidiana delle popolazioni migranti attraverso cui gli stati nazionali producono materialmente i “confini” – non solo alle frontiere, ma soprattutto nelle strade, nelle stazioni, negli aeroporti, nei luoghi di svago, ecc., – che dai dispositivi legali di razzializzazione del lavoro e gerarchizzazione della cittadinanza; dalle rappresentazioni razziste di africani, migranti dell’est, rom e cinesi (ma non solo) disseminate sia nelle tradizionali “strutture del sentire” nazionali, sia nei suoi più insospettabili archivi del sapere e luoghi chiave di produzione della conoscenza su cui si plasma quotidianamente, negoziando i propri modi di godimento, il “senso comune”(scuola, università, agenzie statali o terziarizzate; ma anche stampa, cinema, televisione, intrattenimento e mass-media in generale). Si tratta di un “dispositivo di governo” che non fa che alimentare, soprattutto in momenti di economica o di depressione sociale e politica, il processo di disumanizzazione e trasformazione degli altri in “capri espiatori” e in oggetto di negazione e violenza. E tuttavia, per assumere in pieno la questione, sempre di violenza e di odio razzista occorre parlare: a nulla serve la ricerca delle cause (sociali) “prime” che in teoria agiscono dietro razzismo e razzisti, o l’identificazione degli eventuali “imprenditori politici dell’odio” (partiti xenofobi, destre sovraniste) come elemento chiave del problema. E’ chiaro che la crisi sta alimentando in Europa gli più umori retrivi – sciovinismi, sentimenti anti-immigrazione e securitarismi vari – soprattutto tra i perdenti della globalizzazione, e tra quelli più sottoposti allo stress derivante dalla logica ultra-concorrenziale del neoliberalismo, ma la radice del problema va cercata altrove. Il “governo” della crisi soffia sempre sui “comuni nocivi” (razza, nazione, impresa, famiglia), ma soffiare non è produrre, bensì esaltare, esasperare degli habitus già esistenti e predisposti ad accogliere il richiamo della “morte”. Il razzismo è un elemento strutturale (materiale e simbolico) di tutte le società moderne europee, un dispositivo primario di governo e di produzione delle popolazioni, e come tale deve essere assunto e affrontato. E’ il frutto dell’intreccio storico tra capitalismo e colonialismo a partire dalla conquista dell’America.
L’omicidio di Parma, in un primo momento, non ha innescato né i soliti sentimenti morbosi e sensazionalistici tipici di alcune notizie di cronaca nera costruite come “eccezionali”, né tanto meno la solita ricerca di elementi “autoassolutori” o “minimizzanti” con cui si tende sempre a salvaguardare, in questi casi, il mito coloniale e fascista dell’italiano brava gente. Certo, i primi articoli sul fatto non mancavano di riportare che Habassi non era molto gradito dai suoi vicini, che i suoi atteggiamenti, le continue liti con l’ex-compagna (poi deceduta), alteravano la “quiete” del quartiere, ovvero, non hanno mancato di produrre discorsivamente l’anormalità/eterogeneità portata da Habassi (la vittima) nella normalità/omogeneità dei “nativi” (i carnefici). Discorsi come questi, oltreché essere mossi da una codificazione razzista della società, si muovono entro una certa identificazione (non così) inespressa, se non proprio con gli assassini almeno con la “razionalità” dei loro moventi, finendo quindi per legittimare, mediante la costruzione di una sua plausibilità, l’omicidio. Tuttavia, nel complesso, come ricordava Annamaria Rivera, il fatto è passato sotto silenzio. Ed è proprio questo silenzio che vogliamo interrogare. Anch’esso può dirci molto, quanto l’efferatezza del delitto, ma questa volta non solo degli assassini. Il motivo di questo silenzio sarebbe forse da ricercare nell’estrema vicinanza degli assassini – del loro stile di vita, ambienti, professioni e posizioni sociali – a quei settori delle classi medie (famiglie perbene) che costituiscono spesso sia la posizione del soggetto enunciante, sia il destinatario silenzioso di buona parte del “discorso pubblico” e delle politiche istituzionali. Si tratta di quell’unità sociale (reale e immaginaria), e di uno dei suoi contesti geografici, che vengono spesso prodotti da un certo discorso egemonico nazionale sia come norma della società italiana, sia come modello o tipo-ideale; le rappresentazioni correnti di questa unità sociale e di questo suo specifico contesto geografico ci propongono un immaginario composto da famiglie appartenenti a una classe media laboriosa, a un’Emilia ricca, efficace e produttiva, a una delle patrie tanto delle piccole e medie imprese quanto delle cooperative, a una regione di grande “senso civico”, popolata da gente per lo più cordiale e civile, con un’alta “qualità della vita” e con migranti per la “maggior parte integrati”. E’ chiaro, dunque, che l’habitus che ha prodotto gli assassini è piuttosto intrecciato con quello di buona parte di coloro che avrebbero potuto scrivere o ragionare su di loro. Habassi è stato trovato in stato agonizzante, è morto dissanguato. Se silenzio c’è stato, dunque, è soprattutto perché dal punto di vista di un certo discorso egemonico sull’Italia e gli italiani, c’era davvero poco da dire: a chi addossare un simile orribile delitto? Come spiegarlo? Non c’era alcun elemento “altro” che potesse riportare la “norma” alla “normalità”: nessun “balordo”, nessuna periferia “degradata”, nessun “folle” o chiaro “nemico pubblico”, nessun “clan”, niente “malavita”, niente “economia sommersa”; non c’è qui nessun significante che potesse essere costruito come “arretrato”, “esterno” o “residuale” rispetto alla (presunta) “civiltà” o “modernità” di questo celebrato modo di vita e di produzione, insito nel cuore stesso della cosiddetta Terza Italia. In sintesi, non c’era qui alcun “altro” con cui legittimare la tipica “patologizzazione” autoassolutoria del razzismo, quella “cura terapeutica” che in Italia finisce sempre per espellere questo fenomeno dal suo quotidiano luogo di incubazione, e per legarlo a un qualcosa di “eccezionale”, cercando così di mantenere “immune” la (propria) comunità. E non essendoci “altro”, si resta soli, e in silenzio.
Gli amici: “ci ammazzano come bestie e non ci difende nessuno”
Il silenzio però è stato rotto da altri migranti amici della vittima e da un corteo organizzato dal coordinamento antifascista e antirazzista che si è svolto a Parma il 28 Maggio. Nel corteo, gli amici di Habassi hanno esposto uno striscione, scritto in arabo e in italiano, in cui si leggeva “Le nostre vite valgono più dei vostri soldi”. Alcuni di loro hanno poi riferito ad alcuni mezzi della stampa: “A noi possono ammazzare come bestie, tanto nessuno dice niente”. E’ stata una delle poche prese di parola contro la rimozione pubblica dell’omicidio, investita da un senso comune del tutto a proprio agio nel considerare l’assassinio di un migrante per un debito, o perché risultava molesto e strafottente, un fatto del tutto normale. A noi, invece, quanto è successo in questo piccolo borgo del parmense e il suo non-racconto ci dicono molto: del razzismo spietato, del risentimento piccolo borghese, dell’individualismo proprietario, del cinismo e dell’egoismo spaventosamente mercantili, della mancanza di ogni regola etica o minimamente solidale nel momento di difendere i propri beni materiali, la propria famiglia, i propri pari, il proprio territorio (materiale e simbolico), ovvero dei livelli di violenza e di sopraffazione che percorrono trame importanti di un tessuto sociale e produttivo costruito in buona parte su scala familiare e oramai quasi del tutto dipendente per il proprio successo dallo sfruttamento intensivo del lavoro migrante e delle delocalizzazioni produttive in territori “razzializzati”. E devono dirci molto, non tanto per riconfermare il solito, banale e atemporale stereotipo negativo dell’italiano medio, ma perché ciò che abbiamo di fronte sono gli effetti più perversi di quel processo di neoliberalizzazione della società italiana che sembra ormai entrato nel profondo delle sue linfe vitali. Un processo che, essendo incentrato sulla concorrenza generalizzata, sulla gerarchizzazione della cittadinanza e sulla distruzione del comune, della cooperazione e di ogni mutualismo, non può non avere il dispositivo razzista al centro del proprio modo di produzione di spazi, territori, società, soggettività, culture. Sia chiaro: non stiamo dicendo che il razzismo è un semplice prodotto del capitalismo neoliberale, della sua logica di valorizzazione. La questione è chiaramente più complessa. Come affermava Frantz Fanon, il razzismo è efficace come “politica di governo” perché sta dentro (e non fuori) la cultura delle società moderne europee: è stato un “supplemento costitutivo” dello stesso processo di formazione sia degli stati nazionali europei – tutti profondamente implicati nel governo delle colonie – e dei loro modelli culturali di cittadinanza. Il suo potere interpellante, il suo potere di mobilitazione sociale, ideologica e soggettiva, è tutto qui. Il razzismo è dentro l’aria che respiriamo, per riprendere la vecchia definizione di ideologia di Louis Althusser. Il capitalismo neoliberale ha solo articolato il mostro alla sua logica.
Rosarno: “Italia razzista”
Del secondo omicidio, quello di Sekiné Traorè, lavoratore agricolo maliano a Rosarno, si è parlato, e tuttora si parla, di più. A differenza del caso di Habassi, qui quell’Altro-esterno a cui imputare la tragedia invece c’è: e forse è (solo) per questo che se ne è parlato di più. Come nel primo caso, però, l’attenzione pubblico-mediatica non ha codificato l’omicidio di Sekinè come una morte generata dal razzismo: né in un primo momento, quando prevalevano le versioni “ufficiali” delle forze dell’ordine, né in un secondo momento, quando quelle versioni sono state smentite dalle testimonianze degli altri migranti, compagni di vita e di lavoro di Sekinè. I soli a parlare di razzismo in modo esplicito, e di omicidio razzista, sono stati ancora una volta i migranti, che durante una manifestazione di protesta a Rosarno, insieme agli antirazzisti, hanno urlato “Italia Razzista”, “polizia razzista”, “ci trattate come animali”. Da rilevare, che in qualche caso, anche questa presa di parola è stata minimizzata sulla stampa attraverso il solito gesto razzista di derisione caricaturale dei migranti. Come si può immaginare, alcune delle scritte durante la protesta erano in inglese, un fatto che ha consentito a una giornalista di R.it di precisare che si trattava di un “inglese maccheronico, ma chiaro” (www.repubblica.it/cronaca/2016/06/09/news/).
La prima versione dei fatti parlava di un migrante entrato in forte stato di escandescenza, a causa delle misere condizioni in cui si trovava a vivere, e che aveva minacciato un carabiniere con un coltello mentre si tentava di calmarlo. Il migrante, afferma la versione dell’arma, sarebbe morto a causa di un colpo sparato dal carabiniere per “legittima difesa” di fronte all’aggressione. Con il passare delle ore, grazie alle testimonianze degli altri migranti, questa versione è cominciata a vacillare. I migranti hanno parlato di sette carabinieri, e non di uno, entrati in modo violento nella tenda di Sekinè nella tendopoli di Rosarno. Aggiungono anche che il loro amico non era violento e che non aveva un coltello in mano, ma una pietra. Non è ancora chiaro ciò che è successo, semmai lo sapremo, visto poi come sono andati a finire i casi di Cucchi, Aldrovandi, Uva e altri. Poi del resto, a legittimare un carabiniere a sparare può essere anche il solo non essersi fermarti all’alt, se si è “neri a metà” della periferia di Napoli, come ci racconta il caso Bifolco. Ma a prescindere da quanto sarà accertato, non è difficile parlare in questo caso, come hanno fatto i migranti stessi, e al di là dalle effettive responsabilità dei singoli, di “omicidio razzista di stato”: appare ovvio che si tratta di una morte causata da un razzismo divenuto “intero modo di vita”, per richiamare qui in modo spettrale la nota definizione di cultura di Raymond Williams. Sekinè è stato ucciso dal razzismo come “sistema”, da un razzismo divenuto, come lo stesso fenomeno migratorio, “fatto sociale totale”, poiché presente e prodotto su una molteplicità di livelli: istituzionale e popolare, legale e culturale, sociale, psicologico ed economico. Come ricorda il comitato “Verità e giustizia per Sekinè Traorè”, formatosi dopo l’omicidio, dal 2008 a oggi, questo sarebbe il quinto omicidio di stato di africani a Rosarno, ovvero di casi di morte non naturale di migranti africani, causate dal “superamento della soglia di sopportazione umana”.
 Eppure, se l’omicidio di Sekinè Traorè ha avuto un qualche spazio nei media, tale minima attenzione non ha avuto certamente l’effetto di rendere più “visibile” il razzismo come “questione sociale” primaria, come fenomeno costitutivo della società italiana e dei suoi modi di sfruttamento delle popolazioni. Il parlare di più, paradossalmente, ha detto ancora meno del silenzio del primo caso. La morte di Rosarno, oltre la specificità del fatto che vede coinvolte in modo diretto le forze dell’ordine, è stata subito inserita in una particolare catena di significazione, storica e ricorrente nella storia italiana, in cui l’Altro-esterno-da-sé a cui imputare la tragedia si imponeva in modo quasi del tutto naturale. Il racconto dell’episodio è stato spesso accompagnato da immagini e discorsi che tendevano ad accentuare, per così dire, la “meridionalità”, l’insolita e disumana “arretratezza”, “l’assenza dello stato” (davvero grottesco, visto che la morte è stata causata qui da un carabiniere), della situazione in cui è avvenuta la morte di Sekinè. E’ finita così per imporsi una certa narrazione dei fatti incentrata sul classico discorso del Sud “arretrato”, di un territorio “abbandonato dello stato”, in cui buona parte delle terre sono ancora dominate da un modo di sfruttamento del lavoro agricolo “semi-schiavistico”, residuale, non-moderno e non-civile, eccezionale, e controllato soprattutto dal “caporalato”, divenuto nel discorso pubblico l’unico significante negativo di questo stato di cose. Quanto è accaduto è stato rinchiuso in una “specificità” tutta locale. Attraverso questa modalità di racconto, la morte di Sekinè viene espunta dal presente, dalla norma, dai contesti quotidiani del “noi”, per essere proiettata in una dimensione spazio-temporale “altra”, “irrazionale”, non-moderna, costruita sin da sempre come “esterna” e “non-contemporanea” alla cosiddetta “società civile”. Inoltre, questo tipo di rappresentazione, ampiamente diffusa anche all’interno di settori cosiddetti progressisti della sinistra (istituzionale e non), non fa che rafforzare una “doppia razzializzazione” del tutto funzionale all’attuale ordine del discorso: prima di tutto di Sekinè, ulteriormente declassato a vittima-oggetto, poiché, attraverso la propria morte, non fa che consentire l’empowerment dei “salvatori” o “liberatori di schiavi”, la loro soggettivazione come veicoli di “coscienza morale”, di storia e di “emancipazione”; ma anche del Meridione, che finisce qui per essere rigettato ancora una volta, per dirla con Chakrabarty, nella “sala d’attesa della storia” e della modernità e della norma capitalistica.
Eppure, se l’omicidio di Sekinè Traorè ha avuto un qualche spazio nei media, tale minima attenzione non ha avuto certamente l’effetto di rendere più “visibile” il razzismo come “questione sociale” primaria, come fenomeno costitutivo della società italiana e dei suoi modi di sfruttamento delle popolazioni. Il parlare di più, paradossalmente, ha detto ancora meno del silenzio del primo caso. La morte di Rosarno, oltre la specificità del fatto che vede coinvolte in modo diretto le forze dell’ordine, è stata subito inserita in una particolare catena di significazione, storica e ricorrente nella storia italiana, in cui l’Altro-esterno-da-sé a cui imputare la tragedia si imponeva in modo quasi del tutto naturale. Il racconto dell’episodio è stato spesso accompagnato da immagini e discorsi che tendevano ad accentuare, per così dire, la “meridionalità”, l’insolita e disumana “arretratezza”, “l’assenza dello stato” (davvero grottesco, visto che la morte è stata causata qui da un carabiniere), della situazione in cui è avvenuta la morte di Sekinè. E’ finita così per imporsi una certa narrazione dei fatti incentrata sul classico discorso del Sud “arretrato”, di un territorio “abbandonato dello stato”, in cui buona parte delle terre sono ancora dominate da un modo di sfruttamento del lavoro agricolo “semi-schiavistico”, residuale, non-moderno e non-civile, eccezionale, e controllato soprattutto dal “caporalato”, divenuto nel discorso pubblico l’unico significante negativo di questo stato di cose. Quanto è accaduto è stato rinchiuso in una “specificità” tutta locale. Attraverso questa modalità di racconto, la morte di Sekinè viene espunta dal presente, dalla norma, dai contesti quotidiani del “noi”, per essere proiettata in una dimensione spazio-temporale “altra”, “irrazionale”, non-moderna, costruita sin da sempre come “esterna” e “non-contemporanea” alla cosiddetta “società civile”. Inoltre, questo tipo di rappresentazione, ampiamente diffusa anche all’interno di settori cosiddetti progressisti della sinistra (istituzionale e non), non fa che rafforzare una “doppia razzializzazione” del tutto funzionale all’attuale ordine del discorso: prima di tutto di Sekinè, ulteriormente declassato a vittima-oggetto, poiché, attraverso la propria morte, non fa che consentire l’empowerment dei “salvatori” o “liberatori di schiavi”, la loro soggettivazione come veicoli di “coscienza morale”, di storia e di “emancipazione”; ma anche del Meridione, che finisce qui per essere rigettato ancora una volta, per dirla con Chakrabarty, nella “sala d’attesa della storia” e della modernità e della norma capitalistica.
Il “caporale”, come il “passeur” per quanto riguarda il controllo delle migrazioni, l’emblema del male da sconfiggere, il simbolo dell’eterna arretratezza culturale del Sud. Come sempre, si tratta di salvare il Sud da se stesso. Non a caso, si è tornato a parlare in questi giorni della legge di abolizione del caporalato in esame al parlamento. Tutti sappiamo che il caporale è solo un intermediario all’interno di un sistema più ampio, legalmente costituito, che consente e legittima il suo operare. Come evidenziato in modo piuttosto efficace da una ricerca a cura di Enrica Rigo uscita di recente – Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro (2015) – il problema qui non è tanto il caporale (sempre più spesso un migrante) quanto l’intera filiera produttiva, ovvero quella lunga rete fatta da aziende, consorzi, industrie, catena di distribuzione e logistica che sono i veri beneficiari di tutto il sistema. Si tratta di una rete di “estrazione di valore” che comincia “materialmente” al Sud, ma che si estende ben oltre le regioni meridionali e che appare del tutto integrata ai settori più “avanzati” del sistema capitalistico, come la finanza e la gestione umanitaria delle migrazioni. Su quest’ultimo punto, Leggi, migranti e caporali, mette molto bene in luce in che modo l’apparato umanitario, vincolando la concessione del diritto di asilo a forme di debito e promuovendo la figura del rifugiato come lavoratore a basso costo, è sempre più coinvolto non solo nello sfruttamento del lavoro migrante, ma anche come strumento di un’ulteriore gerarchizzazione della forza lavoro migrante e non. E si tratta di un aspetto che non appartiene affatto alla “località” del modello: visto che anche in Germania, Gran Bretagna e Danimarca sono state approvate delle leggi che vanno in questa direzione.
Come per l’omicidio di Habassi a Parma, dunque, nemmeno nell’omicidio di Traorè a Rosarno c’è un “altro” a cui attribuire in qualche modo l’omicidio. Forse nulla ci spiega meglio questi due omicidi della stimolante definizione di razzismo proposta da Ruth W. Gilmore, geografa nordamericana, attivista del movimento Black Lives Matter e sicuramente una delle studiose più interessanti di questo fenomeno: “il razzismo è la produzione e lo sfruttamento, legittimati in qualche modo dallo stato, di diversi gradi di ‘vulnerabilità a morte prematura’ tra i diversi gruppi sociali, e nell’ambito di geografie politiche distinte ma tuttavia densamente interconnesse”. Qualcosa di simile ci aveva detto anche Michel Foucault in Bisogna difendere la società (1977): il razzismo “mette insieme” e “separa” allo stesso tempo, nel senso che lega la vita e la produttività di una parte della popolazione (gli inclusi, la società civile) alla morte (fisica e/o sociale) di un’altra (gli esclusi, gli eccedenti). A Parma come a Rosarno, a Londra come a Parigi. E gli ingranaggi della sua macchina finiscono sempre per inghiottire (per razzializzare) anche gruppi e soggetti (poveri) “autoctoni”. Il razzismo, dunque, è tutt’altro che irrazionale o esterno rispetto all’attuale “razionalità neoliberale”. Se le cose stanno così, l’antirazzismo non può essere relegato a un elemento “accessorio” della lotta politica, come spesso accade. Dobbiamo necessariamente renderne conto nelle nostre pratiche teoriche e politiche quotidiane. Altrimenti, si rischia una spettrale convivenza con i partigiani del “silenzio”.