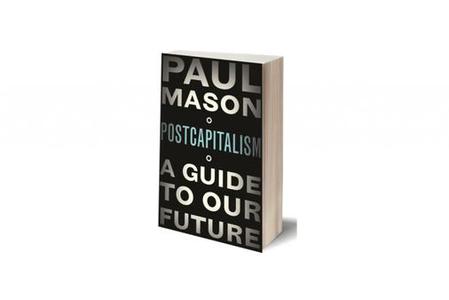di SANDRO CHIGNOLA.
Italian Theory? Note sullo stato della filosofia italiana – 6
(Intervento letto al convegno: L’Italian theory existe-t-elle? / Does Italian Theory exist?, Colloque international / International Conference, Université de Paris Ouest Nanterre La Defense / Université de Paris I, Sorbonne, 24-25 Janvier 2014. In corso di pubblicazione in traduzione francese).
Considerate la vostra semenza
Inferno, XXVI, 118
Mi è stato chiesto di intervenire, se ho ben capito, sulla circolazione dell’Italian theory. Operazione preliminare necessaria sarebbe tuttavia quella di chiedersi se un’Italian Theory esista, quale ne sia lo statuto, di quale teoria e di quale italianità si parli, quando ne vengono evocati i termini. Quando Paolo Virno e Michael Hardt, alla metà degli anni ’90, pubblicano Radical Thought in Italy. A Potential Politics, la «difference of italian thought» che viene posta in primo piano e, in qualche modo, rivendicata, non pertiene alla specificità di una tradizione, né ad un particolare orientamento nel dibattito filosofico: essa pertiene, piuttosto, a uno stile. A uno stile di pensiero come pratica collettiva e come militanza rivoluzionaria; due opzioni che impongono una determinata attitudine sperimentale al lavoro intellettuale.
Facile sarebbe ricordare come questo stile si sia forgiato nelle lotte e sia stato messo alla prova nelle galere. Come, cioè, esso si sia prodotto non sulla linea di sorvolo della riflessione, ma attraverso un’immersione nel reale capace di imporre e di registrare discontinuità e rotture. Meno scontato, forse, il chiedersi quanto di questo stile sia «italiano» – e cioè: inscritto in una specifica prassi e in una determinata serie, quella, all’interno del secolo breve, del lungo ’68 universitario e operaio che si prolunga sino al marzo 1977 e che costruisce la differenza italiana contro la tradizione gramsciana del PCI – e quanto invece gli derivi da «fuori», in quella che, mi sembra, può davvero essere intesa come una linea di circolazione nella quale l’Italian Theory non sta come un soggetto, ma, piuttosto, in una modalità contemporameamente attiva e ricettiva, sperimentale e trasformativa.
Deriva di qui – mi piace giustificare le mie opzioni – il taglio che ho scelto di dare al mio intervento. Avrei potuto entrare nel merito delle tesi che hanno imposto all’attenzione globale, con quella che, certo, è stata una buona strategia di marketing – non imputo nulla di ciò a Paolo Virno e a Michael Hardt – il logo Italian Theory. L’ampia ricezione, a partire dalla prima metà degli anni duemila, nell’eco delle giornate di Genova, di Empire e, pressoché contemporaneamente, dei volumi di Agamben, a partire da Homo sacer, hanno reso possibile un vasto progetto di traduzioni sulla cui scia si sono venuti a collocare convegni, la compilazione di antologie e di numeri monografici di riviste, la stesura di ricerche di dottorato. Varrebbe forse la pena di analizzare, così come altri ha fatto in rapporto alla French Theory che ha dominato i cultural studies negli Stati Uniti – e, di lì, la parte anglofona del globo -, questa fase, ancora embrionale, di un’istituzionalizzazione, anche in questo caso in buona parte esterna ai dipartimenti di filosofia, il cui rischio è quello di compattare, con un evidente lavoro di semplificazione, produzioni e prese di parola differenti tra di loro e sorrette da intenzionalità apertamente divergenti. Non mi interessa, tuttavia, farlo in questa sede. È sufficiente notare come lo stesso logo Italian Theory, mimeticamente riprodotto per calco dal primo, venga adottato come denotativo per una politica della filosofia – qui il genitivo deve essere inteso in senso oggettivo – volta a imporre, sempre sull’orlo di una subalternità, temi e autori altrimenti eccentrici all’attenzione del sistema dei media. Non sono però un sociologo della cultura e quello che mi interessa è una politica della filosofia – ora intesa nella forma soggettiva del genitivo – per la quale l’attitudine sperimentale del pensiero radicale «italiano» – in Italia, titolano Virno ed Hardt, alludendo ad una traiettoria, ad una territorializzazione, ad una fase e non a una ripetizione, ad un momento e non a una «tradizione» – mantiene una certa rilevanza. Di qui, dicevo, la struttura di questo mio intervento. Cercherò di tracciare un doppio movimento: quello di decentramento in base al quale l’operaismo italiano assorbe e rielabora la sconfitta rinnovando il proprio patrimonio teorico e concettuale nel confronto con la filosofia francese – nulla di proprio, dunque, mentre il proprio della filosofia accademica italiana di quegli anni è il rinchiudersi in un dibattito autoreferenziale e asfittico, ancora inesaurito – e quello di ritorno su di sé – un ritorno che non definisce alcuna identità, ma solo il rilancio di uno stile, di quella che poco sopra ho definito un’attitudine sperimentale – capace di rimettere in movimento un’analisi, ad un tempo teorica e politica, discussa e recepita su scala globale perché programmaticamente situata nel piano di immanenza del farsi-mondo del capitale.
Quali sono gli autori e i tempi di questa dinamica di ricezione, trasformazione e rilancio per mezzo della quale si rinnova la tradizione operaista? In che modo, scontrandosi con le retoriche sulla fine della storia, l’Italian Theory – chiamo così, per convenzione, il pensiero radicale che si innesta sulla circolazione globale delle lotte e che territorializza nel campo dell’oltremarxismo italiano la filosofia francese contemporanea – impatta il linguistic turn e si rinnova? Quello che verrà definito postoperaismo nulla ha a che vedere con una sconfessione o con un’abiura: tantomeno, come a volte gli verrà imputato, con un decentramento dell’inchiesta sulla pura circolazione del capitale e sulle contraddizioni, politicamente valorizzabili come ultima chance in tempo di postpolitica, che percorrono la società civile. Al contrario, ed è una delle cose che questo mio intervento intende ribadire, se una continuità tra operaismo e postoperaismo si dà sul piano dell’elaborazione teorica e politica – i due termini non possono essere separati, pena il ridurre il postoperaismo, mi scuso per la brutale semplificazione, ad una figura interna, neutralizzata e minore, di una patetica e triste storia della filosofia italiana -, questa continuità nulla ha a che vedere con il trasmettersi di una tradizione o di una testimonianza: con un’etica e con una vocazione, piuttosto. Quella vocazione alla politica che Max Weber identifica al dennoch di un’ostinazione che impone di proseguire a cercare l’impossibile anche dopo la più secca delle sconfitte.
Credo di poter dire, pur consapevole del rischio di semplificazione che corro, che sono quattro le macchine di pensiero con i quali il pensiero radicale italiano (e non solo) si confronta per trasformarsi tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80. Quattro dispositivi sui quali immediatamente cala l’interdizione degli apparati burocratici che sovraintendono alla politica culturale e accademica italiana. A questo proposito, è sufficiente ricordare la posizione che Cacciari assume su «Aut Aut» contro Foucault e contro Deleuze. Vale la pena ribadirlo: il postoperaismo si sviluppa in buona sostanza fuori e contro la tradizione gramsciano-togliattiana e, dunque, in aperta rottura con il progetto di nazionalizzazione delle masse avviato nel secondo dopoguerra in Italia. Quattro macchine di pensiero, dicevo. Oltre ai già citati Foucault e Deleuze-Guattari includerei tra di esse, seppure in posizione più defilata e contingente, Baudrillard e Lyotard. Pensare il presente, e cioè il divenire, la trasformazione, implica di necessità riaprire continuamente l’inchiesta e la concettualizzazione. E, con essa, la tracciatura delle resistenze e dei processi di soggettivazione che orientano il trasformarsi stesso delle forme di cattura che li inseguono.
Foucault, innanzitutto. Ciò che di Foucault entra nella cassetta degli attrezzi postoperaista sono da subito due istanze. La prima ribadisce un principio – sono le resistenze a costringere il potere a reinvestirsi secondo altre modalità e altri profili -, la seconda lo ingrana ad una diagnosi. Non è forse il caso di insistere troppo – dopo i libri di Leonelli e di Macherey – sulla prossimità di Foucault a Marx. Per Foucault, analista del potere, il funzionamento della società industriale si fonda su dispositivi di assoggettamento che accoppiano tattiche di internamento-sfruttamento a tattiche di formazione-organizzazione. La prima direttrice è quella che fa sì che il tempo della vita venga trasformato in tempo di lavoro: secca estrazione di plusvalore assoluto, la chiamerebbe Marx. La seconda investe direttamente come oggetto i corpi individuali plasmandone le attitudini, selezionandone le qualità, correggendone i difetti e potenziandone la componibilità in schemi organizzativi. Qui, l’anatomopolitica delle discipline, in cui si conferma la connotazione produttiva (e non interdittivo-repressiva) del potere, trasforma i corpi in forza lavoro; la plasticità congenita alla vita viene imbrigliata, organizzata, piegata e con ciò trasformata in forza produttiva. Una serie di specifici dispositivi, funzionali a quella che Marx chiamerebbe estrazione del plusvalore relativo, lavora a produrre le disposizioni a produrre. E cioè – secondo la prospettiva che Foucault rivendicherà esplicitamente come fuoco costante del suo lavoro teorico: non già un’analitica del potere e dei suoi tipi, quanto piuttosto «une histoire des différentes modes de subjectivation de l’être humain dans notre culture» – a fabbricare la forza lavoro in quanto disposizione soggettiva oggettivamente uniformata alle condizioni di produzione (Legrand).
Quando Foucault sposterà il baricentro della sua analisi sui biopoteri, lo farà ai fini di tracciare la genealogia di dispositivi di governo e di disciplina che non si limitano a perimetrare spazi produttivi direttamente organizzati e attraversati dal comando, ma ambienti rispetto ai quali l’istanza di regolazione si cala come intervento sociale complessivo – «sur la société elle même dans sa trame et son épaisseur», scrive Foucault (NBP, 151) – ai fini di impiantare altre attitudini e altre disposizioni soggettive. Deriva da ciò un doppio ordine di conseguenze. La prima concerne la nozione di potere e il suo statuto. Foucault non pensa il potere come una proprietà, ma come una strategia. E, dato ulteriore, come una strategia costantemente contrastata, anticipata, messa alla prova da processi che tendenzialmente le sfuggono. Tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, ragionare con Marx oltre Marx – poco sopra dicevo: Foucault aiuta anche a sviluppare una diagnostica, a imporre uno sguardo sagittale su di un presente sempre mobile ed evolutivo -, significa fondamentalmente leggere l’organizzazione dei biopoteri come una conseguenza della fuoriuscita dal fordismo e come impianto di un differente sistema di valorizzazione che estende alla società nel suo complesso il comando e i suoi schemi di sussunzione. La seconda riguarda invece lo statuto del soggetto. E cioè la costitutiva eccedenza che segna quest’ultimo in rapporto al sistema fabbrichista, una volta che produzione ed estrazione del plusvalore si spostino altrove rispetto alle chiuse mura della fabbrica. Ciò che viene messo ora al lavoro non sono gesti, tempi e ritmi disciplinarmente comandati, ma le caratteristiche speciespecifiche dell’uomo in quanto essere vivente: il linguaggio, la facoltà di cooperazione, l’attitudine alla relazione. Si badi bene, questa non è un’affermazione estrinseca rispetto a Marx. Nel primo libro del Capitale Marx definisce la forza-lavoro nei termini che seguono: «somma di tutte le attitudini fisiche e intellettuali esistenti nella corporeità di un uomo» (Kap. I, 2: 4; MEW, XXIII, 181). «Inbegriff der physischen und geistigen Fähigkeiten»; e cioè: non solo di quella parte meccanicamente messa al lavoro in rapporti di produzione indipendenti ed estrinseci rispetto al soggetto. Ciò che qui fa il suo ingresso è la nozione di forza-lavoro come dynamis, come potenza, come una potenza inerente alla natura umana che solo all’altezza del postfordismo, quando cioè i processi della messa a valore eccedono il perimetro della fabbrica e la misura della giornata lavorativa, può essere pensata all’altezza del suo concetto. Al centro dello scambio tra capitalista e operaio non sta il lavoro, ma la facoltà generica, ancora disapplicata, e tuttavia inerente alla natura umana, di lavorare, senza che in essa si possa distinguere la parte fisica dalla parte geistige, intellettuale e linguistica. È innestando Foucault su questo Marx che i termini biopotere e biopolitica entrano nel lessico e nella pratica politica dell’Italian Theory. Biopolitiche sono le resistenze coestese al rapporto sociale che il sistema dei biopoteri cerca di piegare ad un ordine della valorizzazione differente da quello fabbrichista. Potenza della vita contro potere sulla vita. C’è biopolitica laddove emerge in primo piano ciò che attiene alla dynamis, alla dimensione potenziale dell’esistenza umana; laddove affiora ciò che sfugge al computo e alla rendicontazione: non ciò che è stato detto, ma la facoltà di parlare, non il lavoro effettivamente erogato, ma la generica capacità di produrre, non il disciplinare che prescrive il ritmo di un gesto, ma la plasticità e l’indeterminazione che presiedono all’antropogenesi riproducendone la creatività (Virno, 86-88). Proprio ai dispositivi di produzione postfordisti è la messa a valore di quella Unfestgestelltheit che – da Nietzsche a Gehlen – caratterizza il vivente umano. Flessibile, organizzata sull’algoritmo del just in time, continuamente adattabile e non preformata o disciplinata, può essere solo una forza-lavoro la cui potenza di valorizzazione venga immediatamente sussunta al capitale senza che le funzioni di comando di quest’ultimo ne riconducano tempi e spazi di azione alla misura della giornata di lavoro. È la vita stessa – qui intesa come natura: capacità immediata di cooperazione, linguaggio, intelligenza – ciò che viene catturato dalla macchina estrattiva dei biopoteri. Esattamente come in Foucault, questa macchina lavora in profondità e in estensione sull’intera tessitura del rapporto sociale e modifica radicalmente i termini della composizione di classe. Spazio produttivo è ora la metropoli: nella fabbrica sociale complessiva si organizza la resistenza biopolitica – e cioè radicata su desideri e bisogni che eccedono il rapporto di salario – della moltitudine.
Credo sia principalmente sulla valorizzazione di questo stacco e di questa rottura tra regimi di accumulazione e tra le diverse forme di soggettività che ad essi corrispondono che prende l’avvio quel rinnovamento del pensiero e della pratica che solo molti anni dopo potrà essere etichettato come Italian Theory. Se il Radical thought si rinnova in Italia, è perché in Italia si è più disponibili, e lo si è per motivi politici, per il bisogno di rilanciare un processo di liberazione all’altezza delle nuove figure, cognitarie e precarie, della soggettività, a integrare al patrimonio teorico operaista analisi e impianti teorici che impattano problematicamente il presente e che lo assumono come campo di emersione ed organizzazione di nuove forme di antagonismo. È sulla base di un elogio dell’assenza di memoria che diventa possibile prendere congedo dal passato e guardare al presente per ciò che in esso anticipa il futuro. Nessuna continuità della tradizione: un pensiero è vivente solo se si mette alla caccia di quelle verità che, come diceva Deleuze, sempre di nuovo costringono a pensare.
 Dicevo all’inizio di questo intervento che oltre a Foucault e Deleuze sono stati Baudrillard e Lyotard, in questa fondativa congiuntura tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, a fornire indicazioni preziose. Lyotard definisce condizione postmoderna quella forma di vita in cui perdono vigenza le grandi Narrazioni e si rimodulano significato e funzioni del sapere. La logica culturale della società informazionale è postmoderna nella stessa misura in cui gli apparati di accumulazione che si dislocano sul sapere e sul linguaggio sono postindustriali. Qui, tuttavia, nel suffisso post– non si ammanta alcuna nostalgia dell’organico; ad esso non si lega alcun lamento sulla fine della storia o sul tramonto della possibilità. Si tratta di comprendere in che modo linguaggio e sapere assumono una funzione immediatamente produttiva. Tanto sul piano della produzione e della legittimazione delle decisioni nel quadro di tecnologie di governo che decentrano la propria operatività dal quadro classico della democrazia parlamentare, quanto sul piano di un’economia che mette a valore informazione e linguaggio. Vale forse la pena di ribadirlo una seconda volta: il postoperaismo non si interessa alla sfera della circolazione e della riproduzione del capitale che per mettere in evidenza, specie a partire dalla fine della convertibilità del dollaro in oro, il ruolo immediatamente produttivo assunto dal segno, dalla moneta, dalla finanza. Il passaggio al piano di immanenza che viene in questi termini ad essere circoscritto – la società postmoderna come esito della sussunzione reale, come inerenza di strutture e sovrastrutture, inerenza nella quale sempre più acquistano centralità razionalità sistemiche e funzionalismi giuridici e nella quale si consuma ogni residua autonomia del politico – rielabora anche in questo caso un tema marxiano. In questo caso, il Frammento sulle macchine dei Grundrisse (G, II, 401). In questo testo, Marx avanza la tesi che il sapere astratto – la nuova base dell’accumulazione: il sistema automatizzato di macchine creato dalla grande industria – diventa la principale forza produttiva, relegando ad una posizione limitata il lavoro parcellizzato e ripetitivo al quale sono costretti corpi e gesti. L’immagine che viene evocata per indicare l’insieme di conoscenze che vengono a costituire il centro della produzione sociale è general intellect: «lo sviluppo del capitale fisso mostra sino a che punto il sapere sociale generale, knowledge, è diventato forza produttiva immediata» (G, II, 403), come, cioè, esso ecceda la misura della giornata lavorativa e la legge del valore che vi è riferita. È la cooperazione sociale espressa in termini di sapere sociale complessivo a produrre direttamente valore. E questa tendenza spalanca la sproporzione tra il ruolo assunto dal sapere e la decrescente importanza del tempo di lavoro comandato. Marx vi prefigura, con la crisi della legge del valore, il superamento della forma capitalista dei rapporti sociali. Ebbene, il postfordismo realizza questa tendenza – quella che impone la centralità produttiva del sapere e della cooperazione – senza però che essa si accompagni ad alcun risultato emancipativo (Virno, 107). Questa contraddizione è quella su cui insistere. Da un lato il circuito linguistico-comunicativo su cui si accumula la potenza del sapere sociale; dall’altro – ed è questo un dato che è possibile ricavare dal rapporto sul postmoderno di Lyotard – la valorizzazione del sistema di inserzioni differenziate che fanno dell’individuo non un residuo irrilevante, ma un nodo di quella stessa circolazione. È in questa forma che Lyotard corregge le versioni più ingenuamente tecnocratiche della teoria dei sistemi: se il linguaggio acquista una irrinunciabile centralità nei dispositivi attraverso i quali il sistema si riproduce – e tanto più quanto questo ricava la propria legittimità in termini meramente operazionali e efficientisti nel vuoto lasciato dalle grandi Narrazioni – esso non può essere ridotto a un semplice codice binario di inputs ed outputs. Lyotard fa riferimento ad una pragmatica del linguaggio che valorizza performatività e agonismo dei giochi linguistici. Quello informazionale è un sistema mobile all’interno del quale le relazioni sono continuamente ridislocate: i nodi all’altezza dei quali si scambiano le informazioni impediscono di pensare quello postmoderno come uno spazio liscio e i giochi linguistici locali e specifici che ne assicurano la riproduzione sono ininterrottamente attraversati dall’innovazione.
Dicevo all’inizio di questo intervento che oltre a Foucault e Deleuze sono stati Baudrillard e Lyotard, in questa fondativa congiuntura tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, a fornire indicazioni preziose. Lyotard definisce condizione postmoderna quella forma di vita in cui perdono vigenza le grandi Narrazioni e si rimodulano significato e funzioni del sapere. La logica culturale della società informazionale è postmoderna nella stessa misura in cui gli apparati di accumulazione che si dislocano sul sapere e sul linguaggio sono postindustriali. Qui, tuttavia, nel suffisso post– non si ammanta alcuna nostalgia dell’organico; ad esso non si lega alcun lamento sulla fine della storia o sul tramonto della possibilità. Si tratta di comprendere in che modo linguaggio e sapere assumono una funzione immediatamente produttiva. Tanto sul piano della produzione e della legittimazione delle decisioni nel quadro di tecnologie di governo che decentrano la propria operatività dal quadro classico della democrazia parlamentare, quanto sul piano di un’economia che mette a valore informazione e linguaggio. Vale forse la pena di ribadirlo una seconda volta: il postoperaismo non si interessa alla sfera della circolazione e della riproduzione del capitale che per mettere in evidenza, specie a partire dalla fine della convertibilità del dollaro in oro, il ruolo immediatamente produttivo assunto dal segno, dalla moneta, dalla finanza. Il passaggio al piano di immanenza che viene in questi termini ad essere circoscritto – la società postmoderna come esito della sussunzione reale, come inerenza di strutture e sovrastrutture, inerenza nella quale sempre più acquistano centralità razionalità sistemiche e funzionalismi giuridici e nella quale si consuma ogni residua autonomia del politico – rielabora anche in questo caso un tema marxiano. In questo caso, il Frammento sulle macchine dei Grundrisse (G, II, 401). In questo testo, Marx avanza la tesi che il sapere astratto – la nuova base dell’accumulazione: il sistema automatizzato di macchine creato dalla grande industria – diventa la principale forza produttiva, relegando ad una posizione limitata il lavoro parcellizzato e ripetitivo al quale sono costretti corpi e gesti. L’immagine che viene evocata per indicare l’insieme di conoscenze che vengono a costituire il centro della produzione sociale è general intellect: «lo sviluppo del capitale fisso mostra sino a che punto il sapere sociale generale, knowledge, è diventato forza produttiva immediata» (G, II, 403), come, cioè, esso ecceda la misura della giornata lavorativa e la legge del valore che vi è riferita. È la cooperazione sociale espressa in termini di sapere sociale complessivo a produrre direttamente valore. E questa tendenza spalanca la sproporzione tra il ruolo assunto dal sapere e la decrescente importanza del tempo di lavoro comandato. Marx vi prefigura, con la crisi della legge del valore, il superamento della forma capitalista dei rapporti sociali. Ebbene, il postfordismo realizza questa tendenza – quella che impone la centralità produttiva del sapere e della cooperazione – senza però che essa si accompagni ad alcun risultato emancipativo (Virno, 107). Questa contraddizione è quella su cui insistere. Da un lato il circuito linguistico-comunicativo su cui si accumula la potenza del sapere sociale; dall’altro – ed è questo un dato che è possibile ricavare dal rapporto sul postmoderno di Lyotard – la valorizzazione del sistema di inserzioni differenziate che fanno dell’individuo non un residuo irrilevante, ma un nodo di quella stessa circolazione. È in questa forma che Lyotard corregge le versioni più ingenuamente tecnocratiche della teoria dei sistemi: se il linguaggio acquista una irrinunciabile centralità nei dispositivi attraverso i quali il sistema si riproduce – e tanto più quanto questo ricava la propria legittimità in termini meramente operazionali e efficientisti nel vuoto lasciato dalle grandi Narrazioni – esso non può essere ridotto a un semplice codice binario di inputs ed outputs. Lyotard fa riferimento ad una pragmatica del linguaggio che valorizza performatività e agonismo dei giochi linguistici. Quello informazionale è un sistema mobile all’interno del quale le relazioni sono continuamente ridislocate: i nodi all’altezza dei quali si scambiano le informazioni impediscono di pensare quello postmoderno come uno spazio liscio e i giochi linguistici locali e specifici che ne assicurano la riproduzione sono ininterrottamente attraversati dall’innovazione.
In un testo di questi stessi anni – La philosophie analytique de la politique (1978) – Michel Foucault riconduce ai termini del secondo Wittgenstein la propria analitica del potere: il potere non è una cosa, non ha un’origine né un fuori e deve essere pensato come una pura istanza di circolazione. Di esso, come del linguaggio, è solo possibile dire che esso ci sia. Ciò che ne rivela i fuochi applicativi, evidenziandoli come può farlo un reagente chimico, sono solo le resistenze che li percorrono. In maniera non troppo dissimile, la lettura che il postoperaismo produce di Lyotard valorizza quanto egli dice circa gli elementi di dissonanza e di dissenso che si distribuiscono sul piano di immanenza del sapere producendo le combinazioni pragmatiche che lo tengono in tensione e disturbandone la tendenza ad un equilibrio (o a una separazione) comunque impossibile. Ciò che caratterizza infatti il lavoro vivo postfordista è il fatto che esso è depositario di competenze (linguistiche e comunicative) non oggettivabili nel sistema di macchine. Un’evidente contraddizione attraversa perciò lo scenario della sussunzione reale. General intellect è la potenza sociale del lavoro vivo, la cooperazione comunicativa ed immediatamente interattiva delle intelligenze, non il sistema delle macchine. E tuttavia la destrutturazione del sistema fordista di accumulazione, quella destrutturazione che estingue progressivamente la centralità dello Stato come monopolista della decisione e della coercizione, come istituzione di Welfare, come agente di pianificazione economica, quella destrutturazione attraverso la quale si impiantano le logiche di governance sistemica, non comporta alcuna fuoriuscita dalla società del salario. Al contrario, un sistema di biopoteri si innesta su quella cooperazione per captarne ininterrottamente l’innovatività.
Lyotard, lettore di Luhnmann, coglie esattamente questo passaggio quando fa notare come il sistema non possa non funzionare che riducendo la complessità ambientale e cioè suscitando l’adattamento delle aspettative individuali alla propria riproduzione. La governamentalizzazione neoliberale del potere persegue un fine analogo: essa non crea le condizioni perché libertà, che già c’è, ci sia, ma, per mezzo dell’esercizio che le singolarità ne faranno, essa individua lo spazio economico in ogni soggetto governando, contemporaneamente, i rischi che questo stesso esercizio comporta per la riproduzione e per l’allargamento del mercato. La macchina di governo neoliberale riesce di nuovo ad uniformare le disposizioni soggettive alle condizioni di una produzione che si fa eminentemente simbolica, linguistica, comunicativa. Di qui, per quanto attiene ad uno soltanto dei lati della questione, il lavoro del pensiero radicale italiano sul «lato oscuro» – e cioè: funzionale al comando – della moltitudine: la flessibilità cognitiva tradotta in opportunismo, l’adattabilità che pertiene alla Unfestgestelltheit della natura umana volta in cinismo. Dall’altro, la possibilità di immaginare una biopolitica del desiderio e dell’autonomia: la moltitudine come soggetto di un esodo felice dalla società del lavoro trainato dalla dynamis costituente del suo general intellect.
Poco sopra rivendicavo un terzo apporto “straniero” per il pensiero radicale italiano. Un pensiero radicale, ormai lo si sarà capito, che io vedo in formazione in una particolare temperie, quella della fine degli anni ’70, proprio perché capace di evadere dalla gabbia della discussione italiana e di recepire attivamente, trasformandoli, i discorsi che fanno cicolare il pensiero radicale. Dopo Foucault e Lyotard, mi riferisco ora a Jean Baudrillard. In che modo, in quella che mi sforzo di costruire come una genealogia «materialista» e non storico-filosofica dell’Italian Theory, Baudrillard impatta, per essere recepito al suo interno, il processo teorico e politico del postoperaismo? Nelle prime pagine de L’échange symbolique et la mort (1976) Baudrillard mette a tema la «disarticolazione» delle funzioni di valore. Delle due dimensioni dello scambio del segno-valore – l’esempio di Baurdillard è tratto dalla linguistica di Saussure – il primo lo ancora ad un bene, il secondo a tutti gli altri segni che circolano all’interno del sistema. Vi è un aspetto per il quale è assunta come centrale la relazione di ogni significante con il suo significato, così come di ogni moneta con ciò che se ne può ottenere in cambio; per un altro aspetto, articolato al primo, invece, significanti (e valori monetari) vengono avvalorati da ciò che li differenzia ed oppone a tutti gli altri. Moneta e termini della langue sono soggetti ad un’unica «economia». Baudrillard parla apertamente di una «rivoluzione che ha messo fine a questa economia classica del valore». I due aspetti di cui parlavo vengono ora apertamente sconnessi e disarticolati. Il valore di referenza viene annullato a favore della relatività totale, della commutazione generale, della pura combinatoria dei segni. Il segno viene emancipato. Esso si svincola dal riferimento al reale, dall’esigenza di significare qualcosa: un’indeterminazione radicale subentra alla vecchia regola di equivalenza determinata. Ciò che si sostituisce alla legge del valore – ed è evidente come questo passaggio recepisca l’abbandono del gold standard che innesca la rivoluzione monetarista – è la pura indeterminatezza del codice: un’«economia politica del segno» prende il posto della teoria del valore-rappresentazione. Un altro modo per dire il postmoderno è la sovranità dell’indeterminazione: la ex-termination (Baudrillard) del reale, qui intesa e nominata come «s-terminazione» dei reali di produzione, del reale di significazione. Fine del lavoro. Fine della produzione. Fine dell’economia politica. E ancora: fine della dialettica valore di scambio / valore d’uso. Si ferma qui Baudrillard? No, ovviamente. La fine della produzione fordista e l’esaurirsi della teoria classica del valore-lavoro non segnano la fine della storia. Al contrario, se nel sistema mobile della circolazione della merce e del denaro viene definitivamente meno la distinzione tra lavoro produttivo e lavoro improduttivo, tra struttura e sovrastruttura, tra valore d’uso e valore di scambio, la situazione che viene determinandosi è una situazione in cui tutto lo spazio della circolazione (informazione, moneta, finanza) si ridetermina come immediatamente produttivo. Ciò che viene infatti messo a valore – e in più: senza la necessità di un comando o di una funzione di organizzazione esterna al piano di immanenza sul quale circolano i segni – è il puro operare della mobilità e dei flussi. Interscambiabilità indeterminata delle posizioni, sfumare della differenza tra tempo di vita e tempo di lavoro, impossibilità di una misura del valore ancorata a qualcosa che non sia il rinvio, privo di riscontro reale, al sistema generale dei segni e alla contingente variabilità del loro posizionamento reciproco. Se il reale della fabbrica scompare, è perché l’intera società «assume le sembianze della fabbrica». Bisogna che la fabbrica scompaia in quanto tale, che il lavoro operaio perda la sua specificità e i suoi luoghi, «perché il capitale possa assicurare questa metamorfosi estensiva della sua forma alla società totale» (Baudrillard, 31). Ciò che il pensiero radicale italiano desume da questa posizione – una posizione ancora pertinente, per certi aspetti, per assumere come tratto distintivo della fase globale del capitale la sua finanziarizzazione e per svuotare di senso le retoriche socialiste che al capitale di borsa oppongono una pretesa «economia reale» alla quale ancorare le politiche di occupazione – è la pura mistificazione che si cela nella forma del salario. Finito il lavoro, per Baudrillard, il salario muta di funzione e di significato: tutt’al più esso abilita, con una funzione simbolica, ad uno «statuto». Il lavoratore come interno al circuito non della produzione e dello sfruttamento, ma a quello della merce; il salariato come consumatore. E ancora: come prestatore di servizi in un circuito fatto di erogazione di servizi e di utenze. Con la perdita del referente-produzione è l’intero piano della circolazione che diventa, in senso differente, «produttivo». Producono le relazioni, produce la mobilità, producono le informazioni, produce – e non è affatto paradossale che sia così… – il consumo. È soprattutto sulla crisi della legge del valore, a questo proposito, che si concentra l’analisi postoperaista. Portare ad esaurimento la legge del valore-tempo di lavoro – una crisi della misura del salario che l’Italian Theory legge come risposta alla centralità che il general intellect, la cooperazione moltitudinaria del lavoro vivo, viene acquisendo nel sistema di economia della conoscenza che succede al macchinismo fordista – significa di fatto almeno due cose: l’esaurimento della forza progressiva del capitale e il suo assumere un carattere sempre più evidentemente parassitario. La formula «farsi rendita del profitto» che viene forgiata per descrivere questo processo viene adoperata per alludere a dispositivi di cattura del valore del tutto esterni all’organizzazione della produzione e al puro estrattivismo del capitale finanziario. La rottura della legge del valore, infatti, ha almeno una seconda conseguenza di rilevo: con essa viene meno il rapporto sociale che fa della logica della merce il principio progressivo della produzione dei valori d’uso e della soddisfazione dei bisogni. Questa rottura comporta la rottura della positività della relazione tra valore e ricchezza. Ne deriva una conseguenza ulteriore. Se il principio della proprietà capitalistica permane, così come permane la logica della valorizzazione in termini di scambio, questa sempre di più tende a fondarsi sulla creazione artificiale della scarsità delle risorse e/o sulla distruzione di risorse (comuni) non rinnovabili (Vercellone, 76). Chiamare «estrattivismo» questo principio di valorizzazione significa tenere assieme i due lati dell’operatività del capitale finanziario: da un lato il suo investirsi e scommettere su beni in via di esaurimento (si tratti dei combustibili fossili, dell’acqua o dei terreni adatti alla coltivazione), dall’altro il suo ricavare parassitariamente una rendita dalla scarsità prodotta (ad esempio con brevetti e copyrights) sull’altrimenti incrementale massa di beni e servizi prodotti dalla libera cooperazione della moltitudine. Di questa trasformazione parla l’uso postoperaista del termine biopotere…
Proprio del pensiero radicale italiano è lo sforzo di pensare al’altezza di questi processi una nuova teoria del soggetto. È questa l’ultima cosa sulla quale mi intrattengo. Quella che la retorica mainstream ha potuto leggere come «fine della società» del lavoro, viene invece trattata come tempo della moltiplicazione delle figure del lavoro vivo. Nel momento in cui la teoria politica e sociale non vede più il lavoro, il lavoro – il general intellect che coordina i flussi di informazioni, organizza la rete, incorpora al singolo sezioni fondamentali di capitale fisso, quella cooperazione che pulsa di gradienti e di intensità di potenza – diventa la comune sostanza. Di qui l’evocazione dell’ultimo autore dei quattro che l’Italian theory incorpora al proprio ordine del discorso all’ingresso negli anni ’90: Deleuze. O meglio, la macchina di pensiero Deleuze-Guattari. Vale forse la pena di ribadirlo un’ultima volta. Non vi è nessuna concessione al vitalismo nella biopolitica postoperaista. È di nuovo il frammento sul General intellect dei Grundrisse il testo che evoca la figura politica del comune e della democrazia diretta come formula politica assoluta. Qui, il General intellect non è il sapere astratto che si rapprende nel sistema di macchine: esso corrisponde piuttosto alla composizione di classe potenziale di un lavoro vivo che fa della libera cooperazione il rovescio della pura parassitarietà del comando; un comando che si dimostra del tutto innecessario perché incapace di organizzarla e attivo solo nel catturare il valore che viene da questa prodotto nei circuiti informazionali, affettivi e linguistici.
È un’inaudita verità quella che sta alla base del discorso sul comune: il lavoro vivo si organizza indipendentemente dall’organizzazione capitalistica del lavoro (Dioniso, 103). E non solo. Al di fuori di ogni dialettica, e tuttavia ancora con Marx, ciò che deve essere assunto è il processo di costruzione della soggettività come costante ibridazione tra il soggetto e la macchina. Il soggetto non scompare e non scompare la storia nel farsi-mondo del capitale. Al contrario è esattamente all’altezza della sussunzione reale, che la soggettività, intesa al di fuori di qualsiasi naturalismo, di qualsiasi metafisica della riflessione, intesa piuttosto come motore di trasformazione per mezzo del lavoro e come indice della potenza dell’essere, si impone come riapertura e risignificazione del problema della liberazione. Ciò che il pensiero radicale italiano riprende da Deleuze e Guattari è esattamente il tema della soggettivazione come composizione di molteplicità, agencement, macchina da guerra. Si tratta di pensare e di organizzare il divenire che il discorso postmodernista sulla fine della storia relega al piano di sviluppo del capitale. Quanto più l’assiomatica della valorizzazione irretisce il mondo nelle strategie della finanza globale, tanto più si tratta di pensare il soggetto come attraversamento di confini, come gradiente di intensità. All’universalizzarsi del capitale corrispondono pratiche di universalità e composizioni di potenza. È un’universalità intensiva, quella alla quale si riferiscono Deleuze e Guattari: un’universalità che non si riferisce ad interessi o a identità comuni (tantomeno quelli di classe, cui si sono tradizionalmente riferite, invece, le teorie socialiste della transizione), ma a processi di co-trasformazione immanente (Sibertin Blanc) che segnano tanto il divenire della singolarità – «un dégré, une individu est un individu, Heccéité, qui se compose avec d’autres intensités pour former un autre individu» (MP, 310) -, quanto il divenire degli agencements che inventano – «un agencement (…) est une véritable invention» (MP, 506) – le macchine desideranti che le com-pongano.
Divenire non significa approdare a un divenuto. Ciò che Deleuze e Guattari chiamano il divenire-animale, non implica né progresso né regresso su di alcuna serie evolutiva. Significa, piuttosto, immergersi nel nodo di intensità, gradienti ed affetti che introduce alla singolarità della posizione. E cioè all’ordine del multiplo e dell’alleanza (MP, 291). L’impiego che il pensiero radicale italiano ha fatto del termine moltitudine – il molteplice puro che si sottrae all’unità rappresentativa del popolo o della classe – ha cercato di tradurre questa stessa intensionalità. Il termine moltitudine è un termine composizionista. Esso designa un soggetto sociale attivo nel piano di immanenza che gli corrisponde e che agisce sulla base di ciò che le singolarità hanno in comune (M, 124). Con comune si intende qui tanto il presupposto (la cooperazione del General intellect cognitario), quanto l’effetto (il valore che viene prodotto) della produzione immateriale. E cioè: l’autovalorizzazione del lavoro vivo una volta che alla dynamis che ad esso inerisce non corrisponda più né un comando, né una misura. Quello di moltitudine è un concetto di classe, sì. Ma è un concetto stipulativo, non identitario – perché ricavato da un processo costituente e dall’ibridazione – e adattato alla forma pura del divenire come incessante dinamica tras-formativa. Biopolitica, per il pensiero radicale in Italia, è questa tensione: la costante sottrazione del subiectum al subiectus, che diventa possibilità concreta con la fine della società del lavoro e con l’agencement macchinico dei desideri. Cyborgs, mute postumane, ibridi postgenomici, stanno alla base dell’Italian theory, non nature, tantomeno umane. Nessun vitalismo, quindi. Una materialissima immanenza, piuttosto. Ed è su questo che vorrei aggiungere un’ultima parola.
Ho detto all’inizio di questo intervento che solo in maniera molto debole, da storici (o da contabili) della filosofia, è possibile parlare di una teoria italiana. Tutto ciò che ho provato a dire parla del modo nel quale, tra la fine degli anni ’70 e la prima metà degli anni ’90, al seguito delle lotte e del problema della loro organizzazione, sono stati acclimatati in Italia, producendo effetti positivi di ibridazione, percorsi del pensiero francese contemporaneo. Credo si possa dire che così come è importante assegnare la giusta rilevanza a questa genealogia (Nietzsche, Foucault, Deleuze, per dirla con una serie; Machiavelli, Spinoza, Marx, per dirla con un’altra..), è altrettanto importante sottolineare gli aspetti di disseminazione attivamente e concretamente perseguiti dal pensiero radicale italiano. Non per proselitismo, ovviamente, ma perché la funzione di una macchina da guerra è quella di essere disassemblata e riassemblata ovunque essa possa servire. Un intero seminario sarebbe necessario per ricostruire i percorsi di soggettivazione politica attivati a livello globale da questo oltremarxismo. E per ragionare su come questo stesso oltremarxismo, che pensa il soggetto come attraversamento di confini, venga continuamente riattraversato dagli effetti di verità che gli sono riconsegnati dalla traduzione nei molti dialetti che lo declinano. Ma questa è un’altra storia. Che non coincide – non direttamente, non solo, non principalmente – con convegni, numeri di riviste o traduzioni. Con la verità di ciò che viene, piuttosto.
Sul Povero Yorick: Note sullo stato della filosofia italiana:
Antonio Negri, → A proposito di Italian Theory
Marco Assennato, → Giocare il gioco dell’Italian Theory?
Antonio Negri, → Vana ricerca del buon governo
Girolamo De Michele, → La pop filosofia spiegata a un accademico (e non solo a lui)
Girolamo De Michele, → Oltre l’accademia: le strade