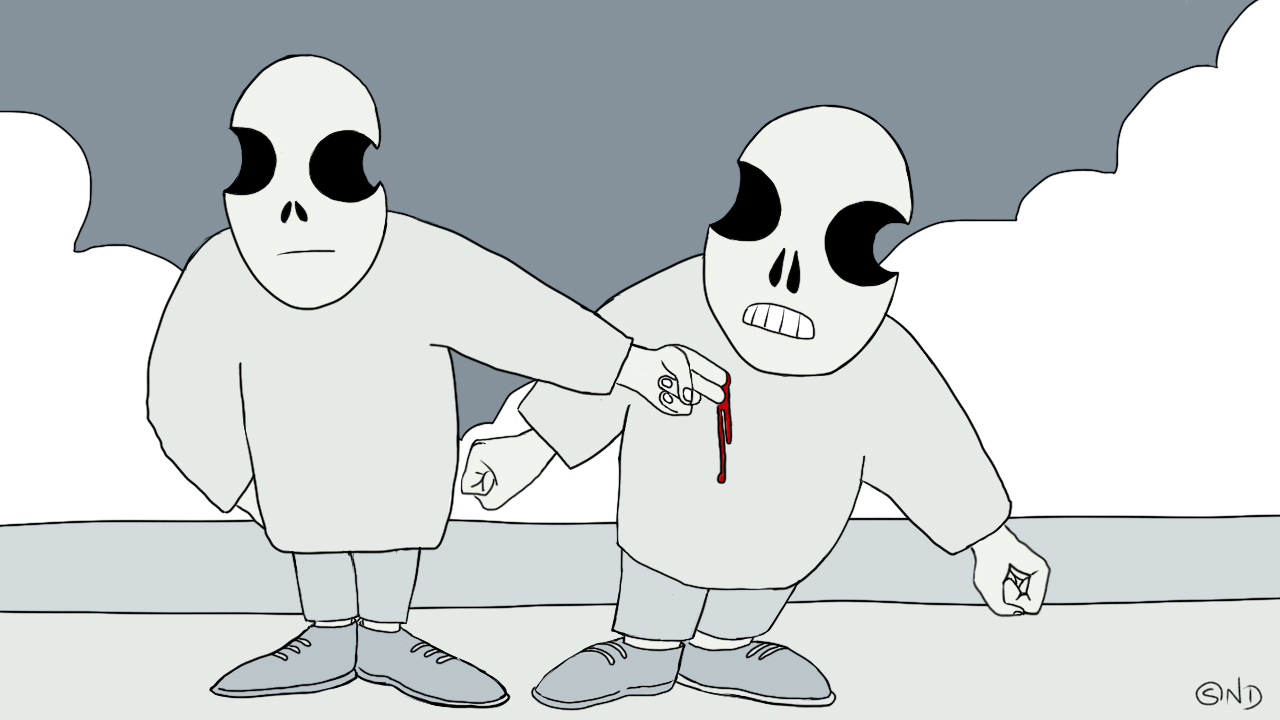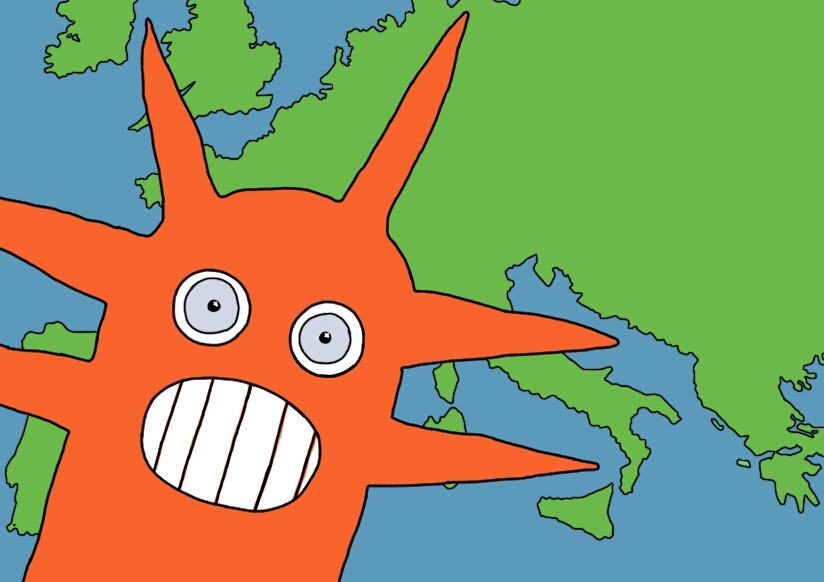di ILARIA BUSSONI.
Cara J.,
grazie molto per questa tua. Mentre venerdì sera ricevevo un messaggio che diceva «Hai visto?», e al quale rispondevo con Pas de mots, pensavo: ma come Chez nous? in quel quartiere che tutti conosciamo bene, dove si incontrano i compagni e si vedono i collettivi, e abitano gli studenti in gran parte italiani che vanno a Paris VIII, quando a Saint-Denis non c’è ancora la fermata per l’università, per seguire Toni o Rancière? Aboulevard Voltaire, con i drappelli di gente ferma ad aspettare un passaggio che arriva da lì a poco in un inverno gelido ma non così tanto del ’95 e una sfera pubblica che si allarga a dismisura durante gli scioperi? E si va a bere un caffè che costa 6 franchi, ci si può stare e dura ore, tanto nei bar si può ancora fumare? Non mi sentivo così immonda, quando al Bataclan suonavano i Blur, Street’s like a jungle / So call the police / Love in the 90’s / Is paranoid, e probabile che tra il pubblico c’era qualche casseur.
Non si era scritto che nelle lotte degli studenti e dei precari (già si chiamavano così) contro il Contratto di Inserimento Professionale del ’93, che discriminava, precarizzava, svalutava, impoveriva la formazione e non solo, si dava il possibile di un’alleanza con la banlieue (che già esisteva) e che quella rompeva la cintura del colore del périphérique? Era solo un esorcismo, per forzare in una formula un conto che sembrava già non tornare? Comunque no, non avrei pensato all’epoca di poter diventare un nemico (di classe?).
Oggi che abito in una periferia romana che a breve sarà gentry, dipenderà dalla crisi e dai sindaci di Roma, dove il gommista mi aiuta a cambiare le ruote che mi hanno appena bucato al centro e me lo fa gratis perché sto nell’appartamento che era del boss della mala degli anni ’70, ancora gode di simpatia e quell’aura ti aiuta a cambiare le gomme, oggi mi chiedo se la mia posizione, nel rimettermi dalle parti dell’XI, sia la stessa di allora. Volontariamente, credo di non essermi spostata, ma c’è qualcuno che pensa il contrario. Vent’anni dopo, rimasta in Francia, avrei forse un lavoro più pagato, qualche paillette culturale da meglio piazzare nelle reti sociali, delle garanzie sociali in più, non è detto una casa più bella perché in questo qui sono stata fortunata, lavorerei di meno, forse avrei dei bambini. Continuerei ad abitare i dintorni dell’XI, come tanti amici e compagni fanno tutt’ora. Mi chiedo se sarei parte della vague bio che persino a Parigi fa pomodori in terrazzo, rimedia oggetti dai cassonetti e ne fa pezzi di arredo, frequenta i concerti, ascolta vinili e legge libri che non sono solo immondizia, si incontra per strada perché le case continuano a essere troppo piccole per una socialità decente. Perché no? Piccoli aggiustamenti delle latitudini del bacino metropolitano del lavoro precario e cognitivo e lì potrei stare. Con tutta l’ambivalenza delle forme vita contemporanee nell’epoca dell’anima al lavoro, con un capitale umano del cui valore sarei più o meno convinta, un ambiente nel quale non poter non stare se voglio vivere lavorando, cercando come tutti (e per qualcuno in assenza di meglio) gli strumenti per salvarmi da sola. Esattamente quel che faccio qui. Ma a mettermi oggi da quelle parti dell’XI, forse sentirei più forte una frattura interna, soggettiva, capace di farmi facilmente basculare verso un’inclinazione dell’opportunismo e del cinismo delle occasioni, i sentimenti dell’aldiquà che accompagnavano la fuoriuscita dalla società del lavoro fordista e come si era capito non andavano senza paura. Mi chiedo se non sentirei meglio qualcosa che non mi è estranea nemmeno qui, dove i confini sono più sfumati e le nostre forme di vita hanno talvolta ancora i tratti dell’esperienza collettiva e non solo quelli del segmento di mercato, qualcosa dell’ordine di una frattura interna, di una linea non ben definita piazzata sulle condotte, l’ethos, il modo di stare al mondo, che mi spingerebbe a chiedermi: da che parte sto, di qua o di là del périphérique? La sociologia risponderebbe, probabile con mia costernazione, al di qua.
Dov’è finita quell’alleanza tra quelli di dentro e quelli di fuori, che talvolta si è intravista nelle lotte francesi degli anni ’90, e non solo perché ci aiutassero a spaccare vetrine, della cui urgenza sapevamo già prima dell’uscita del film di Kassovitz? L’altro giorno al bar, Sergio mi faceva notare l’ironia di aver tradotto il libro di Mark Levine dal titolo Perché non ci odiano, un attacco ad Huntington e allo scontro di civiltà, di un autore che oltre a insegnare a Irvine è pure un gran chitarrista e l’altra sera poteva suonare al Bataclan. “Pensa se ci odiavano che cosa non combinavano?”: mi ha detto. E infatti ci penso a quell’odio, a cosa è diretto perché di sicuro non è un fatto così personale, e mi chiedo se a mia volta quella parte di me che non sempre so bene dove sta, che anche per esperienza sappiamo governata col debito o disciplinata col salario, oggetto di ricatto o di lusinghe, se quella parte non la odi un po’ anch’io. Se non sia proprio quella banlieue interna, tra il me individuato e le pratiche del comune, le facoltà di tutti e i loro usi privati, che mi pare di odiare. Quella scissione che non riusciamo a sanare. Ho lasciato Parigi quando qualcuno me l’ha fatto notare e mi ha spinto dall’altra parte: era un ragazzino che mi sparava addosso ad aria compressa dal quai di un canale della Senna in banlieue Nord, mentre giravamo il film di Francesca, Addio Lugano Bella, la storia di una canzone anarchica e di qualche rifugiato italiano a Parigi; insieme a una rissa scoppiata in una cité, coi sans papiers che occupavano un locale e un gruppo di banlieuesards venuti a lanciargli molotov. E mi sono ritrovata a chiedermi, da che parte sto? E da che parte mi hanno messo?
Di sicuro non sto in quella della corporazione dei vittimari. Oggi una schiera folta che tiene insieme le donne che per l’8 marzo festeggiano la violenza su di loro o una certa piega introspettiva e colpevolizzante che legge la durezza del dover vivere alle condizioni del lavoro contemporaneo con il fallimento di sé da curare con le risorse del comportamentismo. Non con quel complesso di discorsi che danno alla vittima una posizione di parola non sconfessabile, fuori da qualunque critica perché il suo patema è tale da essere immune da ogni responsabilità. Non con quelle funzioni simboliche, retoriche, materiali anche, che danno alla vittima uno statuto indiscutibile a partire non da ciò che ha fatto, dalla sua prassi, ma da ciò che ha subito, ciò che le è stato levato (come ci ha mostrato Daniele Giglioli nel suo libro). Niente di più lontano dalla prefica di cui parlava Deleuze e la sua arte del lamento, che non crea sodalizio e non chiede adesioni, solo di essere lasciata in pace, e che si ribalta in una strategia per nascondere la gioia. Strada comunque pericolosa che portava Deleuze a chiedersi: “Non rischio di lasciarci la pelle?”
Alla stregua del filosofo, mi verrebbe da dire che oggi assistiamo a un divenire vittima. Non ci si ritrova a incarnarla per caso, è una posizione alla cui costruzione in molti partecipano, una casella vuota così ben strutturata nella quale si fa poi a gara a infilarcisi alla prima occasione, tanto nelle strutture affettive private (ma sono poi private?) affatto immuni dal ricatto quanto in quelle pubbliche in cui da vittima viene più comodo esercitare un potere. Astuto travestimento del discorso del padrone, l’aveva detto anche Lacan.
Stasera al Palladium vado a vedere uno degli ultimi Straub, Kommunisten, che comincia con un verso di Eisler, «Tutto il mondo anela alla pace», e non ha niente di irenico. È la ricerca di un riscatto, comune, collettivo, comunista, non solo del presente lacerato ma anche del passato. Un amico tennista mi faceva notare che in relazione al presente e forse pure al futuro si può trovare il modo di salvarsi anche da soli. Ma solo un collettivo, un soggetto storico che è insieme anche i soggetti che l’hanno preceduto, salva e riscatta i possibili che non sono stati, insieme alle loro vite. Non so se Daesh la pensi uguale in merito. Sarebbe tempo per noi di ripensare al riscatto di alleanze possibili appena intraviste. Questo lo si può fare solo col collettivo. Riguarderò Kommunisten, che nella sua forma estetica mi ricorderà da che parte sto, in attesa di trovarne anche la forma politica. Stasera sono abbastanza certa di uscirne viva, ma se così non fosse mi chiedo “Sarò morta combattendo?”