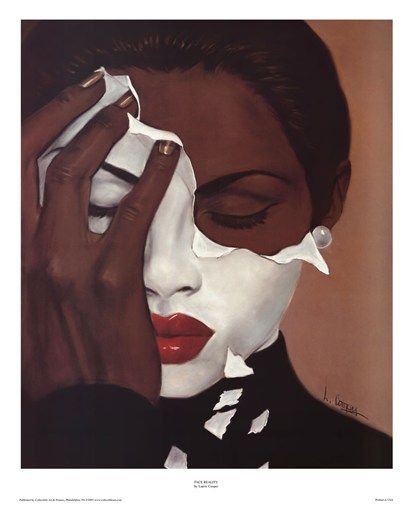di FEDERICO TOMASELLO. [Español] [Português]
(Domanda). Ormai diversi anni fa, alcuni tuoi scritti riguardanti l’oggetto di questa intervista sono stati raccolti in un testo il cui titolo, Dalla fabbrica alla metropoli, rimanda all’adagio secondo cui la metropoli sta alla moltitudine come, una volta, la fabbrica stava alla classe operaia. Vorrei oggi parlare con te di cosa le trasformazioni, i movimenti e la crisi globale di questi anni ci dicono rispetto all’analisi della metropoli intesa come griglia analitica attraverso cui è possibile rileggere e interpretare molte categorie di lettura del presente. Recentemente – in particolare nell’intervento Per la costruzione di coalizioni moltitudinarie in Europa – hai fatto cenno all’esigenza di sottoporre a verifica critica alcune categorie consolidate dell’esperienza post-operaista: vorrei chiederti anzitutto se ritieni che anche questo schema di lettura del rapporto fra metropoli e moltitudine debba essere sottoposto a verifica e aggiornamento.
(Risposta). Ci troviamo oggi di fronte a una situazione completamente aperta per quanto riguarda la metropoli: per questo credo che il discorso vada sottoposto a verifica, ma continuerei comunque a insistere sul tema metropoli-fabbrica, pur senza interpretarlo in modo lineare. Evidentemente la metropoli è qualcosa di radicalmente diverso dalla fabbrica, è un luogo di produzione che va analizzato in tutta la sua specificità, ma è altrettanto vero che essa è il luogo di produzione per eccellenza. In secondo luogo: l’insieme degli abitanti della città, la moltitudine cittadina, metropolitana, è da considerare come la classe operaia in fabbrica? Anche qui evidentemente il discorso va allargato, semplificato, strappato alle categorie iniziali, ma non è una metafora affermare che la metropoli è oggi per la moltitudine ciò che una volta la fabbrica era per la classe operaia. Si deve insistere su questo elemento: non è una metafora perché un rapporto esiste, avviene, anche se non è più semplicemente di sfruttamento com’era nel rapporto di fabbrica. Sono molto spaventato da quelle sociologie che oggi, mascherandosi dietro il feticcio della “spazialità”, percorrono la metropoli esclusivamente nel segno delle differenze e delle separazioni, laddove, invece, dietro queste diversità c’è un meccanismo di sfruttamento che agisce in maniera assolutamente solida, e si chiama “meccanismo estrattivo”. Se noi assumiamo la traiettoria fabbrica-metropoli, classe-moltitudine ci troviamo allora di fronte a una situazione non-metaforica che deve però essere interpretata attraverso nuove categorie dello sfruttamento, ed in particolare di quello sfruttamento che si oggi si chiama estrazione, sfruttamento estrattivo, o meglio rapporto di dominazione estrattiva.
È su questo tema dell’estrattivismo che si deve insistere, pur senza mai dimenticare che il tessuto sociologico della metropoli è qualcosa che non può essere identificato con la fabbrica. Prima di tutto perché la divisione del lavoro non è immediatamente funzionale, non è disciplinare e, al limite, non è neppure di controllo. Secondariamente perché siamo in una diversa fase di sviluppo dello sfruttamento capitalistico, quella che Carlo Vercellone – a proposito del rapporto fra capitale cognitivo e lavoro cognitivo – non chiama già più post-industriale, ma decisamente informatica. Una fase che ormai comincia a trovare il suo equilibrio, e in cui il rapporto di sfruttamento – nella attuale figura estrattiva – diventa assai difficile da definire, perché in quest’ambito c’è sicuramente confusione ed ibridazione di capitale fisso e lavoro vivo, forse riappropriazione di capitale fisso da parte dei soggetti stessi, e c’è un’emergenza di cooperazione sociale che probabilmente deve essere considerata come un dispositivo di autonomia.
Hai parlato del meccanismo estrattivo e, di lì, sei giunto a nominare il tema della cooperazione, e poi quello dell’autonomia: una traiettoria che rinvia al portato e ai significati strutturalmente ambivalenti del concetto di metropoli, che rimanda sempre a un duplice ordine di questioni. Da una parte ai nuovi regimi di controllo sociale, ai meccanismi di cattura del valore socialmente prodotto, all’espropriazione intensiva della forza lavoro e della cooperazione sociale urbana, alla rendita, alle speculazioni immobiliari, al moltiplicarsi delle frontiere interne allo spazio metropolitano. Dall’altra parte c’è la metropoli come – cito Commonwealth – «corpo inorganico della moltitudine», territorio di produzione di soggettività e forme di vita, spazialità specifica di inediti processi di soggettivazione, o, per dirlo con le tue parole, «millefoglie istituzionale che raccoglie l’insieme delle passioni che generano il comune». Come ritieni che debba essere posta e analizzata la relazione reciproca fra questi due versanti della nozione di metropoli? Lavorando a valorizzare gli elementi di relativa autonomia reciproca, oppure a evidenziarne le costanti interazioni? Quali sono insomma le coordinate fondamentali per un lavoro di indagine del tessuto metropolitano dal punto di vista della costruzione del comune?
Io credo che l’economia della metropoli sia fondamentalmente unitaria. Sia l’elemento dell’autonomia, sia quello dello sfruttamento estrattivo devono evidentemente essere considerati entrambi nella loro consistenza propria, nell’intensità del loro darsi. Ma si deve assumere la centralità della loro relazione reciproca. E così torniamo all’assunto, non metaforico, della metropoli che sta alla moltitudine come una volta la fabbrica alla classe operaia, perché quello di capitale è sempre un concetto duplice: c’è che sfrutta e chi è sfruttato, chi comanda e chi resiste. Il problema diviene allora quello di combinare una definizione intensiva dei soggetti che sono in gioco con questa dimensione del rapporto che è una dimensione di continua ridefinizione alternativa dei soggetti stessi – io definisco te, tu definisci me, e così all’infinito. È in questo gioco che si determinano le qualità dei soggetti – con tutti gli sviluppi antropologici che se ne devono trarre – e l’intensità delle forze in campo. Dobbiamo saper vedere questo rapporto come un tessuto, fluido ma estremamente forte, di onde, di contraccolpi ondosi, come se fossero veramente due grandi masse che si scontrano.
Evidentemente poi muovere da questo livello, che pure è reale, all’analisi “micro” è un compito complesso. È il passaggio dalla sociologia – pur sociologia marxista, che assume cioè non il feticismo dell’oggetto, ma la definizione del soggetto come elemento dinamico – alla politica come fisica operativa delle passioni, che sola può condurre sul terreno “micro”. È questo il vero “alquatismo”: non si tratta di banale conricerca, ma della capacità di definire e far funzionare la ricerca come macchina operativa di costruzione di passioni collettive (un po’ quel metodo che troviamo in Machiavelli, Spinoza, nel Marx storico, e oggi in Foucault, oppure, diversamente, nel tentativo deleuzian-guattariano dei Mille plateaux, che pure sconta, da un lato, il limite di un’eccessiva astrazione dalla realtà, e, dall’altro, di una scarsa attenzione alla realtà di classe).
Hai fatto cenno agli “sviluppi antropologici” che si devono trarre dall’analisi dei mutamenti del tessuto metropolitano e dei processi di accumulazione, e poi sei venuto sul terreno del metodo che consente di fare del pensiero e della ricerca un arnese di intervento sul presente. Ecco, vorrei chiederti se ritieni che nella metropoli contemporanea sia possibile rintracciare condizioni che alludono anche a una nuova dimensione antropologica del politico, e attraverso quale postura credi che esse debbano essere indagate.
Anche la tematica antropologica deve essere presa da un duplice versante. Da una parte c’è la questione che potremmo chiamare della “forma mentale dell’antropologia post-industriale”, ovvero della riacquisizione di “capitale fisso” da parte del soggetto, di questa parte meccanica di cui l’uomo si riappropria, e di cui toglie il comando esclusivo al capitale. L’elemento importante da considerare, qui, è che ormai il comando capitalista non opera più semplicemente una sorta di iniezione di elementi tecnologici nel corpo umano, ma ha ora a che fare in maniera altrettanto importante con una capacità di riappropriazione e di trasformazione autonoma degli elementi macchinici in strutture dell’umano. Oggi quando si parla di “passioni sociali” si deve parlare di passioni legate al consumo passivo di tecnologie ma anche e soprattutto di consumo attivo. Questa tematica deve assolutamente essere strappata – come ha dovuto esserlo nel caso dell’operaio industriale – al moralismo e alla stupidità di un’antropologia dell’uomo puro, dell’uomo nudo. L’uomo non è mai puro, il lavoratore non è mai ignudo – queste figure son sempre vestite e sporche – ma è il modo in cui si vestono ed operano che ci offre la sola loro realtà, e questo vale anche per la definizione dell’orizzonte dei bisogni e della povertà. È chiaro che la povertà oggi è qualcosa di completamente differente da quello che era un secolo fa: oggi, quando si parla di povertà, ci si riferisce piuttosto agli strumenti di comunicazione, alla capacità o meno di integrazione sociale su livelli cooperativi, certamente non definendo la povertà solo da un punto di vista alimentare o abitativo.
E poi, dall’altra parte si deve cogliere nella metropoli una ricca consistenza antropologica come livello sul quale si sviluppa interamente l’autonomia dei soggetti, e che è legata a tendenze, a comportamenti che sono generali o generativi, cioè comuni. Questo elemento di comunanza (passiva o attiva che sia) si dà fondamentalmente nella metropoli ed è ciò che deve essere colto preliminarmente dalla ricerca. Poi ci sono mille differenze fra il centro e la periferia, mille livelli di singolarità, figure estremamente diverse che rendono ormai impossibile nella metropoli non solo pianificazione e programmazione interne, ma la stessa topologia. Ora, è quella consistenza antropologica radicale che va ricostruita attraverso le sue discontinuità. Discontinuità dell’oggetto e del soggetto, che non significa tuttavia discontinuità o rottura di un metodo (quello della conricerca) che conserva ancor oggi valore euristico. Per esempio: un approccio antropologico deve riprendere, secondo me, nelle nuove condizioni di vita e di produzione della metropoli, di fronte al lavoratore cognitivo, quel metodo che considerava nell’operaio industriale congiunta una capacità di resistenza ed una forza di irradiazione generale delle forme di questa.
Hai citato il tema del consumo e quello della povertà, attardiamoci ancora su questi elementi. C’è chi, facendo ad esempio riferimento a segmenti dello spazio urbano occidentale segnati oggi da altissimi tassi di disoccupazione giovanile, rileva l’emergere di una condizione di ‘superfluità’, di nuove povertà caratterizzate da una radicale marginalità rispetto ai processi della produzione, dell’accumulazione e della valorizzazione, che hanno profondamente ridislocato i propri centri. Credi che queste prospettive possano descrivere efficacemente segmenti della città contemporanea?
È assolutamente vero che oggi il capitale non riesce a identificare in maniera univoca dentro la metropoli, dentro al luogo privilegiato della sua accumulazione e valorizzazione, i soggetti che sono ubicati sul livello produttivo, dell’accumulazione. Non riesce a identificarli, però riesce, malgrado tutto, a governarli, a “pastorizzarli”, a comandarli in termini pastorali, quindi generalissimi. Però è falso che esistano livelli di “totale” emarginazione – è come dire che esistano gli “uomini nudi” – e ciò vale all’interno di qualsiasi forma di organizzazione sociale. Perlomeno nel grande “centro capitalistico”, il cui asse centrale andava dalla Russia fino agli Stati Uniti e si è poi esteso ai cosiddetti BRIC. E si deve fare attenzione anche al fatto che lo sviluppo “salta”, che questo tipo di sviluppo capitalistico procede per “salti”, e che se ci sono certo zone del tutto marginali rispetto al cosiddetto sviluppo, ciò non avviene più in maniera lineare ma per stadi successivi ecc. (si noti, per esempio, che oggi i più alti tassi di diffusione della telefonia cellulare si danno in Africa).
Non esiste insomma un’emarginazione totale, così come non esistono terreni di totale inclusione: bisogna combattere la mitizzazione dell’emarginazione tanto quanto quella dell’inclusione attraverso il consumo. A me, quello dell’esclusione “totale” sembra costituire un privilegiato elemento polemico – è necessario distruggere questi alibi dell’azione collettiva costruiti sulla pietà, la compassione, e la superstizione religiosa. Quando parliamo di povertà, parliamo di condizioni che riguardano la gente sfruttata, cioè sottoposta in qualche modo a un meccanismo estrattivo, e la gente sfruttata non è mai totalmente povera. Per estrarre qualcosa ci vuole una realtà umana che produce, neppure chi è in schiavitù, è escluso dal meccanismo produttivo.
Veniamo ora a un altro punto di vista radicale sulla città contemporanea: nel suo ultimo libro – Rebel Cities – David Harvey, facendo più volte riferimento al tuo lavoro con Michael Hardt, percorre il tema della metropoli lungo entrambi i suoi versanti, quello della rendita e dell’accumulazione e quello delle lotte. La sua proposta rimanda sostanzialmente alla possibilità di riprendere, reinventare e attualizzare il lefebvriano diritto alla città per innestarlo sulle pratiche sociali di commoning. Credi che si tratti di una strategia all’altezza delle metropoli del nostro tempo?
Ci andrei piano. Credo infatti che il “diritto alla città” sia piuttosto qualificato in termini storici, che sia cioè il diritto alla città della gente che – per fare un esempio – abitava nelle barre della Courneuve e andava a lavorare nel centro di Parigi o a Billancourt: il diritto di attraversare quella città vivace e bella, provenendo da una banlieue miserabile. Per fare un altro esempio: era il diritto degli operai che venivano dal Sud a occupare Torino, invece di essere confinati nella cintura periferica. Il diritto alla città è insomma concetto legato alle ristrutturazioni urbane del periodo fordista. Questa era la città di Lefebvre, che non comprende ancora quel meccanismo di produzione del comune che a me pare oggi l’elemento centrale. Le tesi à la Harvey insistono troppo sulla divisione metropolitana del proletariato, e quindi propongono una visione pessimistica e negativa rispetto alla capacità di associazione, di riorganizzazione interna, e di insurrezione – quella capacità che il proletariato urbano ha cominciato a mostrare nella città post-fordista. Le riflessioni di Harvey non percepiscono ancora i movimenti autonomi e la nuova politicità che mostrano ad esempio i nuovi soggetti del lavoro cognitivo.
Harvey lavora a mostrare le “radici urbane” delle grandi crisi capitalistiche fondamentalmente analizzando il ruolo capitale che l’andamento dei mercati immobiliari avrebbe giocato in ognuna di esse. Senza dubbio è stato così nel crollo del 2008, ma tu credi che questo tema possa essere decisivo anche per indagare sviluppi futuri?
Non credo che il problema della rendita urbana resterà così centrale, anzi sono convinto che su questo terreno ci sarà un cedimento capitalistico consistente. La rendita urbana manterrà un certo rilievo ma non a questi livelli; si andrà secondo me più verso il modello delle città tedesche, dove il mixage dei valori immobiliari è assai vasto. Certo, nelle città turistiche come Venezia, Firenze etc., l’immobiliare avrà sempre un valore enorme, così come in prossimità di luoghi attraversati da “grandi eventi”, ma più in generale la metropoli deve diventare una città ibrida. È inevitabile rispetto ai costi di mantenimento della metropoli stessa: l’elemento sempre più fondamentale diviene il costo del comune. Da tempo sostengo che i costi per la riproduzione della città superano la capacità della rendita urbana di produrli, quest’ultima è attaccata direttamente dalle imposte, dai costi dei servizi, che finiranno per eccedere i redditi immobiliari. Non si tratta tanto di gentrificazione, quanto di una normalizzazione del consumo urbano. L’accumulazione passa ormai attraverso l’uso produttivo di questa macchina, che lavora in modo complessivo, generale: produce idee, linguaggi, potenze, modi di vita, reti, conoscenze, ma soprattutto cooperazione. C’è un’enorme “combinazione” che costa tantissimo al capitale e offre grandissimi ricavi – che sono però legati alla struttura del comune, non alla rendita.
Insomma, secondo me, la città che avremo non sarà costruita tanto sull’immobiliare quanto sulla somma e l’integrazione di servizi: è questo dispositivo che qualifica una città, perché la qualifica in quanto fabbrica. Fabbrica della moltitudine: non allude solo al fatto che la moltitudine produce, ma parla della quantità di servizi in costante espansione. Se ora si parla di mettere internet a banda larga gratuito nelle città, lo si fa perché produce, perché la gente lo usa, lo chiede, perché fa funzionare meglio la città, perché ci sono persone capaci di appropriarsene, perché rappresenta una forma di cooperazione che attraversa la città.
Spostiamoci adesso più specificamente sul versante della metropoli come luogo di produzione di soggettività e insubordinazione: ti propongo un percorso a tappe lungo alcuni avvenimenti ed esperienze degli ultimi anni. Recentemente hai avuto modo di viaggiare sia in Turchia che in Brasile, ove si sono dati mobilitazioni e movimenti propriamente metropolitani, partiamo da qui. Quali sono a tuo avviso gli elementi più significativi di queste esperienze? Quali i nessi e le discontinuità rispetto a movimenti come Occupy e gli Indignados?
In Brasile la lotta comincia su una rivendicazione tipicamente da “diritto alla città” – la tariffa dei trasporti urbani. Comincia così ma diventa immediatamente una rivolta contro politiche di sviluppo che apparentemente riproducono la struttura urbana e sono legate ai “grandi lavori”, ai grandi interventi sulla struttura urbana. In particolare a Rio queste politiche legano investimenti su grandi eventi come i Mondiali di calcio e le Olimpiadi a contemporanee pratiche di esclusione urbana e di “recupero” privatistico di quelle grandi strutture comunitarie che sono le favelas. Per tornarne incidentalmente su un punto toccato prima: le favelas incarnano la critica vivente a coloro che pensano che la miseria e la povertà possano essere “totali”; le favelas sono piuttosto, anche nella povertà, grandi polmoni di economia, di comportamenti produttivi e di nuove figure antropologiche, di nuovi linguaggi, di culture specifiche, non solo indigene, ma vere culture metropolitane, di altissimo valore. Poi, certamente, in esse vivono anche elementi di comunità perversa, su cui troppo poco discutono i sociologi della metropoli – se non quando la crisi arriva al nocciolo – come, per esempio, il mercato della droga, veramente distruttivo delle comunità, in particolare dal punto di vista etico-politico.
In Brasile la lotta è cominciata così, ma poi ha messo in gioco non solo il tema della ristrutturazione della città, ma anche tutti i simboli e i baluardi di una coscienza metropolitana bianca che si erano formati quando la città si era emancipata dallo schiavismo. Le favelas sono delle “città altre” vive all’interno della metropoli. Questo attacco alle favelas è divenuto così il punto fondamentale su cui le politiche dello “sviluppo urbano” sbattono la testa, dimenticando che le favelas sono “altro”, ma sempre “dentro” la produzione metropolitana. Il gruppo dirigente del PT, il governo socialista pianificatore, ha confuso sviluppo e produzione industriale nel senso più rigido della parola. La stupidità di questo archeo-industrialismo è stata subito rivelata da una resistenza ricca e vivace, l’opposizione è stata fortissima. Un’opposizione che certamente non è di natura “ecologica”, come non lo è stata a Gezi Park, ma volta a mantenere uno spazio comunitario vivo all’interno della metropoli. È qui la mutazione antropologica: l’operaio industriale identificava la città con la fabbrica e la fuggiva, oggi c’è invece questo rientro verso la metropoli che è la scoperta di una Comune della produzione sociale. Il carattere metropolitano è produttivo, non ecologico, ed è su questo che senza dubbio agiscono sia la rivolta di Gezi Park sia quelle di Rio e San Paolo…
… Parleresti di lotte dentro e contro lo sviluppo?
Direi piuttosto lotte della produzione contro lo sviluppo, lotte produttive contro lo sviluppo capitalistico. Bisogna cominciare a distinguere radicalmente produzione e sviluppo. Su questo il Manifesto per una Politica Accelerazionista – che ho recentemente commentato su EuroNomade – è molto bello e preciso. Bisogna riconquistare un concetto di produzione contro il concetto di sviluppo capitalistico. E questo vale di certo per Istanbul, dove alcuni strati di lavoro cognitivo sono completamente europeizzati, identici a quelli che potresti trovare a Parigi o Berlino, ed hanno reagito in maniera durissima all’incapacità delle élites di comprendere i loro linguaggi (diversa la situazione di Ankara, dove sono stati invece più rilevanti gli elementi politici legati alla laicità, perché la stretta fondamentalista islamista del governo ha pesato molto). Si tratta di richieste di riconoscimento della comunità produttiva, che è fatta dai lavoratori cognitivi, quelli sui quali agisce soprattutto l’estrazione di valore da parte del capitale. È su questo terreno, ambiguo e ambivalente quanto si vuole ma realissimo, che si è data una trasformazione radicale rispetto alla realtà descritta, ad esempio, da Harvey.
E da questo punto di vista devono essere osservate anche esperienze come Occupy e gli Indignados. Che evidentemente sono lotte contro la crisi per come essa si è venuta delineando in Occidente: una crisi di riassetto complessivo delle società per rimodellarle sui bisogni del capitale estrattivo. Si tratta quindi di un processo di riorganizzazione della metropoli e della divisione del lavoro, che contempla la distruzione del welfare e la costruzione di nuove gerarchie. Per questo dalla Spagna alla Grecia – e anche in Italia, ad esempio con il corteo del 19 ottobre – le lotte sul welfare si sono tutte caratterizzate sul terreno metropolitano, come una sorta di sindacalismo sociale metropolitano.
Eccoci dunque al movimento degli Indignados e a Occupy. Movimenti contro la crisi, nati nella e dalla crisi, ma che poi, in maniera per certi versi sorprendente, hanno organizzato il proprio discorso intorno alla rivendicazione di democrazia radicale, facendo di questo elemento, più che di istanze direttamente socio-economiche, la propria cifra più significativa e dirompente…
… D’accordo con te. Non vorrei però che riferendoci in questo modo a quei movimenti ci allontanassimo dal discorso specificamente metropolitano. È comunque importante che siano chiari i punti che, di quel passaggio politico, di quell’esperienza delle lotte, devono essere accettati e quelli che dobbiamo invece sottoporre a critica.
L’orizzontalità totale – sia in fase costituente, sia in un’immaginaria costituzione futura – cui quel tessuto di mobilitazioni allude, mi pare un modello completamente astratto di struttura politica. Può benissimo valere in fase di agitazione, ma è fuorviante quando si cerchi davvero di costruire e gestire un processo di trasformazione costituzionale. Io penso piuttosto a un modello di contropotere, meglio, di contropoteri diffusi, che è modello più aperto e capace di mediare efficacemente ed effettivamente i modi e le difficoltà di un processo costituente – rispetto all’orizzontalità che si è rivelata impotente, ignorando le diversità territoriali e spaziali che ogni movimento politico deve invece assumere e valorizzare. Gli Indignados hanno prodotto veri salti in avanti quando si sono riposizionati nei territori; la rivolta di Gezi park diventa importante quando si radica nei quartieri, quando cioè ogni quartiere organizza un contropotere effettivo e quando questi diventano capaci di attaccare verticalmente la struttura del comando. A guardar bene poi è la stessa nuova composizione metropolitana che oggi smentisce nei fatti la pertinenza del modello dell’orizzontalità totale nella costruzione di progetti duraturi.
Stesso discorso per l’esperienza statunitense?
Per quanto riguarda Occupy la situazione è parzialmente diversa. Si tratta di un movimento complesso, che nasce dal problema delle espulsioni dalle case, nasce dunque intorno al tema del debito. E attraverso il discorso sul debito si sposta su Wall Street. Ma poi su quel livello produce poco, se non la grande capacità simbolica di una lotta che, in quanto americana, è “vista” in tutto il mondo. Ma, misurata sul terreno dell’efficacia, è stata una delle esperienze più deboli degli ultimi anni. Infatti è stata liquidata dal potere in maniera molto pesante: da una parte attraverso il discorso del “doppio estremismo” – Occupy contro Tea Party –, e dall’altra con una certa inflessione radicale delle politiche dei Democratici che ha prodotto l’assorbimento del movimento nel passaggio elettorale che ha portato all’elezione del sindaco di Blasio. Elemento importante di Occupy rimane comunque il fatto di essere emersa come mobilitazione legata alla casa, contro la rendita immobiliare, intorno quindi a un elemento centrale per qualsiasi agenda di sindacalismo metropolitano.
Mi pare che abbiamo lambito i più importanti movimenti e lotte urbane degli ultimissimi anni, veniamo ora a un altro fenomeno tipicamente metropolitano ma apparentemente più “spurio” dal punto di vista politico, la sommossa. Dalla rivolta di Los Angeles del 1992 fino ai riots londinesi del 2011 passando per gli avvenimenti del 2005 nelle banlieues francesi: nuovi comportamenti sociali collettivi paiono essersi radicati nei territori urbani al punto di definirne una caratteristica quasi oggettiva – come mostra il lavoro di «etnografia politica del presente» del tuo amico Alain Bertho, teso a mostrare consistenza e penetrazione di questi fenomeni nel nostro tempo. Una tematica a cui, in Commonwealth, dedicavate una Genealogy of rebellion che dalla lunga storia delle jacqueries giunge fino alle rivolte urbane contemporanee, definite come «esercizi di libertà» mossi dal sentimento dell’indignazione, ancora insufficienti ma senza dubbio necessari al punto che oggi «jacqueries, lotte di riappropriazione, e rivolte metropolitane diventano il nemico essenziale del biopotere capitalista». Si tratta però di avvenimenti che restano a tratti “enigmatici” perché difficilmente afferrabili attraverso le nozioni più classiche con cui il pensiero politico moderno ci ha abituato a leggere la realtà sociale, e ai quali pertanto l’ordine del discorso è solito consegnare una stimmate di radicale impoliticità. Cosa pensi di questo discorso sull’impoliticità? E quali chiavi di lettura proponi per le sommosse urbane contemporanee?
Si tratta di avvenimenti alla cui origine c’è sempre la morte di un giovane per mano della polizia, si potrebbe dire che c’è qualcuno che muore in forma simbolica per rappresentare l’esclusione. Quindi c’è un’eteronomia degli effetti dell’ordine democratico, dell’ordine dell’uguaglianza formale, che qui esplode. Queste rivolte nascono essenzialmente di fronte a quell’atto politico archetipo, che è un’uccisione ingiustificata da parte del potere. Per questo è idiota definirle “impolitiche”, perché si tratta di rivolte che nascono dall’insulto a un diritto fondamentale, quello di vivere. Il dramma di Antigone è forse impolitico? C’è un’indignazione politica che poi si irradia su tessuti metropolitani sempre più tecnologicamente disponibili e permeabili alla diffusione dell’indignazione e della sommossa. Si tratta di lotte che si diffondono e si organizzano attraverso i nuovi strumenti di comunicazione, in quella combinazione nascosto/palese che ha sempre caratterizzato le jacqueries. Che, anch’esse, avevano un contenuto estremamente preciso: si attaccavano i centri in cui si decretavano le imposte, si bruciavano i registri in cui erano segnati i poveracci che dovevano pagare la gabella. Questo era il loro contenuto, ed è degno di nota come i borghesi pretendano che quando loro parlano di tasse, si tratti di politica, mentre quando ne parlano i poveri, ecco allora l’impolitico.
Chiaramente se si parla di politica solo facendo riferimento alla tabella formale dei diritti ed alla loro traduzione attraverso la rappresentanza parlamentare, allora questi movimenti possono tranquillamente essere definiti “impolitici”. Tutto dipende da come si pensa la politica: se lo si fa da marxisti, politica è la capacità di rompere la struttura del mercato del lavoro e del salario, e l’ordine capitalista che li determina; in questo caso diventa difficile escludere dall’orizzonte politico i fenomeni di insubordinazione urbana, che paiono invece svilupparsi come vere e proprie lotte sindacali o politiche sul terreno sociale della metropoli. Perché attaccano l’esclusione che passa attraverso l’organizzazione razziale del mercato del lavoro, o le pratiche del salario, o le operazioni di bassa retribuzione e inquadramento della forza-lavoro – capitale variabile. Anche la spontaneità di queste lotte ha caratteri politici importanti, e comunque è sempre una spontaneità solo iniziale, perché poi l’irradiamento, l’espressione, la ripetizione, comportano sempre elementi di organizzazione. Che poi questi riescano a svilupparsi in strutture stabili o no, è un problema che va al di là dei limiti della nostra conversazione.
Credi insomma che il discorso sulla metropoli come fabbrica, sulla metropoli post-fordista sia il quadro in cui collocare anche l’analisi di questi fenomeni sociali e comportamenti collettivi?
Credo proprio di sì, penso che il discorso della metropoli produttiva, post-fordista, sia il solo quadro in cui questi fenomeni possono essere compresi fino in fondo. Nella metropoli contemporanea il biopotere del capitale e la biopolitica dei soggetti si mescolano e si confrontano: non ci sono altri luoghi dove questa condizione sia data altrettanto chiaramente. La rivolta, nella metropoli contemporanea, insorge dalle violazioni di un diritto elementare – il diritto di vivere –, e poi si espande, e lo fa normalmente, concentrandosi, sugli elementi di oppressione più forti. Che spesso hanno a che fare con la dimensione razziale e con l’esclusione e la discriminazione che ne derivano. Ivi compresa l’esclusione dai consumi: ragion per cui prende forma la rivolta appropriativa di beni, come accaduto in recenti mobs in cui la lotta contro la determinazione razzista dell’esclusione, attraverso la richiesta di consumo, verificava, nella rivolta appropriativa di beni, anche una determinazione di classe. L’elemento razziale e di classe si intrecciano proprio sulla spinta appropriativa del consumo: tutto ciò è assai efficace nel mostrare quale sia il punto dolente, la povertà, lo sfruttamento. Mi diverte l’esecrazione che i borghesi mostrano davanti a quei giovani che rubano beni solo ai borghesi destinati.
Hai già introdotto anche il tema della razza, che è emerso come una delle chiavi di lettura prevalenti di questi fenomeni metropolitani. Chiave di lettura poliforme e polisemica, che è stata utilizzata dalle prospettive più diverse, dai discorsi reazionari e securitari a quelli volti a scorgervi i profili di insorgenze post-coloniali, fino a tutte le interpretazioni che hanno fatto, a vario titolo, riferimento alla categoria di riconoscimento…
…Sì certo, il riconoscimento è una categoria importante, ma bisogna stare attenti a questo tema, che probabilmente vale più per altri strati di “esilio del lavoro organizzato” che per questo tipo di rivolte, ove magari l’istanza del riconoscimento si realizza sul terreno religioso. La tematica del riconoscimento è sempre portatrice di un’ambiguità legata a quell’elemento di blocco e/o di interiorizzazione della protesta che in maniera astuta le borghesie cercano di iniettare nelle masse multicolori, multiculturali delle metropoli. Dal nostro punto di vista, il discorso va riportato invece a soggettività caratterizzate in termini razzialmente forti, come accade nella scia di sommosse che va, dagli anni 90, da Los Angeles fino, recentemente, a Londra. E come accade oggi anche in Brasile, dove – è utile sottolinearlo – insieme si riconoscono nelle lotte i lavoratori cognitivi e quei ragazzi delle favelas che dopo secoli di dominio razziale conquistano il diritto alla parola. E questa rottura della rigidità di un dominio capitalistico, connotato in termini razziali, costituisce un evento straordinario. Insomma, è evidente che cause e caratteristiche delle rivolte metropolitane possono essere le più diverse, ma il carattere distintivo va trovato nella risposta a “contro cosa ci si ribella?”. Ora, quelli che sono stigmatizzati dal punto di vista razziale si ribellano contro un certo ordine capitalistico, quelli esclusi dalla struttura di un mercato del lavoro regolare si ribellano contro la moltiplicazione del peso dello sfruttamento: comunque questi esclusi, non lo sono dallo sfruttamento o dall’accumulazione. Il problema grosso dal punto di vista politico è allora di riuscire a essere dentro questi processi ed eventualmente di romperli quand’essi si diano puramente in termini di riconoscimento (spesso identitario o producente meccanismi di autoriproduzione separata) per riconoscere piuttosto che la singola diversità oppure l’unità del comando dello sfruttamento, a tutti è egualmente imposta.
Hai giustamente sottolineato che all’origine delle rivolte urbane contemporanee vi sono quasi sempre comportamenti violenti della polizia che sfociano nell’omicidio: questo ci conduce al tema della metropoli come spazialità politica dell’eccezione, territorio in cui le autorità dello Stato sospendono talvolta il diritto, i diritti, la legge lasciando vigere solo la forza su cui l’ordinamento poggia, e che lo garantisce. Come interpreti questa tematica e la sua rilevanza nel nostro tempo?
Senza dubbio il tentativo di rendere eccezionale la normativa dell’ordine è spesso ripetuto. E tuttavia già il fatto che sia ripetuto, mostra che non è una costante. L’eccezione è una necessità posta per determinare controllo, quando il controllo sia precario. Ciò detto, quello che non si deve mai dimenticare, è che nel rapporto regola/eccezione l’elemento decisivo è la regolazione di Stato, l’esercizio del controllo da parte del potere sovrano. In questa prospettiva non bisogna confondere l’“eccezione” sovrana (la dittatura) esercitata in termini costituzionali e le norme eccezionali decretate col fine di mantenere l’ordine pubblico. Tutto ciò ci riporta alla memoria Genova, ma un’eccezionalità di quel genere mi pare (fortunatamente) sempre più probabile di quella costituzionale. Questo per dire che mi sembra molto pericoloso identificare l’una con l’altra, come troppo spesso si fa – in maniera poco ragionevole ed “estremistica”. L’idea di eccezione è secondo me fondamentalmente legata a momenti molto alti della lotta di classe, ed è quindi subordinata anche all’altezza del conflitto – non è dunque ciò che ne dicono Agamben o altri, in termini sofisticatamente metafisici o ingenuamente anarchici. Non si vede perché i padroni dovrebbero riconoscere e designare il proprio potere come eccezionale in un momento in cui, se non tutte, parecchie cose vanno bene per loro. Si deve risalire al rapporto di classe come rapporto di guerra, per comprendere quando e come l’eccezione possa essere instaurata e trasformarsi da provvedimento di ordine pubblico in norma costituzionale. La scienza politica dei grandi storici latini, degli statisti ciceroniani era molto attenta a questo snodo: Tacito lavorava a mostrare che l’eccezione è legata a momenti di conflittualità che sono altrimenti irresolubili. L’eccezione emerge quando c’è uno stato di guerra, a meno di non voler sostenere che siamo in uno stato perenne di guerra – il che mi sembrerebbe molto strano. La violenza – la violenza di eccezione, differente da quella coperta e molto più efficace che il sistema esercita quotidianamente – esplode quando il potere ne ha in qualche modo la necessità e l’urgenza.
Nel tuo discorso il tema dell’eccezione appare dunque legato a quello della conflittualità di classe. Un conflitto da cui, come notava già Walter Benjamin al principio del secolo scorso, le istituzioni del movimento operaio occidentale cercavano di escludere tendenzialmente il ricorso alla violenza, lasciandola solo minacciata, “rappresentata” nelle forme dello sciopero. Indagando alcuni fenomeni del presente, Michel Wieviorka ha, all’opposto, parlato di una “violenza senza conflitto”: ti pare una categoria in grado di far presa sul nostro tempo?
Io penso che invece il conflitto c’è: la crisi cos’è se non un conflitto che è stato portato all’estremo, un conflitto che continua dall’accennarsi della prima crisi post-moderna nel 1973? Un quarantennio di crisi, che sta forse terminando a vantaggio del capitale, con la fissazione di un radicale riassetto delle forme di accumulazione. E tuttavia: a fronte di una ricomposizione di lungo periodo di un “capitalismo da accumulazione” – una nuova accumulazione originaria completamente indipendente da qualsiasi misura o rapporto con il salario e il capitale variabile – si presenta non tanto una crisi divenuta e irresolubile, quanto una resistenza implacabile, socialmente diffusa, sulla quale riposa ormai l’“eccedenza” produttiva del proletariato cognitivo. Il conflitto permane.
In questa prospettiva, la categoria “violenza senza conflitto” mi suona strana. È una delle solite formule che eliminano il conflitto in nome della violenza – che risuonano dunque similmente alle concezioni dell’onnieccezionalità della norma statale. Il conflitto c’è sempre anche senza violenza. Poi la violenza arriva: perché? Guardiamo alla cosiddetta violenza “estremista”. Cosa è stata? Una violenza cui il movimento è stato costretto perché nessuno lo ascoltava, eppure era una forza, ma la sua voce era costituzionalmente inaudibile. Il grande cruccio delle persone che hanno fatto gli anni Settanta, è stato, più che quello di aver esercitato violenza, di non essere riuscite a esercitare un’eccedenza di protesta sufficiente a essere ascoltate, a diventare audibili. Un’eccedenza che era oggettiva: nelle lotte nelle fabbriche, sociali, in una situazione di enorme effervescenza che però quando costituzionalmente è divenuta inaudibile, invece di rafforzarsi ancora sul terreno sociale, ha subito una via di fuga militarista ed è stata quindi militarmente repressa. Dunque, il conflitto c’è – su di esso occorre lavorare e sviluppare una “eccedenza” che blocchi l’“eccezione”.
Ci siamo ormai allontanati dal tema iniziale, e allora terminiamo sulla problematica cui siamo approdati: nel Lavoro di Dioniso proponevate una “critica pratica della violenza” tesa a strappare l’analisi di quest’ultima dal terreno della speculazione astratta e calarla nell’indagine delle sue manifestazioni materiali. Concludiamo allora questa nostra chiacchierata con una breve riflessione su quel circolo violenza/paura che pare una cifra fondamentale di molte rappresentazioni delle città contemporanee.
Non si deve mai operare una sovradeterminazione della violenza come tale. Innanzitutto, un pugno a un vigile non è la stessa cosa di un omicidio, e invece oggi qualsiasi tipo di delitto, di violenza, viene qualificato come delitto contro la sovranità. Questo è assurdo, poiché pone un’omologia fra un atto di violenza qualsiasi e un omicidio: è il meccanismo della sovranità che appiattisce tutto, sovradeterminando i conflitti sociali. In secondo luogo, la violenza c’è sempre, non è un elemento da reprimere, ma da organizzare. La violenza esiste non come dato naturale, ma in quanto elemento legato alla struttura del sistema, di un sistema che esercita una violenza ritenuta legittima. Quindi il problema non è la violenza, è la legittimità della violenza, e qualsiasi tipo di organizzazione sovversiva se lo è posto come tale.
Ora, cos’è la legittimità? È il rapporto che si ha tra l’esercizio del comando e il consenso rispetto alle finalità in nome delle quali il comando viene esercitato. Quando questo rapporto è determinato semplicemente dalle esigenze dello sviluppo capitalistico, esistono margini particolarmente ampi rispetto ai quali l’esercizio della legittimità non funziona, manca o è storto. Infatti, la legittimità imposta in queste condizioni, è eguale a violenza. La reazione ad un ordine capitalista imposto in nome dello Stato non può che essere una risposta violenta e legittima, in quanto si sottrae ad una violenza sporca – quella dell’ordine legale che copre il potere del capitale. Non è violenza, è controviolenza, è contropotere, una controespressione di legittimità. Ritengo che siano legittimi tutti i comportamenti che riguardano la resistenza a un ordine ingiusto. Ma chi determina il fatto che l’ordine sia giusto o no? Da un lato la coscienza di ciascun soggetto, modificatasi storicamente dentro lo sviluppo del rapporto sociale capitalistico, e dall’altra parte il comportamento delle funzioni di comando che hai di fronte. Il problema di definire la legittimità nasce da questa relazione, e da questo punto di vista la violenza definisce il potere ma anche il suo contrario, anche la potenza biopolitica dei soggetti.
Non c’è quindi un modo oggettivo di garantire la legittimità, anche perché essa è sempre e solo un rapporto e un mezzo. Per questo devono essere guardati con occhio critico anche autori, come Benjamin, che, quando sono stati investiti dalla violenza del regime nazista, non sapendo spiegarsela, la hanno assunta dal punto di vista teologico, rinunciando spesso a fare – ma non è il caso di Benjamin – autocritica rispetto alla politica comunista degli anni Venti. L’idea dell’irrazionalità della violenza è fondamentale nella cultura borghese, perché essa non è mai riuscita a esercitare un comando democratico che non avesse la forma del dominio capitalista. Mentre la democrazia potrebbe essere il contrario del dominio, quando i diritti dell’uomo fossero riconosciuti non formalmente (=regole del mercato), ma materialmente (=istituzioni comuni). Così si può determinare un’esaltazione del consenso in un quadro in cui la violenza si può dare solo quando è acconsentita, e non da meccanismi da rappresentaza ma di partecipazione effettiva. Vogliamo muoverci nella direzione di eliminare la violenza? Il modello di democrazia assoluta di Spinoza, per esempio, è un modello in cui il minimo di violenza sarà possibile, perché implica il consenso effettivo di tutti sul terreno dell’uguaglianza nel determinare ogni percorso sociale. Ma anche in questo caso, siccome gli uomini non sono sempre buoni, ci vogliono dei contropoteri effettivi che funzionino per garantire questo processo.
La paura, infine, è un elemento fondamentale nella creazione di una violenza sistemica. Ed è il concetto (la passione) essenziale rispetto a cui è costruita l’eminenza della sovranità. La paura è sempre paura dell’uomo nei confronti dell’altro, ed è perciò la base su cui si costruisce la sovranità come ciò che dovrebbe togliere la paura dell’homo homini lupus nella società individualista. Che tutto ciò fosse poco convincente, che fosse uno strumento essenziale di un solo ordine civile possibile – quello individualista e borghese – è evidente. Val tuttavia la pena di osservare che lì, in quel quadro hobbesiano, la paura era comunque elemento costruttivo che attraverso l’alienazione dei diritti di ciascuno organizzava il potere sovrano. Poi seguiva l’ordine. Adesso invece la paura non costruisce ordine ma organizza la precarietà, riproduce paura, è il grande continente di ogni dispositivo della nostra vita. E il desiderio non va più dalla paura alla sicurezza ma dalla paura alla paura, dall’incertezza all’incertezza. La paura non produce la sovranità ma distende il dominio. Lo riproduce nel senso che ciascuno deve aver paura dell’altro, e la sera non può uscire, e le donne devono stare attente a stupratori che sono a ogni angolo, e la televisione mostra solo cose criminali e poliziesche, eccetera. La paura è in questo senso un elemento centrale nella riorganizzazione e nella tenuta delle forme sociali capitaliste, e incarna probabilmente il punto più oscuro della crisi della democrazia neoliberale: al punto che oggi la serenità può tranquillamente essere assunta come un’attitudine rivoluzionaria.
Firenze, gennaio 2014