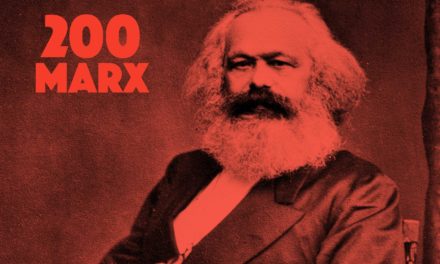di VINCENZO DI MINO.
Brevi note intorno all’ultimo libro di Étienne Balibar, Crisi e fine dell’Europa?, trad. di F. Grillenzoni, Bollati Boringheri, 2016
Grande è la confusione sotto il cielo, come recita un famosissimo adagio. Nel bel mezzo delle frammentazioni che gli eventi succedutisi senza soluzione di continuità negli ultimi anni in Europa, è chiaro come gli scenari politici multilevel si polarizzino sino all’acme, lasciando briciole alle posizioni e ai discorsi altri: non ultimo, il meta-evento rappresentato dall’esito delle elezioni americane e l’infausta vittoria di Donald Trump, con le conseguenti ripercussioni che ha avuto sull’altra sponda dell’Atlantico. Salutare, allora diventa scavare, lavorare sotterraneamente per costruire un’altra opzione, procedendo per tentativi all’attivazione e alla connessione dei processi di democrazia reale, inclusivi e trasversali.
L’ultimo volume del filosofo francese Etienne Balibar Europe: crise et fin si pone in questo solco, in netta controtendenza con la pubblicistica sulla crisi che affligge il vecchio continente; nell’interrogare incessantemente le origini della crisi, la fallibilità delle strutture istituzionali, gli errori delle politiche comunitarie e le vecchie amnesie identitarie delle sinistre, Balibar, convinto sostenitore dell’ipotesi transnazionale, non smette mai di ricercare delle vie d’uscita alle impasse che bloccano i dibattiti ma anche le possibili soluzioni politiche.
La raccolta di saggi, che copre gli anni trascorsi tra il 2011 ed il 2015, snocciola impietosamente una serie di polaroid sul presente, leggendone i sintomi e tracciandone provvisorie conclusioni, trasformandosi in una sorta di volume inattuale, perché collocato nel cuore degli eventi ma tenacemente contro, sviluppando un ordine del discorso irriducibile alle narrazioni e alle politiche mainstream, appiattite su regimi binari di comunicazione ed esecuzione. Usando un concetto tipicamente gramsciano, quello dell’interregno, gli articoli del libro ci portano nel cuore delle politiche europee e delle resistenze che ad esse si sono date, ribadendo come ancora sulle macerie del vecchio il nuovo non sia sorto, e come il vecchio stesso si sia trasformato sulla pelle delle popolazioni attraverso nuovi regimi disciplinari, tagli e misure d’austerità, riduzione degli spazi di dibattito e completa sordità nei confronti delle migliaia di voci di dissenso che via via si sono alzate. La crisi ha scoperchiato il vaso di Pandora europeo, accelerando e scatenando tutti i problemi di natura politica, giuridica, economica e sociale che covavano da tempo al suo interno: nazionalismo, xenofobia, eliminazione dei diritti sociali. La guerra “infinita”, per ribaltare di senso il nome dell’operazione multinazionale a guida statunitense dopo l’11 settembre, che vive non solo ai confini ma dentro le metropoli del continente ha aggravato di molto la situazione. Come riattivare il progetto democratico nell’Europa di Calais, della Brexit, di Gorino e degli hotspot? Provando ad afferrare il filo rosso che lega questa multiforme serie di saggi, articoli e discorsi, tre sono i temi centrali che attraversano il volume: la profonda spaccatura in seno alle istituzioni della governance, sempre più divisa tra aspirazioni federaliste e ritorni di sovranità; l’ambivalente natura e la effettiva esistenza di un popolo europeo, come sottolineano l’emergenza di nazionalismi identitari e gli spettri intermittenti del cosmopolitismo; l’emergenza di una necessità democratica post-sovrana e gli attrezzi per costruirla.
1. La spirale istituzionale
Parafrasando il titolo di un best-seller del compianto Ulrich Beck, questi anni hanno visto la lenta ma progressiva affermazione di una “Europa Tedesca”, con conseguente centralizzazione delle gerarchie politiche esistenti. Il mito della Germania post ’89, con le susseguenti apologie dell’efficienza economica e sociale, ha prodotto un modello intorno a cui si sono riformulate le azioni della governance comunitaria. Dal “commissariamento” del governo Papandreou del 2011, passando per l’esautorazione ex cathedra del governo Berlusconi in Italia, l’orizzonte dei governanti è stato quello dello stato d’emergenza, a partire dal quale sono state varate le famose misure di “salvataggio” o “aggiustamento strutturale”, per usare l’inflazionata terminologia delle discipline economica. Si badi bene: “stato d’eccezione” non viene usato da Balibar nella sua accezione teologica e trascendentale, con il conseguente abbandono nella deboli braccia che rappresenta la metafisica dell’attesa, ma spesso e volentieri accoppiato al più marxiano concetto di “rivoluzione dall’alto”, ovvero sia dell’apertura di un processo di trasformazioni sociali portato avanti dalle élite continentali al fine di garantire le condizioni di governabilità e, anche se ammantato da retorica amministrativa, il ristabilimento di adeguati saggi di profitto per gli agenti economici operanti all’interno. Mario Draghi e Wolfgang Schäuble sono state le figure più rappresentative di questa transizione, essendo il presidente della Bce e il ministro dell’economia tedesca, nel farsi portavoce della nuova fase apertasi dopo il 2008. La nuova “Grande Trasformazione” che è avvenuta in Europa parla la lingua della parità di bilancio, del rispetto delle clausole europee dello sforamento del deficit del 3% e della libera circolazione delle merci a salvaguardia della reale istituzione guida di questa transizione, il feticcio della moneta unica e del suo valore di scambio nei circuiti finanziari globali. In tal senso Balibar parla dell’Europa come mero attore economico nei processi di governance globali, in cui tutto è sacrificabile alla freddezza del rigore finanziario: il “Quantitative easing” e il diktat imposto dall’Eurogruppo al governo greco sono le due facce della stessa medaglia. Due sono allora le modalità di governo adottate: quella della polarizzazione assoluta delle ricchezze, nuova “accumulation par depossesion” attraverso selvagge politiche di privatizzazione dei beni comuni, svendita dei patrimoni pubblici e cartolarizzazione degli enti della previdenza sociale, e quella dello svuotamento delle istituzioni preposte all’elaborazione delle scelte politiche. La necessità tutta ordo-liberale di istituzioni post-democratiche, sciolte dai “vincoli” formali della rappresentanza e in grado di autoregolarsi, fa il paio con la de-democratizzazione delle stesse garanzie sociali, estese su scala continentale, cancellando la fase che il varo del Trattato di Lisbona del 2007 poteva aprire: comprimere i diritti sociali, compreso quello sacrosanto al dissenso, va di pari passo con la teleologia della governabilità tout court. De facto, la separazione sempre più marcata tra soggetti preposti alla decisione e spazi di produzione democratica sembra la tappa finale di quella tragica profezia weberiana, secondo cui la burocrazia sarebbe stata l’approdo finale della “gabbia d’acciaio” capitalistica: la nuova tecnocrazia che governa in nome dell’efficienza non è, come vogliono i sinceri democratici, lesiva dei poteri sovrani dello stato, ma paradossalmente li amplifica inserendoli all’interno di reti internazionali.
Il progetto federale, perno basilare della costruzione europea, è stato superato in nome di quello che il filosofo francese chiama “pseudo-federalismo”, dove al posto dell’eventuale distribuzione di poteri si ha una frammentazione e una sovrapposizione di competenze comunitarie e nazionali, che rendono ormai impossibile qualunque tipo di mediazione. La mediazione classica, figura centrale della forma di governo rappresentativa, ha spazio, ma sul piano meramente formale, non avendo più peso nella produzione normativa o nell’aggredire i nodi irrisolti della governance: il non aver afferrato le trasformazioni dei rapporti di forza ha significato, per l’autore, l’imbocco di un vicolo cieco per le classi politiche nazionali, soprattutto di sinistra, aprendone il declino e l’allontanamento dalle reali necessità collettive, nonostante gli sforzi che egli ha visto rappresentati dalla strenua resistenza di Syriza e nell’ascesa di Podemos in Spagna. Fatta questa premessa, è chiaro come le nuove geografie del potere producano delle divisioni che assumono un peso non indifferente nell’elaborazione governativa: l’Europa a due velocità, su cui sono state scritte molte pagine, diventa operatore politico/economico neo-coloniale per le differenti politiche che in quei paesi individuati come tali (i famosi PIIGS) vengono effettuate al fine di rimetterle in pari con i restanti paesi “virtuosi” e disciplinati, ligi alla regola aurea del pareggio di bilancio. Ed è proprio ai margini di questa seconda Europa che si è abbattuta la più grande tragedia umana del XXI secolo, quella dei migranti, con il Mediterraneo trasformato per volontà governamentale nel più grande cimitero a cielo aperto. Di fronte all’evidente fallimento di Schengen e al revanchismo nazionalista prodotto all’interno delle nazioni, l’unica risposta, peraltro proveniente dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, è stata quella della divisione, del tutto interna alle logiche politiche, tra “migrante economico” non degno di accoglienza e “richiedente asilo” in fuga dalla guerra: al cuore di questi enunciati sta un preciso progetto, che è quello di trasformare uno spazio di circolazione sovranazionale in una mega-frontiera, moltiplicandole e sovrapponendole. “Europe as Borderland” la chiama Balibar, ed è tra Lampedusa e Calais, nell’innalzamento dei muri nell’Ungheria di Orban o nella “Brexit” che la viltà e l’incoscienza dei tecnocrati si manifestano.
2. Dialettica del populismo
Dal 2014, data delle recenti consultazioni per il Parlamento Europeo, un concetto è entrato di forza nel lessico della politica europea: populismo, rifocillato negli ultimi convulsi giorni dal ventaglio di posizioni intellettuali che, in seguito all’elezione di Trump, si stringono in difesa della democrazia sul suolo continentale. Che cosa sia non si sa bene, ma nel suo spettro polisemico è in grado di accogliere e mettere insieme i neo-fascisti del Front National, gli euroscettici del Movimento 5 stelle e Varoufakis. L’invarianza analitica con cui esso viene utilizzato a corollario della crisi è la spia più evidente dello iato tra governanti e governati, tra élite e popolo, e paradossalmente tra demos europeo ed ethnoi nazionali. L’archetipo del “popolo” è tornato ad essere campo di battaglia tra forze politiche differenti, interne alla serie binaria lungo cui si costruisce la politica ufficiale europea. Tagliando con l’accetta ed esemplificando, due sono le declinazioni di questo concetto chiave della teoria politica: l’uno è di matrice neo-keynesiana, che a partire da una neo-rappresentanza popolare in Europa vorrebbe avviare un “New Deal Globale” che individua in alcuni correttivi fiscali e nella ristrutturazione delle modalità della rappresentazione la panacea dei mali di quest’Europa; l’altra, invece, incentrandosi su una macchina di produzione identitaria che individua nell’etnia il carattere centrale che lega gli individui, è desiderosa di ritornare alla vecchia forma-Stato nazionale, in grado di farsi carico dei bisogni e delle aspettative dei singoli individui. Alla prima posizione è ascrivibile l’impegno di Jürgen Habermas, per la seconda c’è l’imbarazzo della scelta tra Marine Le Pen, Matteo Salvini e, last but non the least, il Matteo Renzi in veste di padre costituente della patria morente. Entrambe le posizioni sbagliano completamente il punto: partendo dall’abusatissimo teorema sulla presunta divisione tra una “buona” economia industriale e una “cattiva” finanza, entrambe elaborano correttivi che nella loro accezione sono in grado di permettere l’uscita dalla stasi: marxianamente, però, come può essere sottolineato, esse approcciano i differenti momenti della produzione, rispettivamente circolazione e scambio, senza riuscire a cogliere la totalità del processo di produzione stessi. Per analogia, lo stesso errore vale nella comprensione complessiva dei processi politici post-democratici da cui essi sono intimamente prodotti ma da cui vogliono distanziarsi: né il controllo serrato dei rappresentanti né tantomeno una antistorica autarchia possono essere una cura all’eliminazione dei diritti. Per entrambe le narrazioni c’è un popolo come centro nevralgico di elaborazione. E popolo, ad oggi, è sinonimo di divisione identitaria. Le “comunità immaginate”, per dirla con Benedict Anderson, che entrambe le versioni della governance producono, sono altamente escludenti. Esistono delle linee di divisione intra-europee che a partire dalla teoria delle “due velocità” precipitano nella produzione soggettiva astratta. Lungo le linee demarcate da “debito” e “colpa”, concetti chiave nell’affermazione dell’egemonia tedesca, si è costruita una mega-macchina di produzione identitaria che, dal razzismo interno ha prodotto un razzismo istituzionale esterno in cui l’odio dei poveri, il ritorno violento del rimosso coloniale e la costante delegittimazione delle istituzioni sono il collante. Questo “popolo” è dunque una totalità astratta da qualunque determinazione materiale esistente, mito senza parola, punto d’approdo del processo di spoliticizzazione che la tecnocrazia ha portato a compimento.
Due sono i soggetti politici che si nascondono dietro il “popolo”: l’uno alla ricerca di una nuova mediazione su scala internazionale e l’altro alla ricerca della propria comunità univoca su cui costruire consenso, entrambi però sono funzionali al divide et impera che viene prodotto dall’alto.
Super-stato contro sovranità nazionale, eludendo tutte le altre problematiche, senza spazio per un altrove. Dentro questa serie binaria lo spazio per la democrazia diventa risibile, inesistente, compresso dentro queste esigenze. Ma è su questo punto che Balibar produce una feroce critica ai populismi, specialmente quelli che hanno integrato la nuova declinazione del termine che ne ha data Ernesto Laclau: per Laclau, infatti, il popolo è un “significante vuoto” al cui interno possono prodursi connessioni in grado di dar vita ad una nuova egemonia. Utilizzando Gramsci contro Laclau, Balibar oppone infatti una egemonia materiale, da conquistarsi dispiegando il principio di egalibertè, a un arroccamento identitario e pericoloso. Davanti alla trasformazione della costituzione materiale nazionale e sovranazionale, è importante sottolineare che i processi di aggregazione interni ad alcune cornici identitarie, come quelle che il populismo fornisce, è molto pericoloso. Attualizzando, infatti, le differenti divisioni popolari che caratterizzavano la democrazia ateniese, Balibar scrive che la costruzione dell’identità europea odierna è mediata dalle diverse intensità di senso che hanno i nomi delle divisioni popolari stesse: demos-laos-ethnos-pletos. La stessa confusione semantica che viene poi sovradeterminata dal significante “popolo” annega le intrinseche differenze delle singole componenti stesse di questa identità immaginata, con conseguenze dannose per una politica che si vuole di rottura di trasformazione: il populismo infatti da anticorpo e forza conflittuale diventa un supplemento della governance tecnocratica, che nello spogliare il popolo stesso dalle divisioni da cui è storicamente attraversato, lo trasforma in un universale vuoto tale da permetterne una conduzione docile. Il popolo dunque è soggetto ad un double bind: catturato dalle forze politiche apertamente reazionarie e ricatturato dalle istituzioni della governance, Allo spettro del demos Balibar oppone infatti una “puissance publique comunitarie”, ovvero la costruzione dialettica e dinamica di una “co-citoyennetè” europea, ovvero le condizioni di esercizio di una politica trans-nazionale trasversale e inclusiva.
3. Cosa viene dopo questa Europa?
La situazione che Balibar dipinge è fosca e apocalittica. Negli ultimi mesi, infatti, dopo gli attentati che hanno colpito Parigi e Bruxelles, i governanti hanno provato a fare autocritica per colmare il gap di legittimazione che attanaglia le istituzioni stesse. Questo uso “istituzionale” del populismo non ha avuto gli effetti da loro sperati, avendo tutti negli occhi la drammatica situazione greca del luglio 2015: se il 5 luglio, infatti, l’Oxi si faceva agente collettivo di enunciazione del desiderio di un’altra Europa inclusiva, democratica, in cui la presa di parola trans-nazionale fungesse da vettore di soggettivazione democratica, il trattamento riservato dalle autorità assumette la forma di un vero e proprio waterboarding, costringendo il governo di Syriza a emendare il risultato elettorale ed accettare le misure di salvataggio. Ma nonostante la cecità dei governanti, è possibile pensare a “cosa viene dopo questa Europa”, per detournare il titolo di un importante saggio di Balibar stesso?
 Secondo il filosofo non solo è possibile, ma soprattutto è necessario ripensare le categorie politiche a partire dal piano europeo. La lotta per la democrazia in Europa è centrale nelle nuove dinamiche che la lotta di classe assume oggi. Riprendiamo l’Oxi come modello del conflitto a venire: nel riconoscimento trans-nazionale che la composizione trasversale della soggettività europea operò nei confronti del referendum, esso si trasformò in una vera e propria manifestazione di parrhesia transnazionale: la voice scelta dai governati fu la voce degli sfruttati, dei poveri, di quei segmenti le cui condizioni la governance della crisi ha peggiorato, che individuò il voto greco leggendone le potenzialità post-rappresentative ed immediatamente conflittuali. Nell’Europa dei risentimenti xenofobi quello fu un momento di assoluta democrazia immediatamente soffocata. Ma è necessario riprodurre le condizioni che portarono all’affermazione di una potenza costituente immediatamente transanzionale e collettiva. In questo senso la lotta di classe sul piano europeo può dislocarsi solo a partire dalla produzione di innovazioni democratiche post-sovrane e dalla tensione meticcia e cosmopolitica che anima le molteplici istanze sociali diffuse nel continente. Le condizioni della conflittualità diffusa partono proprio dal concetto di cittadinanza politica che Balibar ha sviluppato negli anni, in grado di coniugare i diritti fondamentali di espressioni con le condizioni di equità e uguaglianza sociale che sono proprie dei processi democratici: l’egalibertè diventa infatti una prima forma di “controdemocrazia”, per usare il termine di Pierre Rosanvallon, ossia di rottura nei confronti dei dispositivi di potere. Programmatica diventa allora l’apertura di un momento costituente europeo, che si ponga oltre le secche del costituzionalismo nazionale: la riappropriazione del momento decisionale collettivo segnerebbe non solo la fase destituente del presente, ma anche il kairos della democrazia come processo di autogoverno molecolare e collettivo, in grado di invertire la serie politologica classica per cui è la forma di governo che produce il proprio soggetto, che alla fine lo legittima: reiventare processi democratici di riappropriazione di tempi e spazi dell’agire politico, nonché di redistribuzione della ricchezza socialmente prodotta, significa costruire un “multiversum” politico, che acquisti un segno di parte nel momento stesso in cui viene fatto proprio dalla praxis collettiva. Significa reinventare le forme politiche di costruzione di un soggetto collettivo in grado di aprire percorsi conflittuali per i diritti collettivi e costruire vettori autonomi di contro-potere sganciati dalla tecnocrazia: in poche parole, opporre politique a police, il dualismo costituzionale al tentativo di accentramento di poteri in corso. E lasciare eccedere questo dualismo dai tentativi di neutralizzazione e repressione. Esempio può essere la diffusione compiutamente europea che il movimento francese della “Nuit debut” si è immediatamente dato: espressione di quella forza lavoro intellettuale pauperizzata, precarizzata e normalizzata dalle categorie mediatiche come “ Generazione Erasmus” o “ Millennials”, essa è scesa in piazza agendo mitopoieticamente la sospensione del tempo costituito e prefigurando dispositivi di conflitto e forme decisionali nuove e possibili, all’altezza della composizione che il movimento stesso esprimeva. Contro la legalità invocata dalle istituzioni nazionali e la legittimità attribuita d’en haut da Bruxelles (scoglio sui cui la sinistra politica e parlamentare si è completamente dissolta), il movimento esprimeva materialmente il senso della dialettica che abbisogna al dualismo costituzionale: un contropotere trasversale, multinazionale, in grado di prodursi in colorate proteste così come in momenti di conflitto con le forze dell’ordine.
Secondo il filosofo non solo è possibile, ma soprattutto è necessario ripensare le categorie politiche a partire dal piano europeo. La lotta per la democrazia in Europa è centrale nelle nuove dinamiche che la lotta di classe assume oggi. Riprendiamo l’Oxi come modello del conflitto a venire: nel riconoscimento trans-nazionale che la composizione trasversale della soggettività europea operò nei confronti del referendum, esso si trasformò in una vera e propria manifestazione di parrhesia transnazionale: la voice scelta dai governati fu la voce degli sfruttati, dei poveri, di quei segmenti le cui condizioni la governance della crisi ha peggiorato, che individuò il voto greco leggendone le potenzialità post-rappresentative ed immediatamente conflittuali. Nell’Europa dei risentimenti xenofobi quello fu un momento di assoluta democrazia immediatamente soffocata. Ma è necessario riprodurre le condizioni che portarono all’affermazione di una potenza costituente immediatamente transanzionale e collettiva. In questo senso la lotta di classe sul piano europeo può dislocarsi solo a partire dalla produzione di innovazioni democratiche post-sovrane e dalla tensione meticcia e cosmopolitica che anima le molteplici istanze sociali diffuse nel continente. Le condizioni della conflittualità diffusa partono proprio dal concetto di cittadinanza politica che Balibar ha sviluppato negli anni, in grado di coniugare i diritti fondamentali di espressioni con le condizioni di equità e uguaglianza sociale che sono proprie dei processi democratici: l’egalibertè diventa infatti una prima forma di “controdemocrazia”, per usare il termine di Pierre Rosanvallon, ossia di rottura nei confronti dei dispositivi di potere. Programmatica diventa allora l’apertura di un momento costituente europeo, che si ponga oltre le secche del costituzionalismo nazionale: la riappropriazione del momento decisionale collettivo segnerebbe non solo la fase destituente del presente, ma anche il kairos della democrazia come processo di autogoverno molecolare e collettivo, in grado di invertire la serie politologica classica per cui è la forma di governo che produce il proprio soggetto, che alla fine lo legittima: reiventare processi democratici di riappropriazione di tempi e spazi dell’agire politico, nonché di redistribuzione della ricchezza socialmente prodotta, significa costruire un “multiversum” politico, che acquisti un segno di parte nel momento stesso in cui viene fatto proprio dalla praxis collettiva. Significa reinventare le forme politiche di costruzione di un soggetto collettivo in grado di aprire percorsi conflittuali per i diritti collettivi e costruire vettori autonomi di contro-potere sganciati dalla tecnocrazia: in poche parole, opporre politique a police, il dualismo costituzionale al tentativo di accentramento di poteri in corso. E lasciare eccedere questo dualismo dai tentativi di neutralizzazione e repressione. Esempio può essere la diffusione compiutamente europea che il movimento francese della “Nuit debut” si è immediatamente dato: espressione di quella forza lavoro intellettuale pauperizzata, precarizzata e normalizzata dalle categorie mediatiche come “ Generazione Erasmus” o “ Millennials”, essa è scesa in piazza agendo mitopoieticamente la sospensione del tempo costituito e prefigurando dispositivi di conflitto e forme decisionali nuove e possibili, all’altezza della composizione che il movimento stesso esprimeva. Contro la legalità invocata dalle istituzioni nazionali e la legittimità attribuita d’en haut da Bruxelles (scoglio sui cui la sinistra politica e parlamentare si è completamente dissolta), il movimento esprimeva materialmente il senso della dialettica che abbisogna al dualismo costituzionale: un contropotere trasversale, multinazionale, in grado di prodursi in colorate proteste così come in momenti di conflitto con le forze dell’ordine.
Questo contropotere democratico si vuole post-sovrano, pacifico e inclusivo, dando così spazio alle mille teste dell’uno e dei molti. Anche le esperienze municipali di Barcellona e Napoli, in mezzo a molti limiti dettati dall’ipertrofia della macchina amministrativa, stanno materializzando queste forme che la democrazia a venire può assumere. Per dirla con il filosofo, è il passaggio tra la logica hobbesian-hegeliana della rappresentazione, dell’espropriazione della potentia a rafforzamento della potestas sovrana, alla logica dell’espressione, della connessione dei desideri singolari all’interno delle dinamiche di ricombinazione e coalizione collettiva: ma non di sole genealogie filosofiche ha bisogno la democrazia europea a venire, ma come ci suggerisce in conclusione Balibar, della lotta di classe, agìta dal basso, che sappia rompere le meccaniche del governo e della rassegnazione per reinventare conflitti e forme istituzionali all’altezza delle sfide e dei bisogni che il presente impone. La strada è ardua ma vale la pena di percorrerla, non solo per l’avanzata del nemico alle porte, sia esso il fascismo in veste religiosa o tradizionale, ma, sottolineando la postura etica benjaminiana che attraversa l’intero saggio del filosofo, pronunciandosi per quest’epoca pur non avendo più illusioni per essa.