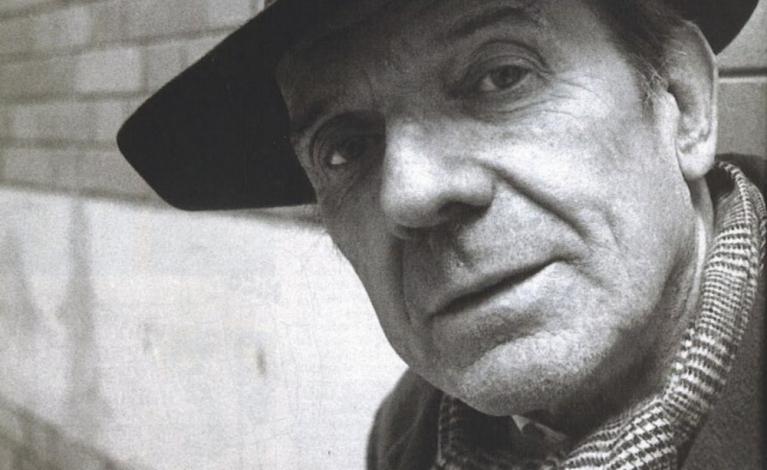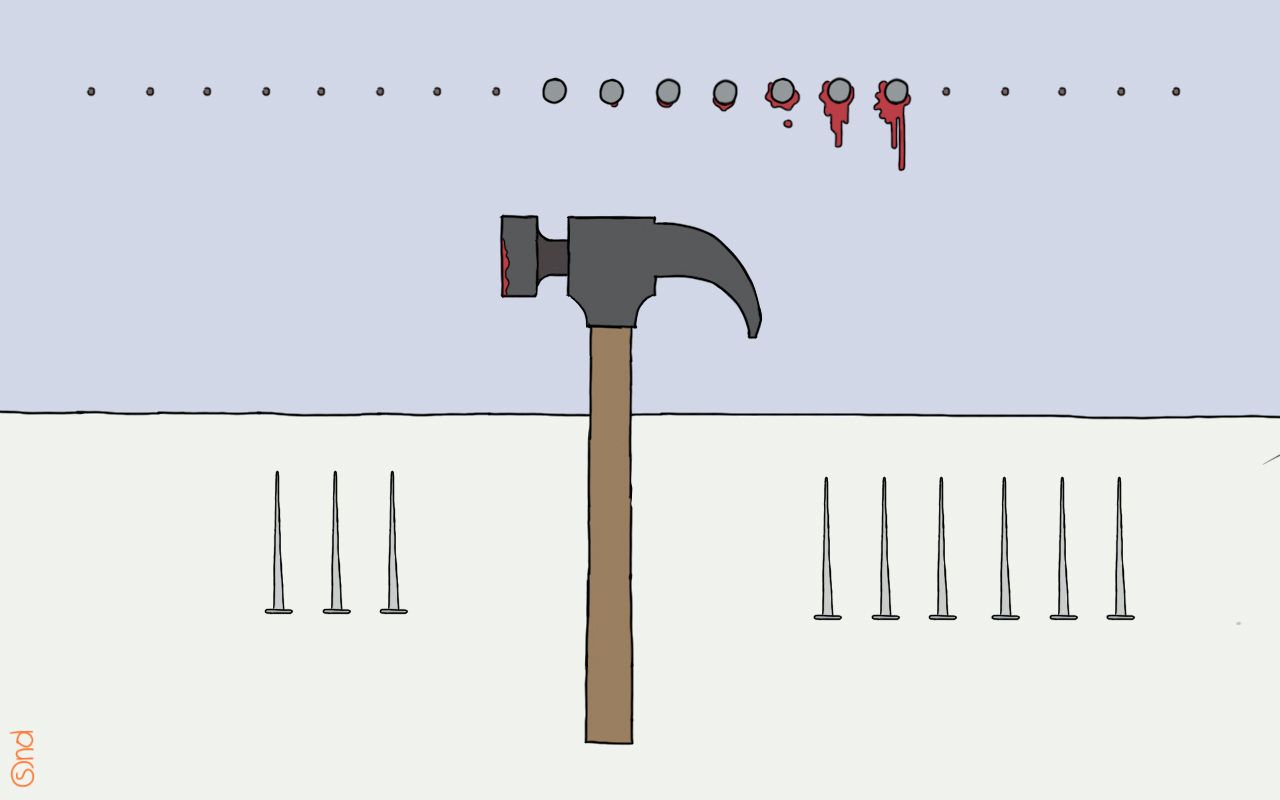Di BENEDETTO VECCHI
Un pensiero irregolare, meglio tentacolare quello che propone Donna Haraway nel suo attraversamento critico della filosofia contemporanea alla ricerca e svelamento di quella «natura sociale» esito ultimo della storia umana che una pessima saggistica ha qualificato come era dell’antropocene.
IL PERCORSO della studiosa femminista è stato anche accidentato dopo che la sua teoria sul cyborg era stata rapidamente consegnata agli archivi perché consapevole che quell’ibrido tra macchina e organico non era scandito da relais, microprocessori, ma da manipolazioni genetiche, di dna ricombinato, di chimica iniettata in un vivente per modificarlo irreversibilmente, strappandolo alla sua presunta naturalità. Ne era nato un libro eccentrico, difficile da leggere e da incastonare in un puzzle teorico-filosofico. «L’oncotopo» di Donna Haraway, pubblicato meritoriamente da Feltrinelli (2000), aveva, ha il sapore acido del materiale grezzo, acerbo, che deve ancora maturare.
Poi della filosofa si erano perse le tracce, nonostante la sua propensione errante, più che nomade. Sempre alla ricerca di un adeguato posizionamento rispetto ai temi e agli argomenti affrontati, Donna Haraway è entrata in relazione con gruppi di ricerca scientifica, associazioni militanti ambientaliste, gruppi solidali e eco-femministi provando a stabilire nessi, associazioni mentali e cognitive al fine di sviluppare un punto di vista forte sul presente a partire dalla cancellazione e il venire meno di una dicotomia che pure molte attenzioni ha avuto da questa teorica eccentrica e irregolare, vale a dire la polarità tra natura e cultura.
NE ERA NATA una raccolta di saggi finalmente tradotta da Angela Balzano per DeriveApprodi con il titolo Le promesse dei mostri (pp. 176, euro 15), dove i mostri non hanno nulla di terrificante, bensì sono presentati come la possibilità di una liberazione da forme di sfruttamento e di colonizzazione mercantile del vivente. Il mostro è annuncio di libertà e non di pervertimento da parte della scienza di un’autenticità umana. La scienza, come la tecnologia, è al tempo stesso strumento di oppressione ma anche di possibile libertà, invenzione, creazione di altri mondi, rompendo le gabbie delle forme viventi codificate come normali. Argomenti che sono ora ripresi in Chthulucene (Nero edizioni), dove la filosofa accentua e radicalizza i temi di tutta la sua opera. Tra i due libri il legame è forte. Il primo è preparatorio e complementare del secondo, che lo riprende ma lo «tradisce», lasciando cadere argomenti come ormai superati dall’incedere del pensiero, come ad esempio il concetto di postumano, che Donna Haraway archivia come espressione di una teoria adolescenziale della contemporaneità capitalista.
Come ogni esplorazione di un nuovo mondo che si rispetti c’è comunque bisogno di un punto di partenza: l’irreversibilità della scienza nella vita associata. La scienza, il fare scienza non significa solo definire progetti, obiettivi e verificare i potesi, bensì è un modo di intendere e definire le relazioni e i rapporti sociali. La scienza, nel suo presentarsi come tecnostruttura è un fattore performativo dello stare in società. Questo è evidente proprio nella manipolazione genetica del vivente, che non solo lo modifica, ma ne definisce il rapporto con le altre specie viventi.
PUNTO DI PARTENZA, però, perché quel che emerge nella esplorazione, e nell’erranza intellettuale di Haraway, è che la scienza diviene una sorta di vera e propria seconda natura, o meglio prototipo e rappresentazione della «natura sociale», di quel cambiamento intervenuto dove la natura ha perso lo stigma iniziale di mondo a parte rispetto la cultura per divenire l’habitat modificato irreversibilmente dall’intervento umano. Ma su questo crinale, interviene la prima fiammata polemica.
Donna Haraway si scaglia contro la tematica dell’antropocene, contro le tesi di chi sostiene che l’intervento umano sulla natura è irreversibile, avendo provocato cambiamenti che hanno alterato gli equilibri biologico e ambientale. La filosofa non nega che questo sia accaduto: soltanto sostiene che è sempre stato così. L’umano cambia la natura da sempre e ogni cambiamento è irreversibile. L’antropocene conferma dunque ciò che è ovvio.
L’ALTRO SPUNTO CRITICO è riservato alla tematica del capitalocene, cioè al fatto che sia il capitale il soggetto iniziale e finale delle trasformazioni dell’ambiente. Anche qui, non viene negata l’azione performativa dei rapporti sociali capitalistici, ma ne è ridimensionata la portata. Il capitale non è un fattore irreversibile, una gabbia che impedisce alternative o che predefinisce tendenze e linee del suo sviluppo. C’è infatti sempre l’azione di resistenza e invenzione dell’umano nel poter immaginare altri mondi.
Da questo punto di vista, le pagine dedicate alla fantascienza speculativa (il futuro come possibile altrove), al pensiero speculativo, alla filosofia immaginifica sono mirabili nella loro eleganza politica. Non solo perché emergono dalle nebbie della metafisica i nomi di Ursula Le Guin, di Marx, di Isabelle Stengers in quanto coordinate per orientare la navigazione, ma anche per segnalare che il pensiero anche se errante può stabilire nessi, relazioni, associazioni che contribuiscono appunto ad afferrare la bestia del presente non per addomesticarlo, ma per indirizzarlo in una prospettiva appunto di liberazione.
In molti lamentano la difficoltà di lettura, di traduzione dei testi di Haraway. Su questo, c’è poco da dire, se non specificare che ogni lavoro di traduzione è un lavoro di contestualizzazione dei testi ma anche di definizione politica della posta in gioco. Quella che sta alla base del lavoro di Donna Haraway è il posizionarsi criticamente, assieme ad altri, rispetto al mondo dato. Non cercando impossibili sintesi, ma convergenze, punti di contatto, definizioni di ambiti di lavoro comune. Come il capitalismo è patchy, cioè irregolare, asimmetrico, che tende a una totalità ma che si alimenta di differenze, anche un punto di vista politicamente critico non può che nutrirsi di differenze, di irregolarità, di fila che si tessono senza avere la certezza che reggano le prove della messa in comune. La politica sta proprio in quell’operazione che Haraway chiama «del compostare».
Il compost nasce da scarti, direbbe l’accorto e altezzoso ingegnere. Prevede un lungo lavoro di macerazione. E il compostare prevede un lungo lavoro di invenzione, di condivisione, di messa in comune di sapere, esperienza, all’interno della produzione di un immaginario di libertà e di liberazione (la fantascienza speculativa di Le Guin, ma non solo).
C’È DUNQUE TEORIA, esperienza, produzione di immaginario nel compostare fattori indistinguibili ormai in un capitalismo e in una realtà che tende a essere presentata come una totalità anche se si nutre di differenze e differenziazioni. Il virtuosismo del compostare sta nel presentare come convergenti sia le esperienze (la relazionaità), il pensiero dell’altrove (immaginario) e la teoria. Sta in questo compost la forza dei mostri promessi e annunciati. E del Chtulucene, cioè di un aracnide forse inventato, forse storpiato nel lessico, forse solo evocato come un altro mondo non possibile, ma nato dentro il lento e incessante lavoro politico appunto del compostaggio.
Questo articolo è stato pubblicato su il manifesto il 5 novembre 2019