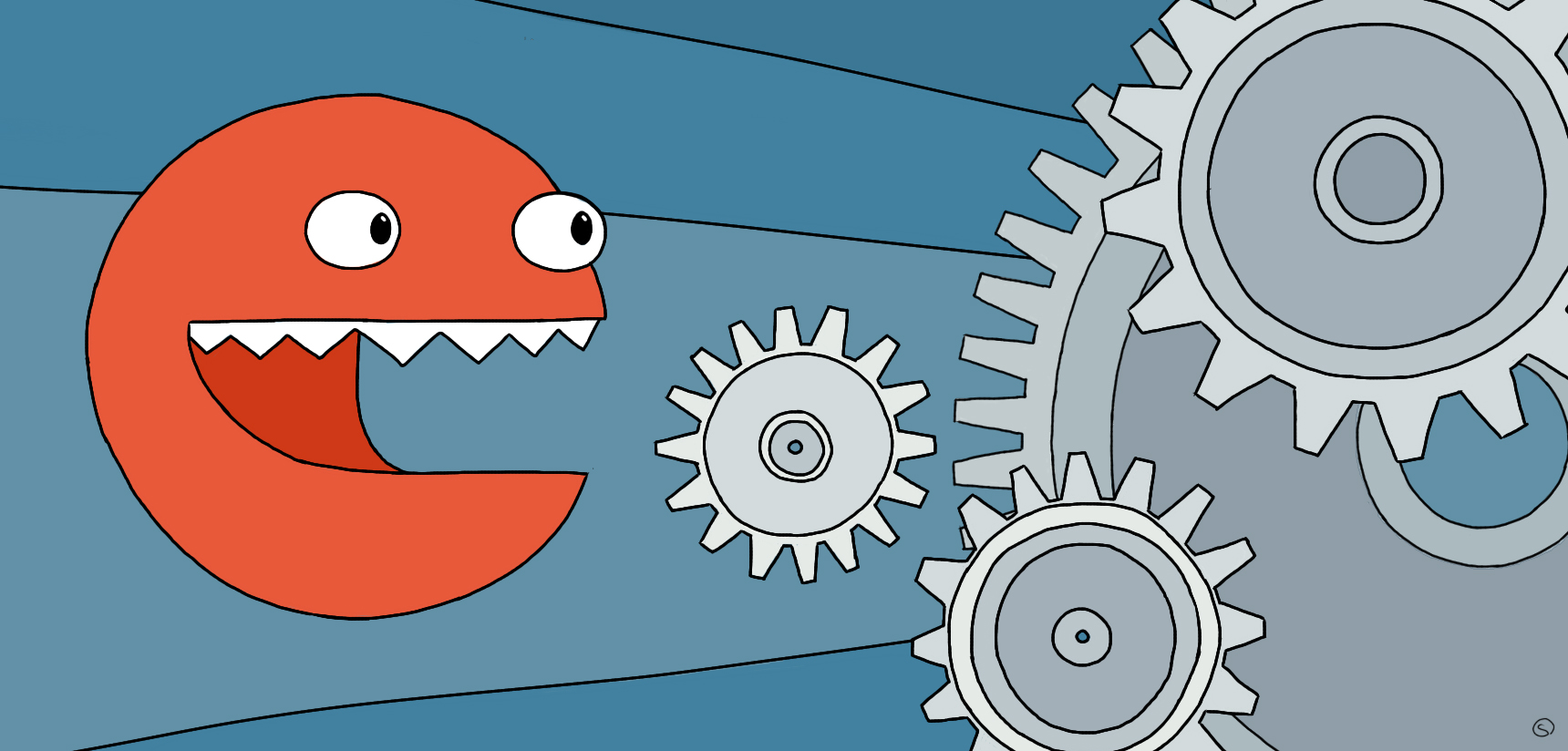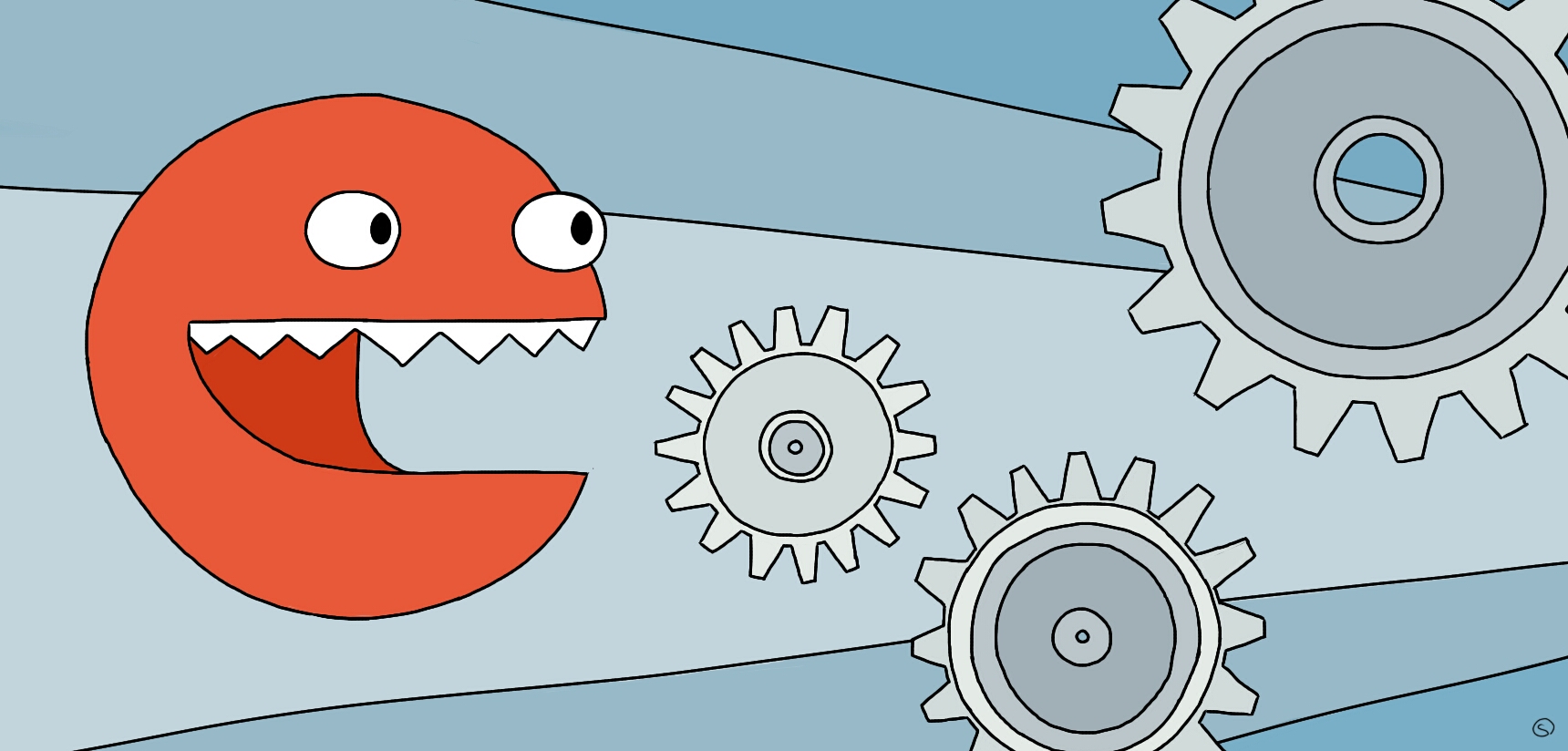di CARLO VERCELLONE.
Lo scopo di quest’articolo è di caratterizzare, nel quadro teorico post-operaista, il senso logico e storico della marxiana legge del valore, nel passaggio dal capitalismo industriale al capitalismo cognitivo. In questa prospettiva, l’analisi si svilupperà in tre stadi. Nel primo si proporrà di precisare cosa bisogna intendere per legge del valore/tempo di lavoro e in cosa consiste la sua articolazione alla legge del plusvalore di cui è una variabile dipendente e storicamente determinata. In riferimento a questa articolazione utilizzeremo la nozione di legge del valore/plusvalore. Nel secondo e nel terzo stadio, l’attenzione sarà focalizzata sulle principali dinamiche che spiegano la forza progressiva della legge del valore/plusvalore nel capitalismo industriale, quindi la sua crisi nel capitalismo cognitivo.
1. Due principali concezioni della legge del valore-lavoro
Nella tradizione marxista coabitano, come rileva Negri (1992), due concezioni della teoria del valore. La prima insiste sul problema quantitativo della determinazione della grandezza del valore. Essa considera il tempo di lavoro come il criterio di misura del valore delle merci. E’ quella che chiamiamo la teoria del valore tempo di lavoro. Questa concezione è ben definita, per esempio, da Paul Sweezy, quando afferma che in una società mercantile-capitalistica “il lavoro astratto è astratto soltanto nel senso, dichiarato nettamente, che sono ignorate tutte le caratteristiche speciali che differenziano un genere di lavoro dall’altro. In definitiva, l’espressione lavoro astratto, come risulta chiaramente dallo stesso uso che ne fa Marx, equivale a lavoro in generale; è ciò che è comune a ogni attività produttiva umana” (Sweezy, 1970, p. 35). In questa visione, la legge del valore è concepita essenzialmente come une legge astorica della misura e dell’equilibrio che regge l’allocazione delle risorse. La nozione di lavoro astratto diviene quasi una categoria naturale, una semplice astrazione mentale, libera da tutte le caratteristiche che, dall’alienazione mercantile all’espropriazione dell’atto del lavoratore, ne fanno una categoria specifica del capitalismo. Abbiamo qui un approccio più ricardiano che marxiano alla teoria del valore-lavoro, la cui genealogia rinvia a un ipotetico modo di produzione mercantile semplice per estendersi in seguito al capitalismo.
La seconda concezione insiste sulla dimensione qualitativa del rapporto di sfruttamento su cui riposa il rapporto capitale-lavoro, rapporto che presuppone la trasformazione della forza-lavoro in merce fittizia. E’ quella che si può chiamare teoria del valore/plusvalore. Essa concepisce il lavoro astratto come sostanza e fonte del valore in una società capitalistica retta dallo sviluppo delle relazioni mercantili e dal rapporto antagonistico capitale-lavoro. Notiamo che in Marx la legge del valore-lavoro è infatti concepita direttamente in funzione della legge del plusvalore e non ha nessuna autonomia rispetto a quest’ultima, cioè alla legge dello sfruttamento. A tal proposito, la stessa scelta molto controversa di Marx, nel primo capitolo del libro I del Capitale, di partire dall’analisi della merce, non ha nulla a che vedere con l’ipotesi di una società mercantile semplice che avrebbe preceduto il capitalismo. Deriva, invece, dalla necessità di mostrare come la trasformazione della forza-lavoro in una merce fittizia – e dunque l’articolazione fra il suo valore di scambio e il suo valore d’uso (il lavoro stesso) – spieghi il mistero dell’origine del profitto. Insomma, in Marx non c’è nessun feticismo riguardante la legge del valore/tempo di lavoro, in quanto legge dello scambio di equivalenti, che ne farebbe una sorta di invariante strutturale del funzionamento dell’economia. Al contrario, la legge del valore-plusvalore deve essere qui pensata, innanzitutto sul piano macroeconomico dell’opposizione fra capitale sociale e lavoratore collettivo e non come una problematica della determinazione della misura del valore delle merci individuali. Questa lettura – ci sembra – è tanto più pertinente in quanto, come osserva Hai Hac “il capitale è indifferente al valore delle merci che produce, poiché ciò che gli interessa è solo il plusvalore di cui il valore è portatore. Inoltre, nella misura in cui il plusvalore cresce con lo sviluppo della forza produttiva del lavoro sociale, il valore decresce in ragione dello stesso movimento, c’è dunque uno stesso processo che abbassa il valore delle merci ed eleva il plusvalore che esso contiene” (Hai Hac, p. 265, Tome I).
A partire da questa seconda concezione, nel prosieguo di questo articolo, ci proponiamo di caratterizzare la genesi e il dispiegamento storico della legge del valore/plusvalore, poi il senso e le poste in gioco della sua crisi in un’economia fondata sul ruolo motore del sapere e della sua diffusione.
1.2 Dalla legge del plusvalore alla legge del valore fondato sul tempo di lavoro
Cominciamo dunque con il definire la legge del plusvalore. Essa esprime in effetti la razionalità economica del capitalismo nella sua essenza, indipendentemente dalla sua forma storicamente determinata: quella di essere un sistema orientato verso l’accumulazione illimitata del capitale. Ritroviamo questa idea nella celebre formula generale del Capitale di Marx (D-M-D’), in cui la valorizzazione del capitale è un processo che non conosce limiti nella misura stessa in cui il suo obbiettivo non è né il consumo né il valore d’uso, ma l’accumulazione della ricchezza astratta rappresentata dal denaro. La merce e la produzione sono per il capitale dei meri strumenti per raggiungere questo scopo, cioè l’accumulazione del denaro in quanto tale, e ciò al fine di aumentare incessantemente il potere di comando che il denaro gli conferisce sulla società e sul lavoro (fonte e sostanza del valore), permettendogli di appropriarsi (in modo diretto o indiretto) di un plusvalore.
In questo senso, seguendo A. Negri (1979 & 1996), si può affermare che la legge del plusvalore si presenta di primo acchito e in modo indissociabile come una legge dello sfruttamento e dell’antagonismo. Essa è anteriore e precede, da un punto di vista sia logico che storico, la legge del valore che fa del tempo di lavoro astratto la misura del lavoro e del valore delle merci. Quest’ultima è solo un sottoprodotto e una variabile dipendente della legge del plusvalore. L’origine e il senso storico della legge del valore/ tempo di lavoro sono strettamente legati alla configurazione del rapporto capitale-lavoro che si sviluppa con la rivoluzione industriale. E’ in questa congiuntura storica che la razionalità economica del capitale, cioè la legge del plusvalore, assume in effetti il controllo diretto e afferma la sua presa tanto sulla sfera della produzione che su quella dei bisogni, dando impulso progressivamente a una logica di produzione/consumo di massa di merci.
In questo quadro, la legge del valore/tempo di lavoro si afferma, (prima ancora che l’economia politica dei classici elabori la teoria del valore-lavoro), come l’espressione concreta di una pratica gestionale di «razionalizzazione» della produzione e di astrazione del contenuto stesso del lavoro, che ha fatto del tempo dell’orologio, poi del cronometro, i mezzi per eccellenza per quantificare il valore economico scaturito dal lavoro, prescriverne i modi operativi e aumentarne la produttività. L’omogeneizzazione del lavoro che risulta dalla sua scomposizione in compiti elementari si presenta in effetti, all’interno delle imprese, come il mezzo congiunto del suo controllo e del calcolo economico. Essa permette di ottimizzare il rapporto fra l’input e l’output misurati in tempi di lavoro “uomini e macchine”, pagando, come sottolineava già Babbage, il salario più basso per ogni mansione. Allo stesso tempo, la legge del valore/tempo di lavoro assicura, in funzione del tempo di lavoro socialmente necessario, la regolazione a posteriori dei rapporti di concorrenza legati all’attività decentralizzata di unità produttive indipendenti le une dalle altre.
2. Razionalità economica del capitale e legge del valore-plusvalore nel capitalismo industriale
Su questa base siamo dunque in grado di caratterizzare con una certa precisione ciò che si può chiamare la razionalità economica della legge del valore/plusvalore che ha segnato lo sviluppo del capitalismo industriale.
Su un piano generale, questa razionalità economica riposa su una concezione produttivistica e puramente quantitativa della crescita della produzione e della produttività. Può essere definita come una logica che consiste nel fabbricare e vendere merci allo scopo di massimizzare il profitto producendo sempre di più, con meno ore di lavoro e con meno capitale (Gorz, 1989). Per questo, come notava già Marx nei Grundrisse, “Il capitale è esso stesso la contraddizione in processo: da una parte, si sforza di ridurre il tempo di lavoro [necessario alla produzione delle merci] a un minimo, e dall’altra pone il tempo di lavoro come la sola fonte e la sola misura della ricchezza”. (Marx, 1980, p.194). Insomma, è lo sviluppo stesso della razionalità della legge del valore/plusvalore che, spingendo al limite la propria logica, conduce in modo endogeno al suo esaurimento e alla crisi.
Ma più precisamente, per concetto di razionalità economica della legge del valore/plusvalore bisogna intendere due dimensioni complementari (due dimensioni il cui esaurimento sta al cuore della crisi attuale).
Secondo la prima dimensione, la legge del valore designa il rapporto sociale che fa della logica della merce e del profitto il criterio chiave e progressivo dello sviluppo della ricchezza sociale e della soddisfazione dei bisogni. Notiamo che questa logica presenta, su più piani, un’ambivalenza economica, sociale e politica essenziale, un’ambivalenza che, come notava A. Gorz (1988), ha nutrito l’ideologia del progresso del capitalismo industriale permettendogli di ottenere anche l’adesione da parte di settori consistenti del movimento operaio e socialista, a prezzo dell’abbandono di ogni critica della divisione capitalistica del lavoro e dell’alienazione nella sfera del lavoro e dei bisogni. In cosa consiste questa ambivalenza?
Consiste nel fatto che la diminuzione continua del tempo di lavoro necessario alla produzione di massa di merci materiali, dunque il calo del loro valore unitario, ha potuto in effetti presentarsi come lo strumento che permetteva di «liberare l’umanità della scarsità» soddisfacendo in tal modo una massa crescente di bisogni, poco importa se veri o superflui. Questo aspetto «progressivo» della razionalità del capitale si presentava anche, almeno in potenza[2], come il mezzo per ridurre gradualmente il tempo di vita dedicato al lavoro salariato a un minimo. In tale logica è presente, insomma, una dimensione utopica –lo sviluppo delle forze produttive come strumento di lotta contro la scarsità– su cui il capitalismo industriale ha potuto edificare una sorta di legittimità storica, i cui fondamenti saranno tuttavia profondamente destabilizzati nel capitalismo cognitivo.
La seconda dimensione della razionalità economica della legge del valore/plusvalore concerne la sua applicazione all’organizzazione della produzione. In essa si rinviene l’origine della norma che, nel senso di Marx, fa del tempo di lavoro astratto, misurato in unità di lavoro semplice, non qualificato, la sostanza del valore delle merci e lo strumento congiunto di valutazione, controllo e prescrizione del lavoro. Per comprendere l’instaurazione e l’approfondimento progressivo di questa norma occorre partire dall’incertezza strutturale che caratterizza lo scambio capitale-lavoro. L’acquisto e la vendita della forza-lavoro ruotano, in effetti, sulla messa a disposizione di una quantità di tempo e non sul lavoro effettivo dei salariati. Tale aspetto dell’analisi marxiana[3] è espresso in maniera estremamente consona da P. Virno (2008) mediante la distinzione fra il concetto di potenza e quello di atto. Ciò permette di comprendere due ordini di ragioni essenziali per cui i rapporti di sapere e di potere, che si annodano intorno all’organizzazione della produzione costituiscono un elemento essenziale dell’antagonismo capitale-lavoro.
Il primo si esplica nella facoltà di controllare l’intensità e la qualità del lavoro da parte di coloro che, detenendo conoscenza e savoir-faire, possono dettare i tempi e le modalità operative. Il secondo consiste nel fatto che quanti detengono le potenze intellettuali della produzione possono egualmente aspirare a gestirne la regolazione collettiva, cioè a definire le stesse finalità sociali della produzione, rispondendo alle questioni fondamentali del come produrre, del cosa produrre e per chi.
Siamo in presenza di una posta in gioco centrale che sta già al cuore della riflessione dei primi grandi teorici della rivoluzione industriale, come Ure e Babbage. Questa riflessione sarà ripresa e sistematizzata da Taylor confrontandosi con il potere della composizione di classe dell’operaio professionale nelle industrie motrici della seconda rivoluzione industriale. Taylor, pur riconoscendo che il «sapere è il bene più prezioso» di cui dispongono gli operai di fronte al capitale, ne farà il bersaglio esplicito nella sua analisi delle loro pratiche sistematiche di rallentamento della produzione. Ne dedurrà la necessità di far emergere ed espropriare gli operai delle loro conoscenze tacite, per convertirle, mediante lo studio dei tempi e dei movimenti, in un sapere codificato detenuto dal management e rinviato ai salariati, sotto forma di prescrizione stretta dei tempi e delle procedure operative. Taylor penserà di aver così posto le basi irreversibili di un’organizzazione scientifica del lavoro che sopprima ogni incertezza sull’esecuzione del contratto di lavoro, garantendo al capitale la pianificazione ex ante della legge del valore-plusvalore. In tal modo, nella fabbrica taylorista, la misura del lavoro e della produttività, così come il volume e il valore della produzione, erano, in via di principio, programmati e conosciuti in anticipo dagli ingegneri degli uffici tempi e metodi. L’insieme di questi indicatori poteva, così, essere ricondotto a un’unità nota e omogenea di calcolo in termini di tempo che forniva anche un indicatore abbastanza preciso del tasso di sfruttamento. La norma industriale del tempo di lavoro astratto incarnava, inoltre, l’utopia capitalistica e manageriale di un’organizzazione produttiva capace di privare il lavoro di ogni autonomia e di ogni dimensione cognitiva. Si poteva ritenere di trasformarla nel suo contrario, cioè in un’attività in via di principio puramente meccanica, ripetitiva, impersonale e totalmente asservita alla scienza incorporata nel capitale fisso. Abbiamo qui la tendenza che Marx caratterizza come logica della sussunzione reale del lavoro al capitale. Tuttavia questa tendenza, che ha trovato per molti aspetti il suo compimento storico nei modelli di crescita fordista e della grande impresa manageriale, resterà sempre imperfetta. Un nuovo tipo di sapere tenderà incessantemente a ricostituirsi al livello più elevato di sviluppo della divisione tecnica e sociale del lavoro.
Si osservi che Marx stesso aveva ben identificato l’esasperazione dei conflitti sui rapporti di sapere/potere e sul controllo delle potenze intellettuali della produzione, di cui era portatrice la logica della sussunzione reale, quando in un celebre passo del primo libro del Capitale notava: “Per la grande industria diventa questione di vita o di morte sostituire quella mostruosità che è una miserabile popolazione operaia disponibile, tenuta in riserva per il variabile bisogno di sfruttamento del capitale, la disponibilità assoluta dell’uomo per il variare delle esigenze del lavoro; sostituire all’individuo parziale, mero veicolo di una funzione sociale di dettaglio, l’individuo totalmente sviluppato, per il quale le differenti funzioni sociali sono modi di attività che si danno il cambio l’uno con l’altro” (Il Capitale, ed. Rinascita, Roma 1956, libro I, 2, cap. 13, p. 201).
Nella congiuntura storica che ha portato alla crisi del fordismo, questa dinamica si è espressa attraverso i conflitti che hanno condotto alla formazione di un’intellettualità diffusa e allo sviluppo dei servizi collettivi del Welfare (sanità, educazione, ricerca) al di là delle compatibilità della regolazione fordista. Sono state così poste le condizioni alla base del decollo di un’economia fondata sul ruolo motore del sapere e sulla sua diffusione.
Bisogna sottolineare a tal proposito un punto essenziale per caratterizzare in modo adeguato la genesi e la natura del capitalismo cognitivo. La messa in opera di un’economia fondata sulla conoscenza precede e si oppone, da un punto di vista tanto logico quanto storico, alla formazione del capitalismo cognitivo. Quest’ultimo è il risultato di un processo di ristrutturazione mediante il quale il capitale tenta di assorbire e sottomettere, in modo parassitario, le condizioni collettive della produzione delle conoscenze, soffocando il potenziale di emancipazione iscritto nella società del general intellect. Per capitalismo cognitivo si intende allora, il passaggio del capitalismo industriale a una nuova fase del capitalismo, in cui la dimensione cognitiva e immateriale del lavoro diventa dominante dal punto di vista della creazione di valore e della competitività delle aziende. In questo quadro la posta in gioco centrale della valorizzazione del capitale e delle forme della proprietà poggia direttamente sull’appropriazione rentière del comune e sulla trasformazione della conoscenza in una merce fittizia (Negri e Vercellone, 2008).
3. La crisi della legge del valore-plusvalore nel capitalismo cognitivo
La trasformazione maggiore che, dalla crisi del fordismo in poi, segna una uscita dal capitalismo industriale si trova proprio nel ritorno in forza della dimensione cognitiva e intellettuale del lavoro. Va notato che questa ascesa del lavoro cognitivo è lungi dall’essere appannaggio di una élite di lavoratori della ricerca e sviluppo (R&D) o dei settori ad alta intensità di conoscenze e informazione. Essa si manifesta in ogni attività produttiva, materiale o immateriale (due dimensioni d’altronde spesso inestricabili); riguarda altresì quelle a debole intensità tecnologica, come mostra la crescita degli indicatori di autonomia del lavoro e la diffusione delle funzioni di produzione di conoscenze e di trattamento dell’informazione nell’insieme dell’economia.
Certo, esistono delle controtendenze; la storia non è un processo lineare, ma procede per accavallamenti e ibridazioni. Così la tendenza verso una nuova organizzazione cognitiva della produzione non segna, ipso facto, la fine del taylorismo, neppure nel campo del lavoro intellettuale. Il capitale si sforzerà sempre di limitare il più possibile il controllo reale esercitato dai lavoratori sul loro lavoro. Nel nuovo capitalismo, differenti modelli produttivi continueranno a coesistere e intrecciarsi. Nondimeno, come mostra la recente inchiesta condotta sulle condizioni di lavoro in Europa dall’European Foudantion for the Improvement of Living and Working Conditions, è la forma di organizzazione cosiddetta di tipo intelligente (Learning Organisation) che svolge sempre più un ruolo egemonico rispetto ad altri modelli produttivi (Merllié et Paoli 2001).
Più in generale, questa evoluzione corrisponde, nelle imprese come nella società, all’affermazione di una nuova preponderanza qualitativa delle conoscenze viventi, incorporate e mobilitate dai lavoratori, rispetto ai saperi formalizzati, incorporati nel capitale fisso e nell’organizzazione manageriale delle ditte. Essa è strettamente associata a una serie di tendenze che segnano la crisi della legge del valore/plusvalore e a quello che chiamiamo «il divenire rendita del profitto».
Che cosa bisogna intendere per crisi della legge del valore? Tale crisi si presenta, in primo luogo, come una perdita di pertinenza delle categorie fondamentali dell’economia politica del capitalismo industriale: il capitale, il lavoro e beninteso il valore. Fondamentalmente, essa corrisponde all’esaurimento di quelle due dimensioni della razionalità economica della legge del valore/plusvalore su cui, come abbiamo visto, il capitalismo industriale aveva potuto affermare il suo dominio sul lavoro e trovare una sorta di legittimità storica, come strumento di lotta contro la scarsità.
3.1 Esaurimento della razionalità economica del capitale e dissociazione del valore dalla ricchezza
La prima dimensione corrisponde dunque all’esaurimento della legge del valore/tempo di lavoro pensata come criterio di «razionalizzazione» capitalistica della produzione che fa della norma del lavoro astratto, misurato in unità di lavoro semplice, non qualificato, lo strumento congiunto della valutazione e della sussunzione reale del lavoro al capitale. L’aumento di potenza della dimensione cognitiva del lavoro determina, in questo senso, una doppia crisi della legge del valore.
Una crisi della misura, poiché il lavoro cognitivo è un’attività che si sviluppa sull’insieme dei tempi di vita[4]. Il tempo passato e certificato nell’impresa è in genere solo una frazione del tempo sociale effettivo di lavoro. Nel nuovo capitalismo, la fonte principale della creazione del valore si colloca, in effetti, sempre più a monte o a valle della sfera della produzione diretta e dell’universo delle imprese. In questo quadro, non solo le modalità di organizzazione del lavoro sono sempre meno prescrivibili, ma le fonti della competitività dipendono in misura crescente da una cooperazione sociale produttiva che si sviluppa all’esterno dei confini aziendali. Ne risulta inoltre che il profitto, come la rendita, riposa sempre più su meccanismi di appropriazione del plusvalore effettuati a partire da un rapporto di esteriorità del capitale rispetto all’organizzazione della produzione.
Una crisi del controllo, poiché l’incontro fra l’intellettualità diffusa e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione fa della riappropriazione collettiva del lavoro e dei mezzi di produzione una prospettiva di nuovo plausibile, generando potenzialmente conflitti relativi all’autodeterminazione stessa dell’organizzazione del lavoro e delle finalità sociali della produzione. Per questo, in molte attività produttive, il modello taylorista della prescrizione delle mansioni cede il posto a quello della prescrizione della soggettività. Nel contempo, come per la produzione di valore, il controllo sul lavoro si sposta sempre più a valle e a monte dell’atto produttivo stesso, facendo del controllo totale del tempo e dei comportamenti dei salariati la posta in gioco centrale. Esso si concretizza nella moltiplicazione di tutta una panoplia di strumenti di valutazione della soggettività del lavoratore e della sua conformità ai valori dell’impresa, inducendo spesso quelle che in psicologia si chiamano ingiunzioni paradossali[5].
La seconda dimensione rinvia alla crisi della legge del valore pensata come il rapporto sociale che fa della logica della merce e del profitto il criterio chiave e progressivo dello sviluppo della ricchezza sociale e della soddisfazione dei bisogni. Questa crisi si esprime con un divorzio crescente fra la logica del valore e quella della ricchezza. Per meglio comprendere il senso di questa affermazione, occorre ricordare, come per Marx (ma anche per Ricardo), il valore delle merci dipenda dalle difficoltà della produzione e dunque del tempo di lavoro. Il concetto di valore è dunque completamente differente dal concetto di ricchezza, che invece dipende dal valore d’uso (non dal valore di scambio), dall’abbondanza e dunque dalla gratuità[6]. Orbene, la logica capitalistica della produzione mercantile aveva trovato, come si è visto, nel capitalismo industriale, una sorta di legittimità storica nella capacità di sviluppare la ricchezza, producendo sempre più merci con meno lavoro, dunque con prezzi unitari sempre più bassi, consentendo di soddisfare una massa crescente di bisogni. Invece, nel capitalismo cognitivo, quel legame positivo fra valore e ricchezza, fra produzione mercantile e soddisfazione dei bisogni, è spezzato. Ciò significa che la legge del valore, sopravvive ormai come una specie di involucro svuotato di quella che Marx considerava la funzione progressiva del capitale, vale a dire lo sviluppo delle forze produttive come strumento di lotta contro la scarsità, che avrebbe permesso nel lungo periodo di favorire il passaggio dal regno della necessità al regno della libertà.
Numerose evoluzioni del capitalismo cognitivo illustrano questa dissociazione del valore dalla ricchezza[7] che esprime, in ciò che vi è di più essenziale, la perdita progressiva di forza della legge del plusvalore e dell’impossibilità di ristabilirvi intorno una qualche dialettica lotte-sviluppo. Esse rinviano alla contraddizione fondamentale fra la logica di valorizzazione del capitalismo cognitivo e quella intrinsecamente non mercantile dell’economia della conoscenza.
Notiamo che questa contraddizione affonda le radici nelle proprietà particolari del bene comune conoscenza e nel suo carattere irriducibile allo statuto di merce e di capitale. In confronto ai beni classici, le particolarità del bene comune conoscenza consiste, in effetti, nel suo carattere non rivale, difficilmente escludibile e cumulativo. A differenza dei beni materiali, essa non si distrugge nel consumo. Anzi, si arricchisce quando circola liberamente fra gli individui. Ogni nuova conoscenza genera un’altra conoscenza, secondo un processo cumulativo. Per tal motivo l’appropriazione privativa della conoscenza è realizzabile solo stabilendo barriere artificiali al suo accesso. Questo tentativo si scontra però con ostacoli maggiori. Essi riguardano tanto l’esigenza etica degli individui, quanto il modo per cui l’uso delle tecnologie informatiche e comunicative rende sempre più difficile l’esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale. D’altronde, il tentativo di trasformare la conoscenza in una merce fittizia genera una situazione paradossale, una situazione in cui più il valore di scambio della conoscenza aumenta artificialmente, più il suo valore d’uso diminuisce, per il fatto stesso della sua privatizzazione e rarefazione. Insomma, il capitalismo cognitivo può riprodursi solo ostacolando le condizioni oggettive e le facoltà creatrici degli agenti alla base dello sviluppo di un’economia fondata sul sapere e la sua diffusione.
Osserviamo più in generale che per molteplici beni ad alta intensità di conoscenza (software, beni culturali digitalizzati, farmaci, ecc.), i tempi di lavoro e dunque i costi di riproduzione sono molto bassi, talvolta tendenti a zero. Di conseguenza il valore-tempo di lavoro di queste merci dovrebbe tradursi in una diminuzione drastica dei loro prezzi, del valore monetario della produzione e dei profitti associati. Per il capitale diventa allora strategico mettere in opera una politica di rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale, che consenta di costruire artificialmente una scarsità di risorse. Il capitale è così indotto sempre più a sviluppare nuovi meccanismi di rarefazione dell’offerta, nel tentativo di mantenere forzosamente il primato del valore di scambio e salvaguardare i profitti. Tale logica è une delle espressioni principali del divenire rendita del profitto. Ne deriva una situazione che contraddice i principi stessi sui quali i padri fondatori dell’economia politica giustificavano la proprietà come strumento di lotta contro la scarsità. Ormai è la creazione della proprietà a far comparire la scarsità. In un certo senso, si può dunque affermare che è il tentativo stesso di mantenere forzosamente in vigore il primato della logica della merce e del valore di scambio, che conduce il capitale a tentare di emanciparsi dalla legge del valore/tempo di lavoro. Si apre una contraddizione sempre più acuta fra il carattere sociale della produzione e il carattere privato dell’appropriazione, che costituisce una delle maggiori manifestazioni della crisi della legge del valore nell’epoca del capitalismo cognitivo. Questa contraddizione è associata alla forte crescita di forme di captazione del valore fondate sulla rendita.
3.2 Capitale immateriale e produzioni dell’uomo per l’uomo: oltre la forma-valore
L’esaurimento della razionalità della legge del valore/plusvalore implica d’altronde altre manifestazioni cruciali che testimoniano la profondità della crisi del capitalismo e del suo divorzio dai bisogni sociali. Una prima manifestazione concerne il ruolo crescente del capitale cosiddetto immateriale, che rappresenta ormai la parte più considerevole della capitalizzazione borsistica. Orbene, questo capitale, chiamato immateriale, sfugge anch’esso a qualsiasi misura oggettiva in termini di «costi storici» (e dunque in termini di tempo di lavoro necessario alla sua produzione). Il suo valore non può essere che l’espressione della valutazione soggettiva dei profitti anticipati effettuata dai mercati finanziari che in tal modo si accaparrano una rendita. Ciò contribuisce a spiegare perché il valore borsistico di questo capitale è essenzialmente fittizio e sottoposto a fluttuazioni di grande ampiezza. Esso si basa su una logica autoreferenziale, propria della finanza, che alimenta bolle speculative destinate immancabilmente a scoppiare, trascinando l’insieme del sistema creditizio ed economico in una recessione profonda. L’impossibilità di determinare una misura oggettiva e affidabile del capitale immateriale trova altresì conferma nella controversia sull’origine del celebre goodwill (che designa lo scarto crescente fra il valore di mercato delle aziende e il valore dei loro attivi tangibili): il principale attivo immateriale, da cui dipenderebbe il sopravalore incarnato dal goodwill, non sarebbe, di fatto, nient’altro che il «capitale intellettuale» rappresentato dalla competenza, l’esperienza, il sapere tacito, la capacità di cooperazione della forza-lavoro. Insomma, non si tratta di capitale (malgrado la torsione operata dai concetti di capitale intellettuale o di capitale umano), ma in realtà della qualità intellettuale della forza-lavoro. Ora, quest’ultima, per definizione (a meno di ridurla a schiavitù) costituisce un attivo non negoziabile sul mercato. Per questo, come osserva I. Halary (2004), il tentativo di spiegare il goodwill con l’esistenza di attivi immateriali non classificati, resta prigioniero di un ragionamento circolare che non permette di eliminare l’indeterminazione del valore di questi attivi immateriali. Perché circolare? Perché alla domanda: “Da cosa dipende il goodwill?” Si risponde: “Dal capitale umano dell’impresa!” E alla domanda: “Come determinare il valore del capitale umano?” Si risponde: “Con il goodwill!”
Ciò significa che la misura del capitale e il fondamento del suo potere sulla società, dipendono sempre meno dal lavoro passato e dal sapere incorporato nel capitale costante e si fondano ormai principalmente su una convenzione sociale che trova la sua molla principale nel potere della finanza[8].
Una seconda manifestazione è legata al modo in cui le produzioni dell’uomo per l’uomo, assicurate tradizionalmente dal Welfare State secondo una logica non mercantile, sono il principale settore motore di una economia fondata sulla conoscenza. Sono esse che assicurano una parte essenziale del processo di trasmissione e di produzione della conoscenza, e quindi della formazione del cosiddetto capitale immateriale. Di fronte a tendenze stagnazionistiche sempre più profonde, le produzioni dell’uomo per l’uomo rappresentano inoltre uno dei rari settori in cui bisogni e domanda sociale sono in continua espansione. Questi elementi costituiscono uno dei principali indicatori dell’esaurimento della sfera dei bisogni che la logica della merce e del lavoro astratto può soddisfare in modo progressivo. Al tempo stesso, essi contribuiscono a spiegare la pressione straordinaria esercitata dal capitale per privatizzare e mercificare questi servizi collettivi. Le produzioni dell’uomo per l’uomo non possono, tuttavia, essere sottomesse alla razionalità economica della legge del valore/plusvalore, se non al prezzo di uno spreco di risorse e di diseguaglianze sociali profonde che, per di più, rischierebbero di destrutturare le forze creatrici alla base di un’economia fondata sulla conoscenza. Tre argomenti principali corroborano questa tesi. Il primo è legato al carattere intrinsecamente cognitivo, interattivo e affettivo di queste attività in cui il lavoro non consiste nell’agire sulla materia inanimata, ma sull’uomo stesso in una relazione di coproduzione di servizi. Ne consegue, come già suggerito da Marx nei passaggi del Capitolo VI inedito del Capitale dedicati al lavoro immateriale, che le produzioni dell’uomo per l’uomo possono essere difficilmente sussunte alla razionalità produttiva del capitale in quanto la soggettività dei lavoratori, come “il prodotto è inseparabile dall’atto produttore” (Marx, 1867, p. 98). Insomma né l’atto di lavoro né il prodotto (che corrisponde all’uomo stesso nella singolarità di ogni individuo) possono essere veramente standardizzati. L’efficacia in termini di risultato dipende invece da tutta una serie di variabili qualitative legate alla comunicazione, alla densità delle relazioni umane, alla cura disinteressata e quindi alla disponibilità di tempo per l’altro, che la contabilità analitica aziendale è incapace d’integrare se non come costi o tempi morti improduttivi. Il tentativo di elevare la produttività e la redditività di questi servizi collettivi non può dunque essere compiuto che a detrimento della loro qualità e del loro rendimento sociale. Sul piano dell’organizzazione sociale della produzione, siamo insomma qui confrontati a una contraddizione flagrante tra la concezione capitalistica e quantitativa della produttività e la concezione sociale della produttività, che risulta dal carattere intrinsecamente comune di queste attività e del loro risultato materiale e immateriale[9]. Il secondo argomento rinvia alle distorsioni profonde che l’applicazione del principio della domanda solvibile introdurrebbe nel diritto all’accesso a questi beni comuni, inducendo una deteriorazione della qualità collettiva della forza lavoro. Sia per ragioni di giustizia sociale che d’efficacia economica, le produzioni del comune devono insomma fondarsi sulla gratuità e sul libero accesso. Il loro finanziamento non può dunque essere assicurato che attraverso il prezzo collettivo e politico rappresentato dalla fiscalità, dai contributi sociali o da altre forme di mutualizzazione delle risorse. Il terzo argomento é legato alla non esistenza (ad esempio nella salute come nell’educazione) della figura mitica del consumatore che effettuerebbe le proprie scelte sulla base di un calcolo razionale costi/benefici, dettato dalla ricerca della massima efficienza dell’investimento nel proprio capitale umano. Fortunatamente, non é certo questo il criterio principale che anima lo studente nella sua ricerca del sapere. Lo è ancor meno quello del malato che, spesso, è prigioniero di uno stato d’angoscia che lo rende incapace di compiere una scelta razionale e lo predispone, invece, a tutte le trappole di una logica mercantile in cui vendere speranze e illusioni é un mezzo per fare profitti.
Ultima manifestazione, ma non meno importante, la crisi di razionalità della legge del valore che esprime la dinamica del capitalismo cognitivo, non consiste solo nel rendere artificialmente rare risorse di per sé abbondanti e gratuite. Essa si esprime anche nell’accelerazione di una logica di predazione e rarefazione delle risorse naturali non rinnovabili. Di fatto, il capitalismo cognitivo non sopprime la logica produttivistica del capitalismo industriale. La riarticola e rinforza, grazie specialmente a una subordinazione della scienza al capitale che pone, come nel caso degli OGM, le nuove tecnologie al servizio di una strategia di standardizzazione e trasformazione mercantile del vivente che accentua i rischi di distruzione della biodiversità e di destabilizzazione ecologica del pianeta. Più in generale, la crisi ecologica segna su scala planetaria i limiti strutturali di una politica di fuoriuscita dalla crisi che non può in nessun modo fondarsi principalmente sulla coordinazione di mercato e sul rilancio del consumo privato delle famiglie. Essa richiede piuttosto di reinventare una politica di pianificazione democratica del comune, basata su un’autentica socializzazione dell’investimento e dell’innovazione tecnologica in attività che consentano di ripensare l’urbanismo, l’agricoltura, di realizzare economie di energia, ecc. – tutti elementi che, per loro natura, sfuggono in gran parte a una logica mercantile.
Per concludere, l’insieme delle contraddizioni soggettive e oggettive che attraversano il capitalismo cognitivo, segnando la crisi della legge del valore/pluvalore, sono di una tale acutezza da richiamare la situazione descritta da Marx nel 51° e penultimo capitolo del libro III del Capitale, quando affermava: “Si riconosce che è giunto il momento di una tale crisi quando guadagnano in ampiezza e profondità la contraddizione e il contrasto tra i rapporti di distribuzione e quindi anche la forma storica determinata dai rapporti di produzione ad essi corrispondenti, da un lato, e le forze produttive, capacità produttiva e sviluppo dei loro fattori dall’altro” (K. Marx, 1968, pp. 1482-1483).
Bibliografia
Fumagalli A., Morini C., (2009), “La vita messa al lavoro: verso une teoria del valore-vita. Il caso del valore affetto”, in Sociologia del lavoro, N° 115, pp. 94-115.
Gorz A. (1988), Métamorphoses du travail, Quête du sens – Critique de la raison économique, ed. Galilée, Paris.
Gorz A. (2003). L’immatériel : connaissance, valeur et capital, éd. Galilée, Paris.
Gorz A. (2004) «Économie de la connaissance et exploitation des savoirs», entretien avec Moulier-Boutang Y. e Vercellone C., in Multitudes, N° 15, pp. 205-216.
Gorz A, (2008), Ecologica, éd. Galilée, Paris.
Halary I. (2004) « Ressources immatérielles et finance de marché : le sens d’une liaison », papier présenté au Séminaire Capitalisme Cognitif, MATISSE-ISYS, avril, Paris.
Hai Hac Tran (2003), Relire “Le Capital”, Cahiers libres, Editions Page deux, Tomes I et II, Généve.
Hardt M., Negri A. (2010), Comune. Oltre il pubblico e il privato, Rizzoli, Milano.
Marazzi C. (2005), « L’ammortamento del corpo macchina” in Laville JL., Marazzi C., La Rosa M., Chicchi F., (dir) Reinventare il lavoro, Sapere2000, Roma.
Marazzi C. (2010), Il comunismo del capitale, Ombre Corte, Verona.
Marx, K. (1968), Le Capital Livre I, in Œuvres, Economie, Tome I, La Pléiade, Paris.
Marx, K. (1968a), Le Capital Livre III, in Œuvres, Economie, Tome II, La Pléiade, Paris.
Marx, K. (1980), Grundrisse, Tome II, Éditions Sociales.
Merllié D., Paoli P. (2001), Third European Survey on Working Conditions (2000), Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2001/21/en/1/ef0121en.pdf.
Negri A. (1979), Marx oltre Marx, Feltrinelli, Milano.
Negri A. (1992), « Valeur-travail : crise et problèmes de reconstruction dans le postmoderne », Futur Antérieur, n° 10, pp.30-36.
Negri A. (1997), « Vingt thèses sur Marx», in Vakaloloulis M. et Vincent JM. (ed), Marx après les marxismes, Harmattan -Futur Antérieur, pp. 333-372.
Negri, A. et Vercellone, C. (2008), « Le rapport capital-travail dans le capitalisme cognitif », Multitudes, n° 32.
Sweezy, P. (1970), La teoria dello sviluppo capitalistico, Bollati Boringhieri, Torino.
Vercellone C. (ed.) (2006), Capitalismo Cognitivo, Manifestolibri, Roma.
Vercellone C. (2007), « From Formal Subsumption to General Intellect : Elements for a Marxist Reading of the Thesis of Cognitive Capitalism », Historical Materialism, Vol. 15, n° 1.
Vercellone (2007a), « La nouvelle articulation rente, salaire et profit dans le capitalisme cognitif », in European Journal of Economic and Social Systems, vol. 20, n° 1, 2007, p. 45-64.
Vercellone C. (2008), « La thèse du capitalisme cognitif. Une mise en perspective historique et théorique», in Colletis G. et Paulré P. (coord.) Les nouveaux horizons du capitalisme, Economica, Paris, pp. 71-95.
Vercellone C. (2009), « L’analyse “gorzienne” de l’évolution du capitalisme », in Christophe Fourel (dir.), “André Gorz, un penseur pour le XXIème siècle“, La Découverte, Paris, pp. 77-98.
Vercellone C. (2009), “Lavoro, distribuzione del reddito e valore nel capitalismo cognitivo”, in Sociologia del lavoro, N° 115, pp. 31-54.
Vercellone C. (2009), «Crisi della legge del valore e divenire rendita del profitto. Appunti sulla cisi sistémica del capitalismo cognitivo », in Fumagalli A. Mezzadra S. (dir) in Crisi dell’economia globale, Ombre Corte, Verona, pp. 71-99.
Vercellone C. (2010) Modelli di Welfare e servizi sociali nella crisi sistemica del capitalismo cognitivo, «Common» 0, pp. 32-39.
Virno P. (2008), «Forza Lavoro» in Lessico Marxiano, Manifestolibro, Roma, pp. 105-116.
[1] Si ringrazia vivamente Augusto Illuminati che ha tradotto dal francese una prima versione di questo articolo. Sono evidentemente il solo responsabile degli eventuali errori e mancanze riscontrabili nel testo.
[2] Cioè a condizione di lotte sociali che garantissero la conversione degli incrementi di produttività in riduzione del tempo di lavoro.
[3] Che anticipa di almeno un secolo, la teoria economica mainstream dell’incompletezza del contratto di lavoro.
[4] Su questo punto vedi l’importante contributo di Fumagalli e Morini (2009).
[5] Bisogna notare che una delle dimensioni più pregnanti di questa evoluzione non è il solo inasprimento dello sfruttamento, nel senso più classico ed economico del termine. Declassamento e precarietà vanno anche di pari passo con un’alienazione crescente del lavoro. Essa proviene da una contraddizione sempre più profonda fra la potenza di agire iscritta nella dimensione cognitiva del lavoro, da una parte, e l’obbligo di sottomettersi a obiettivi eterodeterminati e spessi in contrasto netto con i valori etici dei lavoratori, dall’altra. E’ proprio nel solco di questa contraddizione che cresce il fenomeno della sofferenza al lavoro, di cui la moltiplicazione in Francia dei suicidi compiuti sul luogo di lavoro rappresenta soltanto la punta scoperta dell’iceberg.
[6] La distinzione, o meglio l’opposizione, tra il concetto di valore e quello di ricchezza, è enunciata da David Ricardo nei Principi. Ricordiamo infatti che, secondo Ricardo, l’aumento del valore delle merci, lungi dal significare una maggiore ricchezza per la società, è l’indicatore di un’accreciuta difficoltà della produzione che rischia di bloccare a termine la dinamica della crescita economica e dell’accumulazione di capitale. Su questa base egli sviluppa, infatti, la tesi della tendenza verso lo stato stazionario legata alla logica dei rendimenti decrescenti in agricultura e al conseguente aumento del prezzo naturale del grano. La ricchezza dipende invece dall’abbondanza, nel senso che la quantità disponibile di beni, considerati dal punto di vsita del loro valore d’uso, è inversamente proporzionale al loro valore di scambio. In altri termini, più aumenta la forza produttiva del lavoro, più diminuisce il valore delle merci, secondo una logica che, spinta alle sue ultime conseguenze, conduce a quella della gratuità (per quanto Ricardo, a differenza di Marx, non espliciti questa conclusione).
[7] Su questo punto vedi anche l’entretien avec Gorz (2004).
[8] Su questo punto vedi in particolare Marazzi (2010).
[9] In questo senso, come lo osservano Hardt et Negri, in modo più generale “i prodotti biopolitici tendono […] a eccedere qualsivoglia misura quantitativa e ad assumere forme comuni che sono facilmente condivise e perciò sono difficilmente sussumibili dalla proprietà privata”, (Hardt e Negri, 2010, p. 141).