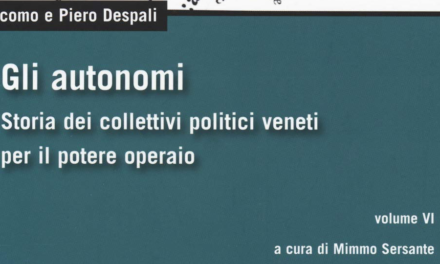di CHRISTIAN MARAZZI.
Ancora non si è insediato alla Casa Bianca e già le parole di Donald Trump su come intende make America great again stanno modificando radicalmente gli equilibri monetari e finanziari globali che in qualche modo si erano venuti normalizzando nel corso degli ultimi anni. Parole enunciate in forma di promessa, come in qualsiasi campagna elettorale, ma parole basate sul nulla che, nel momento stesso in cui Trump ha vinto le elezioni, hanno assunto legittimità e potere, a tal punto da invertire le scelte degli investitori, modificando la grammatica finanziaria che d’ora in poi plasmerà il mondo.
Per rilanciare la crescita economica americana, Trump ha promesso un forte stimolo fiscale con la riduzione delle imposte sugli alti redditi e sul capitale e con l’aumento della spesa pubblica per investimenti infrastrutturali. Queste due misure portano diritti all’aumento dei deficit pubblici e di conseguenza all’aumento dei tassi di interesse. In tale prospettiva, gli investitori si precipitano a vendere i titoli a reddito fisso, in particolare i Buoni del Tesoro, i cui tassi d’interesse, cioè i rendimenti, sono inversamente proporzionali al loro prezzo. E infatti i rendimenti dei bonds, dei titoli obbligazionari americani, inglesi e giapponesi, sono subito aumentati.
In prospettiva di una crescita più robusta e di politiche monetarie restrittive, il dollaro si sta rivalutando rispetto a tutte le altre monete, a quelle dei paesi emergenti in particolare. Se così sarà, saranno i settori industriali orientati all’esportazione che verranno penalizzati. La pressione per aumentare le tariffe alle importazioni, promesse da Trump, non mancherà di farsi sentire. E non è detto che a trarne vantaggio saranno i ceti medi e bassi, dato che il potere d’acquisto dei loro redditi è aumentato in questi anni proprio grazie ai beni low cost importati da paesi come la Cina. Il settore più esposto alla globalizzazione, quello tecnologico, è quello che più rischia dalla rivalutazione del dollaro. I profitti statunitensi realizzati all’estero diminuirebbero, vanificando i vantaggi derivanti dagli sgravi fiscali.
Molti vedono una ripetizione di quel che accadde nel corso dei primi quattro anni di presidenza di Ronald Reagan, dato che allora l’aumento del debito federale e gli alti tassi d’interesse provocarono una tale rivalutazione del dollaro e una tale pressione per erigere barriere tariffarie, che solo il Plaza Accord del 1985 per indebolire il dollaro riuscì a bloccare. Nell’economia globalizzata di oggi, con le tensioni geopolitiche che l’attraversano, è poco probabile che una rivalutazione del dollaro potrà essere domata con la stipulazione di accordi internazionali. Porterà, piuttosto, all’acuirsi dei conflitti tra la pluralità di aree economiche che in questi decenni si sono consolidate.
Il denaro torna così ad essere la spia di cambiamenti economici e sociali destinati a durare nel tempo, un campo di battaglia in cui si gioca la possibilità stessa di costruire lotte e resistenze contro gli effetti del ripiegamento sulla sovranità monetaria nazionale. Ma si tratta di un denaro che in questi decenni è mutato nella sua stessa natura, un denaro in cui la dimensione linguistica ha assunto una centralità inedita. Del divenire linguistico del denaro, del fatto, come ebbe a dire Ben Bernanke, già presidente della Federal Reserve, che «La politica monetaria è per il 98% parole e per il 2% azione», parlano due libri recenti: Gli oracoli della moneta. L’arte della parola nel linguaggio dei banchieri centrali, di Alberto Orioli (il Mulino, pp. 248, € 16) e Scommettere sulle parole. Il cedimento del linguaggio nell’epoca della finanza, di Arjun Appadurai (Raffaello Cortina Editore, pp. 197, € 21).
Per Orioli, nelle politiche monetarie degli ultimi due decenni gli «atti di parole», gli speech acts, riflettono un cambiamento radicale nella gestione delle informazioni, il fatto che la parola è ormai diventata azione. Quando denaro e linguaggio coincidono si ha a che fare con la teoria degli enunciati performativi del filosofo del linguaggio John Austin, di cui il titolo dell’opera fondamentale, Fare cose con le parole, è di per sé alquanto significativo. Si tratta di enunciati in cui il solo dire qualcosa rende vero questo qualcosa. Esemplare a questo proposito è il whatever it takes, quel «qualunque cosa necessaria» pronunciato da Mario Draghi nel 2012 per rassicurare i mercati finanziari e, come di fatto accadde, salvare l’Euro dal tracollo.
Più in generale, con le politiche di quantitative easing e, prima ancora, di forward guidance, le Banche centrali dichiarano quel che si farà e si continuerà a fare, aggiustando in corso d’opera la durata e l’entità delle politiche di emissione monetaria per stimolare la domanda aggregata e la crescita in generale, come sta facendo in questi giorni la Bce. Col rischio, come nel caso della trappola della liquidità quando si inceppano i meccanismi di trasmissione della politica monetaria, che si incorra nell’altra trappola, quella verbale. La qual cosa è pericolosa, perché le spalle dei banchieri centrali «possono sopportare solo ciò che la fiducia concede alle loro parole».
Anche Appadurai, figura intellettuale rilevante nel campo dei postcolonial studies e autore dei rilevanti Modernità in polvere e Il futuro come fatto culturale, entrambi riproposta da Raffello Cortina, parte dal ruolo nuovo che il linguaggio ha assunto nei mercati monetari e finanziari. La sua analisi si concentra però sui prodotti derivati: «Un prodotto derivato si può definire come un asset il cui valore dipende da quello di un altro asset sottostante, il quale può essere a sua volta un prodotto derivato. In questa catena di collaterali che la finanza dei nostri giorni ha prolungato all’infinito un prodotto derivato finisce per costituire fondamentalmente un fenomeno di tipo linguistico». La catena degli scambi di questi prodotti finanziari, e i contratti che sulla loro base vengono stipulati, si basano sulla promessa relativa a valori futuri fondamentalmente ignoti. È così che «La dispersione e disseminazione all’infinito delle promesse, unita alla monetizzazione dell’intera serie, ha indotto una clamorosa incongruenza tra l’idea e la realtà del sistema di compravendita di derivati». Da cui la tesi di Appadurai: il crollo finanziario del 2007-2008, a partire dall’esplosione dei derivati legati all’evoluzione del mercato immobiliare statunitense, va inteso in primo luogo come un «crollo linguistico».
Benché suggestiva, l’interpretazione della natura linguistica del denaro e dello sviluppo dei prodotti derivati lascia in ombra il fatto che, all’origine degli atti di parole monetari, risiede in primo luogo la svolta linguistica del lavoro, il fatto che nel capitalismo postfordista si lavora comunicando, si producono merci a mezzo di linguaggio. Il denaro è, in altre parole, forma del valore di merci linguisticamente prodotte.
L’insegnamento di Ferruccio Rossi-Landi, oggi riproposto con la pubblicazione di Linguistica ed economia (Mimesis, Milano-Udine), andrebbe tenuto presente per cogliere appieno le implicazioni della crisi monetaria e finanziaria odierna. Con una precisazione, e cioè che le merci e le parole sono sì entrambi artefatti secondo la teoria del valore-lavoro, come dimostrato da Rossi-Landi, ma non sono ormai più distinguibili in due sfere separate, quella della produzione e quella della circolazione. La crisi linguistica e monetaria rimandano ad una nuova fase dello scontro sociale in cui ogni promessa non mantenuta sarà pagata cara.
questo articolo è stato pubblicato sul manifesto il 15 dicembre 2016