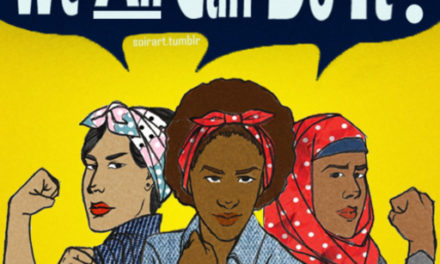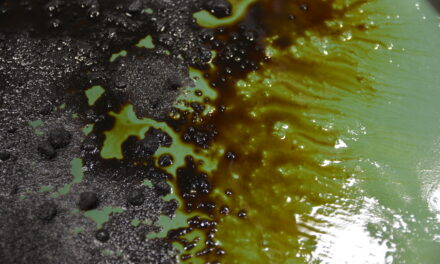di Maria Rosaria MARELLA.
1. Introduzione
Nel variegato articolarsi dei discorsi intorno ai beni comuni l’aspirazione al bene comune e, talora, l’indicazione del bene comune quale obiettivo di un’azione politica collettiva tornano di frequente. Ciò tanto perché i sintagmi bene comune, beni comuni sono evidentemente assonanti, così da indurre con qualche (automatismo, eccesso di) semplificazione (di troppo) ad una loro identificazione, quanto perché si pensa che nella definizione di un progetto politico di trasformazione l’uno implichi gli altri fino a sovrapporsi e coincidere. La relazione di contiguità fra bene comune e beni comuni si colloca dunque su due piani diversi: da un lato la loro assimilazione è tendenzialmente frutto di un equivoco in cui è facile cada la non addetta ai lavori, dall’altro tale assimilazione è invece il precipitato di un preciso disegno politico.
In questa breve voce mi propongo di illustrare le ambiguità sottese all’associazione semantica bene comune/beni comuni sui diversi piani in cui essa si dà.
2. I beni comuni v. il Bene comune
La nozione di bene comune, nell’accezione resa nota dalla dottrina di Aristotele, prima, e di Tommaso d’Aquino, poi, indica il fine della legge, la quale, come Tommaso specifica nella Summa Theologiae, in tanto può dirsi tale in quanto persegua attraverso i suoi precetti la realizzazione del bene comune, ossia di ciò che giova all’intera collettività; di talché il bene comune, potremmo dire, risponde a un’opzione sia metodologica che assiologica, ed è insieme fondamento di legittimazione del giuridico e suo fine ultimo. Ovviamente ciò presuppone una comunità omogenea e coesa al suo interno, fondata su una gerarchia di valori condivisa, poiché il bene comune per essere tale deve essere riconosciuto nella sua qualità da tutti. Ed è altresì evidente, agli occhi dell’osservatore moderno e laico, l’assoluta indeterminatezza di un progetto finalizzato al bene comune, in quanto capace per sua natura di essere piegato ai programmi e alle ideologie più diverse1, ma comunque iscritti nella cornice ideale di una completa pacificazione sociale.
I beni comuni, per contro, almeno per come la nozione è andata configurandosi nel recente dibattito italiano – il quale peraltro, bisognerà pure ammetterlo, rappresenta una punta avanzata in Europa – fanno capo a pratiche politiche e a teorizzazioni filosofiche e giuridiche che trovano nel conflitto sociale la loro cifra. Ricorrente, ad esempio, è l’idea che il conflitto che porta al riconoscimento di un bene comune sia parte integrante del bene comune stesso. Così che, volendo indulgere nel paradosso, potrebbe dirsi che i beni comuni siano, a dispetto del loro nome, risorse ‘di parte’ (non nel senso di essere destinati ad alcuni e non ad altri, ma per il disegno politico che esprimono). Certamente di parte è la nozione che li individua.
Lungi dal celebrare un ritorno a idilliaci scenari premoderni di cui gli usi e i demani civici ancora esistenti costituirebbero il retaggio, i beni comuni sono infatti l’esito di pratiche di resistenza alle politiche neoliberali di spossessamento del comune che trovano oggi anche e forse soprattutto nel pubblico, in considerazione delle massive operazioni di privatizzazione poste in essere dagli stati nazionali, un fattore cruciale di avanzamento. Questo chiarisce l’aspirazione del discorso dei beni comuni a porsi su un piano altro rispetto alla critica scontata alla sempre più pervasiva commodification delle risorse un tempo liberamente accessibili; ad andare oltre il privato e il pubblico, secondo una formula che ha conosciuto qualche fortuna e molte critiche nel recentissimo passato2. Un piano che certamente non esclude, peraltro, che si possa (ed, anzi si debba, stante il sistema vigente) far ricorso a dispositivi giuridici di diritto pubblico e soprattutto di diritto privato per il riconoscimento, la gestione e la tutela di ciò che si assume comune3. Che anzi nelle pieghe del sistema intende radicarsi e crescere, diffondendosi interstizialmente come spazio di resistenza e di costruzione di comun-e (-ismo).
Sono dunque fuori quadro quelle visioni idilliache, pacificatrici, persino bucoliche, dei beni comuni che circolano soprattutto fra i loro detrattori. Anche una pratica comune, apparentemente pacifica come il ricorso a una licenza Creative Commons rappresenta una presa di posizione, un vero e proprio atto di resistenza contro la moderna campagna di enclosure messa in atto a livello globale a sostegno della proprietà intellettuale. Sul web il conflitto in difesa del public domain è agito costantemente, trovando poi momenti di emersione in singole mobilitazioni, occasionate dai molteplici, continui tentativi di spossessamento del comune messi in atto attraverso accordi internazionali fra stati, come ad es. ACTA. Ed è persino inutile sottolineare come la rivendicazione del carattere comune di una risorsa naturale simbolo della vita stessa, come l’acqua, si accompagni a dure lotte popolari, dalla celebre “guerra dell’acqua” di Cochabamba, in Bolivia, alla storia infinita della ripubblicizzazione del servizio idrico in Italia. In fondo gli stessi residui di proprietà collettiva che più di tutto incarnano quella visione bucolica dei commons di cui si alimenta certa cattiva stampa, sono l’esito finale di un aspro conflitto che ha visto prevalere i modelli della proprietà pubblica e della proprietà privata individuale ai danni di “un altro modo di possedere”4, duramente contrastato nel corso dell’Ottocento e del Novecento dalla legislazione dello Stato liberale post-unitario, prima, dello stato fascista poi, e infine, dalla legislazione regionale, sino a ridurre il vasto patrimonio agricolo a titolarità e gestione comune prima esistente in Italia a poche, isolate realtà.
Ancora, affermare che lo spazio urbano è un bene comune è un atto di resistenza – alla disgregazione sociale, alla crescente erosione degli spazi di democrazia – e una rivendicazione di libertà: libertà di stringere legami sociali in spazi lisci, libertà di sottrarsi al controllo dei corpi e alla imposizione di identità che i dispositivi in atto nella metropoli, dalla marginalizzazione originata dalle operazioni di gentrification e di rigenerazione dello spazio pubblico alla creazione di gated communities e quartieri-ghetto, dalla costruzione delle cattedrali del consumo alla messa in opera di politiche securitarie, costantemente producono e ri-producono.
Infine la proposta di riconfigurare come beni comuni istituzioni erogatrici di servizi pubblici finalizzati alla realizzazione di diritti fondamentali come la salute e l’istruzione, dunque sanità, scuola, università, mette in campo l’aspirazione a superare sia l’odierno mix pubblico-privato che dà vita a quei modelli di aziendalizzazione che tanto apertamente si pongono in contrasto con l’originaria vocazione del servizio pubblico a soddisfare in forme tendenzialmente universalistiche i diritti sociali di rilevanza costituzionale, sia il vecchio modello statalista di matrice ottocentesca che rappresenta l’ente pubblico come erogatore del servizio e il cittadino come suddito portatore della pretesa alla prestazione, e che tanto quanto il primo esclude gli utenti dalla programmazione degli obiettivi e dal controllo dei risultati prodotti dal servizio pubblico, cioè da una gestione autenticamente partecipata, prossima a forme di autogoverno.
Il quadro si arricchisce e si complica se prendiamo in considerazione quelle pratiche di riscrittura ‘dal basso’ delle relazioni fra persone e cose in cui si sostanziano le occupazioni di immobili abbandonati e spazi culturali dismessi che, sempre più di frequente nelle città italiane, si richiamano ai beni comuni aspirando con ciò a superare il modello della proprietà, pubblica e privata, per affermare il valore della cooperazione sociale5.
Riassumendo, se identifichiamo i beni comuni con quelle risorse sottratte allo spossessamento del comune e strettamente correlate a – ovvero direttamente costitutive di – una collettività, gestite in comune o quanto meno in modo partecipato, a prescindere dal titolo di appartenenza (sia esso corrispondente ad una proprietà privata ovvero alla proprietà pubblica), non possiamo occultare o sottovalutare il potenziale di critica al sistema ad essi inerente e, più precisamente, la componente conflittuale che è loro propria, se non al prezzo di mistificarne o equivocarne la sostanza6. Cosicché la distanza da un ideale di pacificazione sociale risulta netta e, in ultima analisi, irriducibile, ed è allora evidente l’ambiguità che si cela dietro l’associazione fra Bene comune e beni comuni.
3. Il Bene comune, i beni comuni e la legalità costituzionale
A prima vista, tale associazione parrebbe trovare riscontro nella più nota definizione di “beni comuni” che ricorre nel dibattito italiano, quella partorita dalla Commissione Rodotà nel 2008 all’interno di una bozza di disegno di legge delega volta a riforma della disciplina dei beni contenuta nel libro III del codice civile. Nell’articolato i beni comuni sono descritti come quelle “cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona”. Ora, il soddisfacimento dei diritti fondamentali e il rispetto dell’autodeterminazione dei singoli sono da ritenersi senz’altro un obiettivo condiviso e sono pienamente in linea con la portata emancipatoria dei beni comuni, tanto per l’effetto di empowerment che realizzano sul piano individuale, quanto per il rafforzamento della legalità democratica che producono sul piano generale. Apparentemente, quindi, questa formula definitoria di carattere giuridico, che ritorna con insistenza nei discorsi ‘benecomunisti’, presta il proprio suggello all’idea che la tutela dei beni comuni sia in funzione dell’affermazione del Bene comune. Ma in realtà non è così. Come meglio vedremo in seguito, il diritto di avere diritti porta con sé il potenziale conflittuale proprio di ogni istanza autenticamente egalitaria e, ove coniugato all’affermazione dei beni comuni, si colora di spinte antiproprietarie che poco hanno a che vedere con l’ideale di una comunità pacificata nella tensione verso il Bene comune.
Il discorso critico richiede tuttavia di essere adeguatamente articolato, poiché, come si è detto, la sovrapposizione Bene comune – beni comuni si gioca a diversi livelli e assume diverse sfumature anche in riferimento al contesto culturale e disciplinare in cui la si ritrova.
Nel discorso di alcuni economisti, ad esempio, l’associazione è resa possibile da una visione essenzialista dei commons, che assume la loro esistenza e la loro sostanza come date, a prescindere dai processi politici che conducono alla loro individuazione. Bisogna precisare che, in linea di tendenza, l’elaborazione economica sul punto continua a confrontarsi con l’esigenza di confutare l’assolutezza e l’ineluttabilità della tragedia dei beni comuni. Pertanto si preoccupa in prevalenza di individuare le condizioni in cui è possibile prevenire o limitare il free-riding, ossia quei comportamenti individuali che mettono a rischio la sopravvivenza del bene comune (in ciò fornendo tuttavia una giustificazione ‘scientifica’ al detour dalla proprietà – privata individuale o pubblica); mentre un altro filone di studi, di taglio più specificamente giureconomico, ha ad oggetto le condizioni di accesso e uscita dalla comunità degli utenti/gestori del common e dunque il problema del bilanciamento fra regole di autogoverno della comunità/risorsa e libertà individuale. Ciò che complessivamente occulta o, quanto meno, svaluta, la dimensione collettiva delle lotte per il comune.
Quando poi in questo contesto discorsivo fanno ingresso le suggestioni provenienti dall’etica del dono, le pulsioni altruistiche in grado di contrastare il free-riding assumono una connotazione morale che va oltre la solidarietà sociale, rinviando piuttosto a una gerarchia di valori data, che traduce il complesso delle relazioni di interdipendenza su cui poggia il governo del common in una comunità in sé conchiusa, omogeneamente protesa verso la realizzazione del bene comune. Ma dire che il bene comune è esso stesso un bene relazionale (“l’insieme di “condizioni di vita buona” di una comunità), che esiste un “circolo virtuoso (…) fra beni relazionali ↔ beni comuni ↔ bene comune ↔ dono ↔ felicità ↔ beni relazionali”7, proietta il discorso dei beni comuni nella dimensione di un comunitarismo rugiadoso fatto di relazioni sociali immaginarie, del tutto disconnesse dalla concretezza del contesto economico e istituzionale neoliberale in cui in realtà sono calate.
Questo limite non si riscontra invece quando il Bene comune cui i beni comuni dovrebbero preludere è identificato con la legalità costituzionale. È questa la prospettiva che sceglie Salvatore Settis nel suo ultimo libro, fissando sin dal titolo uno stretto legame fra attivismo dei cittadini, bene comune e attuazione della costituzione repubblicana8. Davanti a “una gestione della crisi economica che ne accolla il peso non a chi l’ha provocata con la complicità dei governi (grande speculazione finanziaria e imprese parassitarie), bensì a tutti i cittadini”9, reclamare la difesa dei diritti individuali non appare più sufficiente: per Settis occorre richiamarsi a forti valori collettivi, al bene comune, appunto. Sull’onda delle primavere arabe, le mobilitazioni che hanno dato luogo alle acampade spagnole o a Occupy Wall Street negli Stati Uniti, mentre danno voce all’indignazione collettiva, mettono in scena un ritorno dei cittadini all’attivismo. Il ritrovato protagonismo della cittadinanza, per Settis, non deve rimanere allo stadio di puro movimentismo – movimentismo che, peraltro, nel nostro paese fatica a trovare una dimensione più generale – ma deve essere convogliato in dinamiche istituzionali. Di qui la proposta di far ricorso all’azione popolare, un istituto processuale risalente al diritto romano, in forza del quale qualunque cittadino era legittimato ad agire in nome dell’intera comunità per chiedere la sanzione di un fatto lesivo dell’interesse generale, che oggi viene riproposto da alcune costituzioni latinoamericane quale strumento di accesso alla giustizia in forma collettiva. Attraverso le azioni popolari i cittadini italiani potrebbero direttamente tutelare i valori costituzionali – la libertà, l’uguaglianza, il diritto al lavoro, ma anche la tutela dell’ambiente, della salute, della cultura, dell’arte – traditi da una politica prona all’assolutismo dei mercati e al ricatto del debito pubblico. È infatti la costituzione repubblicana il manifesto politico destinato a guidare la comunità nazionale oltre la soggezione alle politiche neoliberali verso la realizzazione del Bene comune.
Nel progetto di Settis ai beni comuni è riservato un ruolo cruciale. Essi sono distinti dal bene comune inteso in senso valoriale, ma sono strettamente connessi ai valori che la costituzione promuove (lavoro, salute, arte, ecc.). E, parallelamente ma anche conseguentemente, si pongono in continuità coi beni pubblici. Anzi, secondo Settis, il fatto che la costituzione non menzioni i beni comuni (ad es. le proprietà collettive di cui abbiamo prima parlato) si spiega con la volontà dei costituenti di rafforzare la contrapposizione fra proprietà privata e proprietà pubblica, sottolineando di quest’ultima l’ancillarità all’utilità sociale. Del resto la teorizzazione di un continuum beni comuni-beni pubblici è in linea con un recupero del ruolo dello Stato, inteso non già come Stato-persona, bensì come Stato-comunità che si identifica nei cittadini e nella concretezza della sovranità popolare. Ecco dunque che il cerchio si chiude: il protagonismo dei cittadini si esplica attraverso la tutela dei beni comuni/pubblici nella prospettiva della realizzazione del bene comune, cioè delle finalità dello stato democratico costituzionale.
L’argomento è portato a conclusioni più radicali da chi ricostruisce il comune interamente all’ombra (di una rivalutazione) del pubblico e ne contesta l’autonomia sul piano tecnico-giuridico nonché l’utilità sul piano euristico una volta che si assuma la piena attuazione della costituzione del 1948 quale prospettiva di trasformazione, altrettanto rivoluzionaria sì, ma, diversamente dai beni comuni – “un flauto magico verso il nulla” – saldamente radicata nella realtà del diritto10.
Senonché è proprio dall’angolo visuale del diritto dei beni comuni, per la fisionomia che esso è andato assumendo nel dibattito italiano, che progetti di questo tenore non convincono fino in fondo. In primo luogo il discorso del comune si è presto intersecato con una discussione vivace e seria sull’attualità della costituzione repubblicana11. Che la globalizzazione abbia messo in crisi il costituzionalismo moderno è una realtà con cui gli stessi costituzionalisti fanno i conti12. E poiché i beni comuni e le lotte che li accompagnano hanno sempre, direttamente o indirettamente, una dimensione transnazionale e globale, ne consegue che crisi del costituzionalismo e rivendicazione dei beni comuni non sono questioni impermeabili l’una all’altra, ma al contrario hanno significativi punti di contatto. Infatti lo spossessamento del comune è spesso direttamente orchestrato a livello globale dalla partnership fra imprese multinazionali, stati sovrani e istituzioni della globalizzazione (World Bank in testa): ne sono un esempio il land grabbing nell’Africa subsahariana, in molti paesi dell’Asia e persino in Canada13, così come le operazioni di privatizzazione dell’acqua che hanno colpito intere popolazioni nel Sud del mondo, e non solo, portando a rivolte come quella, celebre, di Cochabamba. Tuttavia, anche quando il “saccheggio”14 è interamente da imputare all’iniziativa dei governi nazionali ed ha dimensioni locali, come nel caso della privatizzazione dei servizi o della svendita del patrimonio pubblico, l’incanto neoliberale della forza emancipatoria del mercato, prima, e le politiche di austerità dettate dall’indebitamento degli stati, poi, ci narrano di uno svuotamento o forse, meglio, di una riconfigurazione della sovranità degli stati che cede al livello sovranazionale molte sue prerogative tanto da non poter ormai essere pensata fuori dalle dinamiche della globalizzazione. Tutto ciò comporta necessariamente una perdita di centralità delle costituzioni e una rimodulazione della gerarchia delle fonti, nonché, sul piano dei contenuti, un attacco mirato ai contenuti sociali delle carte del secondo dopoguerra, come messo in evidenza dal tenore dei progetti di revisione della costituzione italiana e dall’introduzione al suo interno del principio del pareggio di bilancio. Con il che promuovere l’orizzonte costituzionale come prospettiva futura (‘del bene comune’) rischia di apparire un’operazione di retroguardia se non corredata dalla presa d’atto delle trasformazioni in corso e dal disincanto che ciò necessariamente comporta. Anche perché svalutare i varchi ‘verso il nuovo’ aperti anche nel diritto dai beni comuni per riportare il Bene comune dentro l’orbita della costituzione gioca su un non detto che andrebbe infine svelato: se il bene comune, o comunque voglia chiamarsi l’obiettivo perseguito, sia la costruzione di un’alternativa al capitalismo, come parrebbe di capire dalla vibrante condanna delle devastazioni ambientali e sociali imputabili alle politiche neoliberali e alla finanziarizzazione dell’economia, o sia invece qualcosa d’altro. Perché, nel primo caso, l’orizzonte della legalità costituzionale non appare sufficiente allo scopo, ponendosi il progetto costituzionale non come alternativo al capitalismo, ma al contrario iscritto nel momento ‘sociale’15 della sua fase fordista. Mentre nel secondo caso, cioè nel caso in cui il bene comune si identifichi con “qualcosa d’altro”, e dunque con la ricerca di una soluzione riformista, l’obiettivo assume il sapore di un’operazione nostalgica, giacché il disegno politico consegnato al testo costituzionale fa leva su quelle istituzioni – lo stato sociale, il lavoro, la socialdemocrazia – che sono andate in crisi insieme al fordismo. E che oggi non sono più in grado di realizzare quei valori costituzionali – la libertà, l’uguaglianza, la dignità sociale, la solidarietà – che tutti riconosciamo ancora validi.
Provo a addentrarmi un poco nella complessità del tema per evitare di renderne un quadro eccessivamente banale. Nella costituzione la proprietà è pubblica o privata. La proprietà privata, conformata dalla funzione sociale, è riconosciuta e garantita. I beni comuni non sono contemplati né si fa menzione delle proprietà collettive di cui in sede costituente si discusse per poi decidere di assorbirle nel pubblico (o nel privato). Tanto rende il progetto costituzionale e la dimensione del comune, intesa come dimensione collettiva che scardina in qualche modo la rigidità della dicotomia pubblico/privato, non immediatamente armonizzabili. Il tentativo più fortunato di superare l’ostacolo sta in una rilettura della funzione sociale secondo cui la proprietà dei beni comuni, pubblica o privata che sia, è intrinsecamente limitata dalla facoltà di accesso e uso riconosciute a chiunque abbia un interesse conforme alla natura del bene16. Si tratta di una interpretazione avanzata, distante, almeno in apparenza, da un’impostazione originaria che leggeva la funzione sociale, in piena coerenza con il sistema capitalistico, come quel principio che consente ad una società moderna che riconosca la proprietà dei beni di trarre da essa vantaggi adeguati17. Il che induce altri a ridimensionarne la portata trasformativa in riferimento ai beni comuni, riconoscendo tutt’al più la possibilità di un uso tattico di ciò che resta comunque un dispositivo appartenente per intero ad una fase ormai passata della cultura giuridica18. Ma questa polarizzazione, se da una lato tiene in considerazione la relatività storica delle regole e degli istituti giuridici, dall’altra trascura l’indeterminatezza ovvero la flessibilità delle forme giuridiche, la loro intrinseca capacità di dar voce a progetti anche distanti fra loro. Da questo punto di vista, che è quello proprio di una prospettiva critica al diritto19, appare inutile (e sbagliato) denunciare l’egoismo proprietario, quando è possibile – tanto più in presenza della previsione costituzionale della funzione sociale – argomentare in favore di assetti proprietari ‘altruisti’, che consentano l’accesso alle risorse a chi sia portatore di interessi di una data rilevanza.
Non per questo, però, l’identificazione della costituzione con il Bene comune offre soluzioni concrete agli scenari aperti dal capitalismo finanziario. Un approccio non dogmatico (o idealista) impone di guardare senza infingimenti a come la proprietà della costituzione ha preso realmente corpo nel sistema giuridico vigente. Costatiamo allora che le regole operazionali che è possibile desumere dalla giurisprudenza costituzionale hanno di molto ridotto la carica trasformativa del principio della funzione sociale, giacché l’idea giusnaturalista del contenuto minimo intangibile propugnata dalla Consulta ha presto spuntato l’arma della proprietà conformata, con la quale una parte della dottrina e la legislazione d’ispirazione sociale degli anni ’60 e ’70 avevano tentato di dare voce alle potenzialità marcatamente redistributive della funzione sociale. Come noto, sin dalla metà degli anni Sessanta ogni limite consistente alle facoltà proprietarie è stato letto dalla Corte come una forma di espropriazione indennizzabile e ciò ha portato quasi senza soluzione di continuità ad una lettura del dettato costituzionale compatibile con il nuovo scenario europeo, nel quale il ritorno alla proprietà = diritto umano (art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU) e all’equazione proprietà = libertà (art. 17 della Carta di Nizza) si rinnova nei connotati propri dell’economia neoliberale.
Riassumendo, il riconfigurarsi del sistema delle fonti del diritto che accompagna i processi di globalizzazione vede da una parte una perdita di centralità delle costituzioni nazionali e dall’altra, quanto meno nel contesto europeo, una penetrazione al loro interno di nuovi principi, estranei nell’ispirazione all’impianto originario. Il diritto di rango costituzionale che ne risulta è secondo l’opinione maggioritaria poco sensibile a finalità di perequazione sociale, tanto da perdere la vocazione emancipatoria che connotava le costituzioni del dopoguerra. E i beni comuni? Arduo rintracciarli nell’agenda delle democrazie europee, la cui risposta alla crisi economica continua a essere cercata nella tradizionale tensione fra pubblico e privato, pur rimodulata nelle forme di una partnership fra stato – o agenzie pubbliche di varia natura – e imprese private con trade-offs invariabilmente a vantaggio di queste ultime e a svantaggio della collettività, come creazione di nuova urbanizzazione e costruzione di infrastrutture/grandi opere bene mettono in evidenza. In questo quadro – e tornando alla vicenda italiana – non sembra che invocare la realizzazione del progetto costituzionale, eventualmente rappresentata come coronamento del Bene comune, sia sufficiente a restituirgli la forza emancipatoria perduta. La crisi del costituzionalismo moderno è in atto e può essere superata solo se esso stesso saprà farsi interprete di nuovi conflitti20. Al momento, insomma, i beni comuni non sono i beni pubblici perché i beni pubblici non sono pensati e gestiti come beni comuni21: a tutto concedere, questa sovrapposizione diverrà plausibile se la costituzione potrà essere riletta e applicata alla luce della conflittualità sociale che si esprime in forme rinnovate anche attraverso le rivendicazioni dei commons. In questa direzione mi pare si muova Rodotà quando propone un’interpretazione dell’art. 42, 2° co., cost. che comprime radicalmente le prerogative dominicali in nome dell’accesso ai beni comuni, in ciò segnando però una cesura netta rispetto al regime proprietario che è venuto consolidandosi all’ombra della costituzione. In sostanza, se la dimensione del comune non apre una fase costituente, quanto meno indica il cammino verso una nuova legalità nella quale, per esempio, il riconoscimento della liceità di un’occupazione non sia meramente residuale, cioè configurabile solo quando la proprietà è esercitata illegittimamente; nella quale cioè la funzione sociale e la costituzione nel suo complesso non siano più una tattica di difesa del comune ma diventino strategia. Al momento però il transito verso una nuova legalità costituzionale non è compiuto e non si danno le premesse per una riscrittura del pubblico alla luce del comune. C’è invece il diritto europeo. Da cui bisogna comunque ripartire. Per andare avanti, non indietro.
4. Beni comuni & Bene comune reloaded: suggestioni neoliberali e neopaternaliste
Un altro modo, più aggiornato, di tracciare un rapporto di continuità fra beni comuni e pubblico quale vettore del Bene comune si ritrova nella sussidiarietà orizzontale. Si tratta di una proposta che definisco più aggiornata in quanto maggiormente in linea con le retoriche proprie della fase di globalizzazione che stiamo attraversando.
Per sussidiarietà orizzontale si intende un modello organizzativo delle pubbliche funzioni che prevede forme di collaborazione fra settore pubblico e settore privato e, più precisamente, lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di privati cittadini sulla base di un accordo con l’istituzione pubblica titolare delle relative competenze. Il principio di sussidiarietà orizzontale è strettamente connesso all’idea di partecipazione e di democrazia partecipativa, ma mentre in quest’ultima la collaborazione dei privati riguarda essenzialmente i processi decisionali, “nel modello della sussidiarietà la collaborazione si spinge fino al piano dell’attuazione concreta delle decisioni, grazie alla promozione di forme di empowerment della società civile”22. Questo principio ha trovato accoglienza in Italia con le riforme amministrative degli anni Novanta ed è poi stato consacrato dall’art. 118 della costituzione – come riformulato dalla riforma c.d. del Titolo V, nel 2001 – che all’ultimo comma dispone che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. In virtù di ciò è dunque possibile l’attribuzione/condivisione di funzioni pubbliche al di fuori del tradizionale contesto istituzionale in linea con la logica della governance multilivello che connota il riconfigurarsi della sovranità statale tipico di questa fase e che nel caso di specie si sviluppa appunto secondo una prospettiva orizzontale, di collaborazione fra istituzione pubblica e cittadinanza. Cos’ha tutto ciò a che fare con il comune? Poco, se si assume una nozione conflittuale di comune, come chi scrive. Al contrario, i sostenitori della sussidiarietà orizzontale individuano in essa la dimensione ideale della tutela dei beni comuni. Concetto chiave in questo contesto discorsivo è quello di “cittadinanza attiva”, che indica chi partecipa in modo consapevole “alla vita politica e sociale del territorio in cui vive, motivato dall’intento di contribuire alla tutela del bene comune (c.n.) e al perseguimento dell’interesse generale attraverso proprie autonome iniziative”23. Nelle parole di uno dei massimi teorici italiani della sussidiarietà, Gregorio Arena, “è come se i cittadini oggi venissero chiamati in aiuto dell’amministrazione pubblica, delle istituzioni… perché da sole non ce la possono più fare”24. È dunque vero che “ognuno di noi può prendersi cura della propria scuola, del proprio quartiere, della propria città, come fossero nostre, ciò che in effetti è”25; ma ci si organizza e si opera in difesa dei beni comuni o per la tutela dei diritti fondamentali in supplenza delle istituzioni pubbliche e senza alcuna ‘cessione di sovranità’26 da parte delle stesse. Del resto, gli esempi che vengono portati a testimonianza delle potenzialità trasformative della c.d. cittadinanza attiva sono poi la cura di un monumento cittadino, la manutenzione stradale, la bonifica del cortile di una scuola (magari cancellando i graffiti fatti dagli studenti ‘cattivi’). Ciò che avviene nel pieno rispetto delle politiche pubbliche e in conformità con le finalità da esse perseguite, sia in termini di individuazione e condivisione degli obiettivi, sia in termini di controllo delle modalità di realizzazione degli stessi da parte delle amministrazioni pubbliche competenti. Ma soprattutto in un clima, anche qui, di comunitarismo rugiadoso, nel quale il conflitto sociale è del tutto obliterato, lo scontro fra valori in conflitto risolto a monte e i cittadini si organizzano e agiscono all’ombra di un paternalismo (statale) di nuova generazione, pienamente conforme alle esigenze della governance neoliberale.
Per contro, l’occupazione di appartamenti sfitti da parte di chi è senza casa, la difesa dell’originaria destinazione culturale di un cinema storico che il legittimo proprietario vuole destinare a sala giochi non saranno mai in linea con gli obiettivi indicati dalle istituzioni pubbliche, sebbene perfettamente in linea con l’affermazione dei diritti fondamentali – all’abitare, alla cultura, in questi casi – degli occupanti. Queste pratiche – che alla stregua del dibattito corrente rappresentano esempi di lotta per i beni comuni – risultano invece del tutto estranee ai programmi della cittadinanza attiva. Non saranno mai considerate funzionali alla realizzazione del Bene comune e neppure alla difesa dei beni comuni. Siamo infatti da tutt’altra parte, in una dimensione in cui sono patenti le spinte antiproprietarie ed è patente la dimensione del conflitto, poiché l’obiettivo è non già tentare di porre rimedio alle carenze dell’azione amministrativa nella gestione dei beni pubblici, bensì restituire all’uso comune ciò che è stato catturato dai dispositivi pubblico-privatistici di appartenenza esclusiva.
5. Per concludere: le sirene della democrazia deliberativa e la tenuta della contrapposizione beni comuni/Bene comune
Ci si può chiedere in conclusione se il conflitto di cui i beni comuni sono portatori possa essere gestito con il metodo della deliberazione, se la democrazia deliberativa sia all that participation is about, e se, dunque, non sia questa la via per ricongiungere finalmente i beni comuni al Bene comune.
Premetto che il tema è complesso e meriterebbe ben altro spazio. Senza alcuna pretesa di esaustività, mi soffermo brevemente sull’associazione proprietà-deliberazione e sugli sviluppi che essa dovrebbe comportare per il regime dei beni comuni.
Di recente si è infatti proposto di leggere l’emergere di nuove tipologie di appartenenza, i beni comuni fra esse, come istituzioni sociali rette da procedure deliberative27. Il tentativo ha il merito di attribuire alla gestione c.d. partecipata dei beni comuni un contenuto sufficientemente definito, cosa che nel dibattito italiano risulta per lo più carente, giacché in proposito ricorrono formule suggestive e eterogenee fra loro – autogoverno, istituzioni del comune, o semplicemente gestione partecipativa – cui risulta difficile ricondurre un significato preciso. La teoria della democrazia deliberativa propone invece forme di proceduralizzazione delle decisioni collettive alquanto definite e consolidate. E l’idea di un’arena deliberativa28, in cui tutti gli interessi in gioco si confrontano apertamente sulla base di argomenti razionali portati da soggetti che si assumono liberi e uguali, sembra dare concretezza alle istanze di partecipazione che accompagnano le lotte per i beni comuni, dall’acqua al governo dello spazio urbano. C’è però da chiedersi se il progetto politico che fa capo ai beni comuni davvero richieda – o tolleri – il ricorso agli strumenti della democrazia deliberativa e all’ideologia che li supporta.
Rispetto ad altri progetti che associano la cura dei beni comuni al bene comune, il metodo deliberativo ha il pregio di non occultare il conflitto, che invece è assunto come un dato che si ritiene possa essere efficacemente analizzato e amministrato attraverso il confronto fra le ragioni avanzate da ognuna delle parti portatrici di interessi. L’attitudine di ciascuno all’ascolto e la ricerca della razionalità degli argomenti presentati garantiscono, in quest’ottica, una gestione delle opinioni e degli interessi contrastanti che, in virtù delle caratteristiche ora ricordate, necessariamente sfocia nella assunzione della decisione migliore per la comunità, compiuta nel rispetto del pluralismo dei valori che essa esprime. Tanto, senza neppure bisogno di esplicitarlo, porta alla realizzazione del bene comune che, in ultima analisi, è realizzazione della democrazia stessa.
Tuttavia la visione delle relazioni sociali che il metodo deliberativo propone, non diversamente da quanto visto in precedenza, appare poco aderente alla realtà, tanto meno alle dinamiche innescate dalla crisi finanziaria. Sono perciò da condividere le critiche più comunemente rivolte alla deliberative democracy, che mettono in evidenza come, date condizioni di disuguaglianza economica e sociale fra i soggetti potenzialmente riguardati dalla deliberazione, tale diseguaglianza si riproduce nel processo deliberativo, viziandolo. Senza contare che il divario abissale di potere fra haves e have-nots generato dal capitalismo finanziario, la forte ideologizzazione che connota le forme ‘istituzionalizzate’ di accaparramento del comune29, la frequente opacità dei portatori di interessi speculativi rendono l’arena deliberativa uno scenario inverosimile (o al contrario, uno scenario cruento, da Thunderdome30). In riferimento ai beni comuni, poi, l’associazione deliberazione-proprietà sembrerebbe tendere a esaltare i valori di cui la proprietà è portatrice, mentre il discorso dei beni comuni e le lotte che ad essi si accompagnano tendono piuttosto a delegittimare lo ius excludendi alios, cuore della proprietà. Ma, ripeto, è un discorso che meriterebbe ben altro spazio.
Al di là questi rilievi più generali, deve notarsi che la proposta di governare i beni comuni attraverso i processi deliberativi sembra calibrata principalmente sulle istanze di partecipazione alla gestione di alcuni servizi pubblici, come ad es. il servizio idrico integrato31. E ci si può immaginare che istituzioni che sono volte a soddisfare diritti fondamentali e si declinano come beni comuni, quali la scuola, l’università, il sistema sanitario, possano trovare nel processo deliberativo un metodo di gestione che dia voce alla comunità degli ‘utenti’, ovvero, nel caso soprattutto dell’istruzione pubblica, che attivi la partecipazione di chi – studenti, docenti, personale amministrativo – dà vita all’istituzione meglio dei meccanismi rappresentativi attualmente operanti.
Ma quando è la proprietà nel suo senso più classico ad essere investita dai conflitti ingenerati dai beni comuni, il discorso cambia di registro, perché allora si tratta di incidere sulle prerogative proprietarie, di far valere l’istanza egalitaria che la rivendicazione dei diritti porta con sé, restituendo la concretezza dei rapporti di forza che regolano la società. Di nominare la “class violence”32 che impone di disarticolare la proprietà33.
Si vedano al riguardo le precise osservazioni di L.Pennacchi, La triangolazione pubblico/privato/comune ai fondamenti della modernità, in AA.VV. (Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco cur.), Tempo di bei comuni. Studi multidisciplinari, Roma, Ediesse, p. 61 ss., spec. 62-64. ↩
La formula compare nel sottotitolo della versione italiana di Commonwealth di A.Negri e M.Hardt (Comune. Oltre il privato e il pubblico, XXX) ed è ripresa nel titolo del volume collettaneo da me curato (Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Verona, ombre corte, 2012) attirandosi anche severe censure. Cfr. ad es. T. Seppilli, Sulla questione dei beni comuni. Un contributo antropologico per la costruzione di una strategia politica, in Oltre il pubblico, cit., p. 110, spec. 125. ↩
Il che non vuol dire rendersi subalterni alla logica neoliberale, come intende invece, equivocando, C.Formenti, Utopie letali. Contro la politica postmoderna, Jaca Book, 2013, spec. 136 s.; tutto il contrario. Ma vedi infra nel testo. ↩
P.Grossi, ‘Un altro modo di possedere’. L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria, Giuffrè, Milano, 1977. ↩
Rinvio sul punto a M.R.Marella, Pratiche del comune. Per una nuova idea di cittadinanza, in Lettera internazionale, 116, 2013, p. 24 ss. ↩
Si consenta il rinvio al mio Il diritto dei beni comuni oltre il pubblico e il privato, in G. Allegri, M. R. Allegri, A. Guerra, P. Marsocci (a cura di), Democrazia e controllo pubblico dalla prima modernità al web, Napoli, Editoriale Scientifica. ↩
C.Montesi, I beni comuni al crocevia tra simpatia per il prossimo ed interesse personale, in AA.VV. (Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco cur.), Tempo di beni comuni. Studi multidisciplinari, Roma, Ediesse, 2013, p. 217 ss., 242. ↩
Azione popolare. Cittadini per il bene comune, Einaudi, Torino, 2012. ↩
Ivi, p. 3. ↩
Cfr. A. Algostino, Riflessioni sui beni comuni tra il “pubblico” e la Costituzione, in Costituzionalismo.it, 3/2013. ↩
Per una sintesi vedi Collettivo Uninomade, La costituzione del comune, www.uninomade.org; Id., Insistiamo: la critica della costituzione è necessaria, ibidem. ↩
G. Azzariti, Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, Laterza, Roma-Bari, 2013. ↩
Cfr. L. Paoloni, Land grabbing e beni comuni, in Oltre il pubblico, cit., p. 139. ↩
Cfr. U. Mattei & L. Nader, Plunder. When the Rule of Law is Illegal, Wiley-Blackwell, 2008; P. Bevilacqua, Il grande saccheggio. L’età del capitalismo distruttivo, Laterza, Roma-Bari, 2011. ↩
Il riferimento è a Du.Kennedy, Three Globalizations of Law and Legal Thought: 1850-2000, in D. M. Trubek and A. Santos (eds.), The New Law and Economic Development. A Critical Appraisal, Massachusetts, Cambridge University Press, 2006, 19-73. ↩
In tal senso S. Rodotà, Postfazione. Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide, in M.R. Marella (cur.), Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, ombre corte, Verona, 2012, p. 311 ss. Su questa linea è anche U.Mattei, Una primavera di movimento per la “funzione sociale della proprietà”, in Riv.crit.dir.priv., 2013 (in corso di pubblicazione). ↩
Rodotà, Note critiche in tema di proprietà, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1960, p. 1252 ss. ↩
M.R. Marella, Il principio costituzionale della funzione sociale della proprietà e le spinte antiproprietarie dell’oggi, in Alpa e Roppo (curr.), La vocazione civile del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà, Laterza, Roma-Bari, 2013, p. 105; L. Nivarra, La funzione sociale della proprieta’: dalla strategia alla tattica, in Riv.crit.dir.priv., 2013 (in corso di pubblicazione). ↩
Secondo la scholarship ascrivibile al movimento dei Critical Legal Studies, di cui si veda, con specifico riferimento agli istituti del diritto privato innanzitutto Duncan Kennedy, Form and Substance in Private Law Adjudication, 89 Harvard Law Review 1685 (1976). ↩
Cfr. G. Azzariti, op.cit., spec. p. 158 s. ↩
Sul piano operazionale richiamarsi alla cittadinanza democratica progettata dalla costituzione, come fa Algostino (op.cit., n. 83), non cambia, ahimè, il quadro di una virgola. ↩
F. De Toffol e A. Valastro, Dizionario di democrazia partecipativa, a cura del Centro Studi Giuridici e Politici della Regione Umbria, 2012, p. 146. ↩
Così A.Valastro, op.cit., p. 49. ↩
Ancora G.Arena, loc.ult.cit. ↩
L’espressione ha in questo contesto un significato essenzialmente politico, di riconoscimento ad entità altre – comunità, gruppi organizzati, moltitudini (!) – di una potestà che si struttura e si esercita al di fuori della compagine statuale. Resta impregiudicato il dato giuridico costituzionale secondo cui la sovranità appartiene al popolo, come esplicitato dall’art. 1, 2° co. Cost. ↩
A. di Robilant, Property and Deliberation. The Numerus Clausus Principle, New Property Forms and New Property Values, consultabile nel sito http://www.law.harvard.edu/programs/about/privatelaw/related-content/di_robilant_property_and_deliberation.pdf. ↩
Per una prima informazione v. F. De Toffol e A. Valastro, Dizionario di democrazia partecipativa, cit., p. 32 s. ↩
Si pensi alla retorica dell’efficienza, dello sviluppo, del progresso che accompagna la progettazione delle c.d. grandi opere. ↩
La suggestione è tratta dal film Mad Max – Oltre la sfera del tuono: nella città di Bartertown le controversie si risolvono nel Thunderdome, sorta di Colosseo in cui le ragioni si fanno valere combattendo fino alla soccombenza fisica (=morte) di uno dei contendenti. ↩
Cfr. di Robilant, op.cit. ↩
Cfr. Du.Kennedy, The Effect of the Warranty of Habitability on Law Income Housing: «Milking» and Class Violence, in “Florida State University Law Review”, n. 15/1987, pp. 485 ss. ↩
Per una discussione rinvio a Kennedy-Negri-Rodotà et al., a cura di M.R.Marella, Disarticolare la proprietà. I benicomuni e le possibilità del diritto, in corso di pubblicazione. ↩