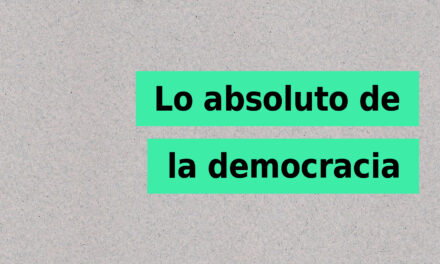di FRANCESCO FESTA.
«La musica ci invita a viaggiare – scrive Iain Chambers – adottando una visione nel complesso meno rigida delle varie discipline, delle prassi e delle istituzioni che assieme configurano la modernità di oggi. Essa offre un caso rilevante di deterritorializzazione». Che le melodie circolino apparentemente libere, spesso inconsapevolmente dalle rivendicazioni delle «comunità immaginate», non significa che non siano altrettanto «sature di tempo storico e di intensità culturali»1. Ad onta del positivismo del progresso e dello storicismo della modernità, per cui la musica va ordinata in un canone e istituita in un genere, la musica di cui parliamo risuona di «dissonanze», imparando a preferire le «diversità» e lo «spaesamento»2. Anzitutto essa si muove lungo uno spazio discorsivo il cui baricentro è il luogo: infatti lo «spaesamento» avviene da un punto determinato per divenire movimento: «misurare territori, cartografare contrade a venire»3.
Ecco, la musica di cui parliamo è quella che muove i suoi passi nella metà degli anni Settanta, con radici in un lustro precedente, e il territorio da «cartografare» è lo spazio mediterraneo, il Mezzogiorno d’Italia e la città di Napoli. Parliamo del movimento blues Neapolitan Power4, soffermandoci su alcune canzoni di Pino Daniele. A nostro parere, queste presentano un uso assai prensile, innovativo e decostruttivo dei discorsi essenzializzanti se non razzializzanti, di ciò che con Deleuze intendiamo per dispositivo, vale a dire esercizio di libertà5: se déprendre de soi même, sradicarsi da se stessi e dall’insieme di «elementi eterogenei discorsivi», il cui fine è il controllare, sorvegliare e l’ordinare uno spazio rendendolo direttamente produttivo.
 Il Neapolitan Power è, infatti, l’uso contro-discorsivo del dispositivo che su Napoli e sul Sud italiano viene agito attraverso discorsi sulla «questione meridionale» e l’«arretratezza». Ciò dà luogo però a «un eccesso supplementare non rappresentato e subalterno, che persiste e resiste nel suono, nel gusto, nel divenire affettivo della vita quotidiana […] rimane tendenzialmente inconscio, non identificato»6. Laddove la cartolina vuole i napoletani rappresentati con pizza e mandolino, proiettati lungo piani inclinati e scorciatoie di cliché e luoghi comuni, poeti e musicisti del Neapolitan Power hanno recuperato il volgare, il folclore, il sincretico per squadernare lo spazio identitario da elementi nocivi quali la chiusura nel vicolo cieco delle concezioni duali: moderno – arretrato, sviluppo – sottosviluppo.
Il Neapolitan Power è, infatti, l’uso contro-discorsivo del dispositivo che su Napoli e sul Sud italiano viene agito attraverso discorsi sulla «questione meridionale» e l’«arretratezza». Ciò dà luogo però a «un eccesso supplementare non rappresentato e subalterno, che persiste e resiste nel suono, nel gusto, nel divenire affettivo della vita quotidiana […] rimane tendenzialmente inconscio, non identificato»6. Laddove la cartolina vuole i napoletani rappresentati con pizza e mandolino, proiettati lungo piani inclinati e scorciatoie di cliché e luoghi comuni, poeti e musicisti del Neapolitan Power hanno recuperato il volgare, il folclore, il sincretico per squadernare lo spazio identitario da elementi nocivi quali la chiusura nel vicolo cieco delle concezioni duali: moderno – arretrato, sviluppo – sottosviluppo.
Esemplare è l’uso nelle canzoni di Pino Daniele, nei suoi primi album7, del mélange di napoletano volgare con italiano e inglese, mentre l’ibrido è il tratto naturale dell’estetica musicale fatta di crossover e cut and mix, mix di tarantella e di musiche della diaspora nera, il blues e il jazz, che diviene stile Tarumbò8, cioè uno stile che si affranca della fissità e della stanzialità dell’identità, mentre spiazza il luogo e il suono in un perenne divenire altro. Per un altro verso, è l’esercizio di quel genius loci presente nei meridionali9, che preferisce il divenire dei luoghi, l’aspetto creativo e contingente dei processi di produzione di senso legati alla vita quotidiana, che, a ben guardare, sono oggetto di «amoralità» o «inoperosità» per i «Chicago boys» della scuola neoliberale e, oggi, concausa dell’«inadempienza» dell’Europa a trazione neoprussiana.
D’altronde proprio il tedesco Walter Benjamin restò estasiato dell’alterità napoletana rispetto alla razionalità tedesca, coniando il concetto di «porosità», ossia luogo dove persiste un’«unità di uomini e pietre», e nessuna forma – sociale o architettonica – è «per sempre»: Napoli, soggetta a un continuo divenire, un transitare da uno stato all’altro che è proprio il contrario del «tutto concluso di Berlino, la città-caserma»10.
Il ritmo Tarumbò agisce – non subisce! – il dispositivo del sé e i processi attivati dall’identità (razza, genere e classe), opponendo resistenza alle rappresentazioni e alle configurazioni fisse di tempo, spazio e appartenenza. Esso segue la «porosità» di Napoli, di una comunità in continuo divenire. In canzoni come Che calore, Chillo è nu buono guaglione, O’ Padrone, Napul’è, Il Mare, Pino Daniele dà voce appunto agli uomini e alle pietre, ai tanti volti della subalternità: narra lo sfruttamento lavorativo così come la miseria del disoccupato, restituisce la rabbia e i silenzi dell’identità di genere, così come la lotta di classe nel rapporto capitale-lavoro, e via di questo passo. Alcuni stralci di canzoni ridonano il senso di questa «storia minore»:
E mi chiamerò Teresa/ scenderò a far la spesa / me facce crescere ‘e capille / e me metto ‘e tacchi a spillo / inviterò gli amici a casa / a passare una giornata / senza avere la paura / che ci sia una chiamata / e uscire poi per strada / e gridare so’ normale! / e nisciuno me dice niente / e nemmeno la stradale. Chillo è nu buono guaglione /e vo’ essere na signora…
Oppure:
Adesso ha la tessera del partito / compra il giornale tutti i giorni / ma è un uomo finito / la mattina va a strillare al collocamento / tanto ‘ o sape ca è vennuto pe poco / e niente.
E il mare il mare / il mare sta sempe llà / tutto spuorco chino ‘e munnezza / e nisciuno ‘o vo’ guardà’.
Evitando scorciatoie identitarie e dispositivi inferiorizzanti, queste cartografie sonore raccolgono la voce dei senza voce, in una sorta di «letteratura minore». Al silenzio della «violenza epistemica» esse rispondono alla celebre domanda di Gayatri Chakravorty Spivak, «i subalterni possono parlare?»11.
In un certo senso il Neapolitan Power e i testi prodotti esercitano una sorta di parrhesia: sputano in faccia al potere la verità, a quella borghesia meridionale, quella parvenu e rancida, che tra egemonia culturale, clientelismo politico-criminale, incarna profondamente lo spirito gattopardesco del cambiare tutto, del cavalcare la retorica dell’arretratezza, per mantenere lo statu quo, mentre costruisce la propria identità in opposizione al completamente Altro: l’Altro che necessita di essere educato e civilizzato, e che di volta in volta viene battezzato come disoccupato, operaio, guaglione d’o bar, femminiello, ecc.
A ben guardare il tema dell’identità nel Neapolitan Power chiama in causa quello ben più radicale del movimento di liberazione afroamericano Black power. Senza eccedere in analogia, rischiando inopportune comparazioni, nondimeno elementi del Black power servono a inquadrare la funzione dell’identità e la formazione di un discorso critico che non se ne affranchi completamente quanto ne raccolga la sfida in processi di soggettivazioni altri. Il Black power è l’affermazione simbolica non del potere nero, bensì di una soggettività altra, di una subalternità che prende parola: affermazione di un’alterità rispetto alla società bianca.
Tra gli anni Sessanta e Settanta, negli Stati uniti, il Black power è stato affermazione della crisi dell’universalismo, di un modello rivelatosi falsamente realizzato, infatti, l’ipocrisia risiedeva nel linguaggio fondato sui diritti, mentre sanciva l’esclusione e la marginalità. D’altro canto proprio le contraddizioni di razza, di classe e di genere sono state il fondamento su cui si è andato costruendo il modello americano. E non solo. Le stesse nazioni nell’Ottocento hanno trovato la propria fondazione in quelle contraddizioni, così come la stessa Unità italiana. Il Black power, dunque, è l’affermazione di soggetti subalterni, che rivendicano la presa di parola; ma è anche la rivendicazione di una soggettività che vuole usare altri linguaggi, altre parole, altri immaginari per significarsi e per imporre la propria presenza nello spazio pubblico. Uno spazio pubblico né omogeneo, né liscio, che andava riempito di contraddizioni, in primis quelle di razza e di genere12.
Allo stesso modo, il Neapolitan Power, nel suo piccolo, è stato l’affermazione di una diversità di linguaggi, di un’alterità di immaginari, a dispetto delle immagini stereotipate, per dare nuovo significato alla propria identità e alle indentità subalterne. Nero a metà, l’album di Pino Daniele del 1980, forse, coglie profondamente questo processo.
In effetti, proprio Pino Daniele, con il suo «mediterraneo blues», ha avuto il «coraggio di trattare la tradizione come luogo di traduzione e di transito, creando così uno squarcio nel mondo locale attraverso cui faceva illuminare il nostro presente con la luce dei blues per offrirci un altro spazio storico e culturale in cui vivere Napoli e il Mezzogiorno come soggetti storici e non come le solite vittime di altre narrazioni elaborate altrove»13.
In tal senso, esemplare è la canzone Bella ‘mbriana, il cui testo dona icasticità a una narrazione subalterna, a una credenza popolare napoletana sullo spirito benefico della casa, dando dignità a ciò che Ernesto De Martino, da par suo, ha osservato come studi sull’«altra Europa». Oppure la canzone Tutta n’ata storia, con echi a un’altra sua canzone Terra mia, in entrambi i testi il cantautore napoletano affronta il tema dell’emigrazione, per un verso, e per un altro il desiderio di libertà da ricercare nella propria terra – Napoli – rifiutando di abbandonarla in cerca della felicità in una terra lontana – l’America – che non può offrire «tutta un’altra storia», un’altra vita.
Dunque, il Neapolitan Power è stato soprattutto una pratica di «travelling cultures»14, ove il viaggio sta per «traduzione» e «dialogo» tra soggetti e universi culturali diversi, di incontri e di fusioni, ma anche di conflitti e di resistenze originati dall’interazione tra il locale e ciò che viene da fuori e passa attraverso, cioè il globale. Nel Neapolitan Power ritroviamo quelle che Chambers ha chiamato le «vene blu che attraversano il tessuto urbano»15: i suoni del Mediterraneo, quali le intonazioni mutevoli della voce, i melismi, la lunga storia di improvvisazioni musicali del mondo arabo, accolti nei suoni metropolitani, quelli della diaspora nera, il blues e il jazz, e nei suoi derivati, le culture urbane dal basso.
Effettivamente è la stessa musica del Neapolitan Power in grado di generare fenomeni in continua produzione – con Stuart Hall, «processi eternamente in atto» – che vanno letti sempre in senso politico, nel loro rapporto con il potere, o meglio nel rapporto fra la parte subalterna e la parte egemonica della società16. Così, le immagini tratteggiate da Pino Daniele, i soggetti popolari, talvolta pittoreschi, che sembrerebbero surrogare le rappresentazioni naturalizzanti, gli stereotipi e i luoghi comuni sulla Napoli popolana, riempiono, al contrario, gli spazi di quelle rappresentazioni attraverso le stesse contraddizioni e gli stessi difetti che ne danno fondamento. In altre parole, la forza e il significato di quelle immagini risiede tanto nella presa di parola dei soggetti reali quanto nell’uso della lingua volgare, nell’appropriazione del folclore e della cultura popolare, i cui effetti sono proprio il disinnesco dell’«ordine del discorso dell’orientalismo»17.
 Infatti, secondo Gramsci solo riuscendo a non considerare più il folclore e la cultura popolare come una «bizzarria», ma come una «cosa molto seria», si colma il distacco tra la «cultura borghese», la «cultura degli intellettuali» e la «cultura popolare», la «cultura degli umili». Allo stesso tempo, proprio la stereotipata concezione del rapporto tra «semplici» e «intellettuali», cioè il modo di rappresentarsi, rinforza l’omologazione culturale, quale dispositivo politico ed economico esercitato dai «ceti egemonici» ad onta dei «ceti subalterni»18.Dopotutto il rappresentare è uno strumento molto ambito dalla cultura borghese, ancorché un dispositivo di cattura dei desideri dei subalterni: il rappresentare esercita un doppio potere, quello di rendere presente ciò che è assente e di costituire legittimità di questa presenza esibendo qualificazioni, giustificazioni e titoli. La tragedia risiede nel desiderio dei «ceti subalterni» di avvicinarsi ai modelli dei «ceti egemonici», parafrasando Pasolini, quando i subalterni «iniziano a vergognarsi di esserlo». Il cortocircuito di tale dispositivo accade invece nel momento in cui si afferma un’identità culturale. Durante un concerto, gli urlarono «impara a parlare!», Pino Daniele rispose, «nun fa niente parla’, l’importante è sape’ suna’».
Infatti, secondo Gramsci solo riuscendo a non considerare più il folclore e la cultura popolare come una «bizzarria», ma come una «cosa molto seria», si colma il distacco tra la «cultura borghese», la «cultura degli intellettuali» e la «cultura popolare», la «cultura degli umili». Allo stesso tempo, proprio la stereotipata concezione del rapporto tra «semplici» e «intellettuali», cioè il modo di rappresentarsi, rinforza l’omologazione culturale, quale dispositivo politico ed economico esercitato dai «ceti egemonici» ad onta dei «ceti subalterni»18.Dopotutto il rappresentare è uno strumento molto ambito dalla cultura borghese, ancorché un dispositivo di cattura dei desideri dei subalterni: il rappresentare esercita un doppio potere, quello di rendere presente ciò che è assente e di costituire legittimità di questa presenza esibendo qualificazioni, giustificazioni e titoli. La tragedia risiede nel desiderio dei «ceti subalterni» di avvicinarsi ai modelli dei «ceti egemonici», parafrasando Pasolini, quando i subalterni «iniziano a vergognarsi di esserlo». Il cortocircuito di tale dispositivo accade invece nel momento in cui si afferma un’identità culturale. Durante un concerto, gli urlarono «impara a parlare!», Pino Daniele rispose, «nun fa niente parla’, l’importante è sape’ suna’».
Questo articolo è stato pubblicato su alfabeta2 il 25/01/2015
I. Chambers, Mediterraneo blues. Musiche, malinconia postcoloniale, pensieri marittimi, Torino, Bollati Boringhieri 2012, p. 29. ↩
E. Said, Sempre nel posto sbagliato. Autobiografia, Milano, Feltrinelli 2009, p. 308. ↩
G. Deleuze – F. Guattari, Millepiani. Capitalismo e schizofrenia, a cura di M. Guareschi, Roma, Castelvecchi 2006, p. 36. ↩
Nasce alla fine degli anni Sessanta con gli Showmen di Mario Musella – morto a 35 anni cui Pino Daniele ha dedicato l’album Nero a metà – e del sassofonista James Senese, entrambi figli della guerra, la Nuova Compagnia di Canto Popolare di Roberto De Simone e, negli anni Settanta, con Napoli Centrale di James Senese. Con Pino Daniele e la super band – Tullio De Piscopo alla batteria, Rino Zurzolo al basso, James Senese al sax, Tony Esposito alle percussioni e Joe Amoruso al piano – però, raggiunge la massima espressione e diffusione. ↩
G. Deleuze, Cos’è un dispositivo?, Napoli, Cronopio 1998. ↩
I. Chambers, op cit. p.18. ↩
Terra mia, 1977; Pino Daniele, 1979; Nero a metà, 1980; Vai mò, 1981; Bella ‘mbriana, 1982. ↩
Tarumbò, brano contenuto nell’album Bella ‘mbriana. ↩
F. Piperno, Elogio dello spirito pubblico meridionale. Genius loci e individuo sociale, Roma, Manifestolibri 1997. ↩
A. Lacis, W. Benjamin, Napoli, in Napoli a cura di E. Donaggio, Napoli, L’ancora del Mediterraneo 2000, pp. 39-41 ↩
C. G. Spivak, Critica della ragione postcoloniale, Roma, Meltemi 2004. ↩
A. Davis, Autobiografia di una rivoluzionaria, Roma, Minimun fax 2003. ↩
Ringrazio Iain Chambers per avermi suggerito questa osservazione. ↩
J. Clifford, Strade. Viaggio e traduzione alla fine del secolo XX, Torino, Bollati Boringhieri 2008. ↩
I. Chambers, op. cit., p. 7. ↩
S. Hall, Quando è stato il postcoloniale? Pensando al limite, in La questione postcoloniale. Cieli comuni, orizzonti divisi, a cura di I. Chambers e L. Curti, Napoli, Liguori 1997, p. 306. ↩
E. Said, Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente, Milano, Feltrinelli 1978, p. 13. ↩
A. Gramsci, Quaderni del carcere, vol. III, Q. 27 a cura di V. Gerratana, Torino, Einaudi, 1975, pp. 2311-13. ↩