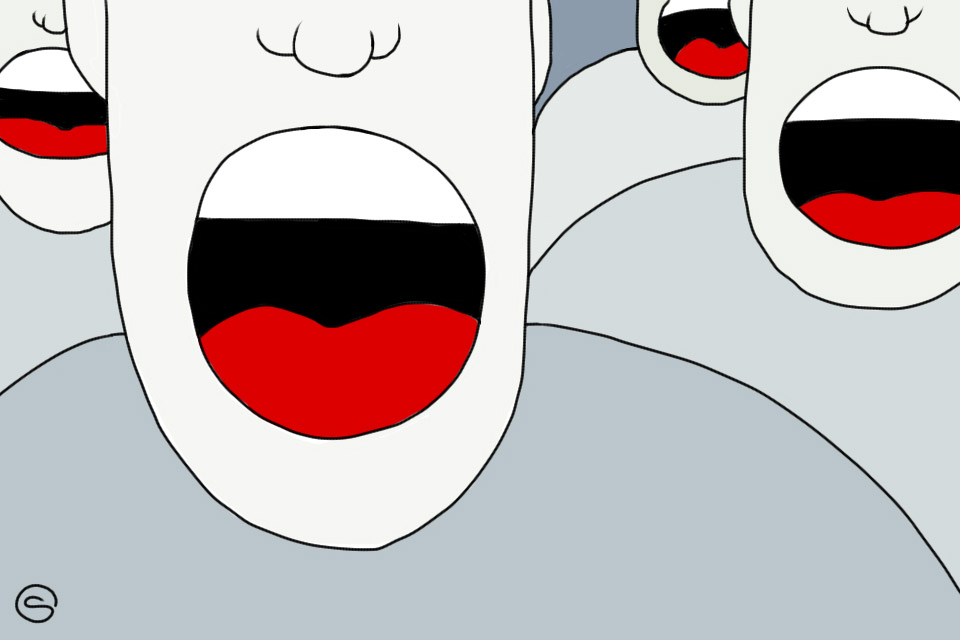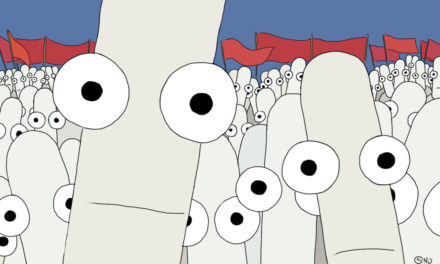Di BIAGIO QUATTROCCHI
Prima della pandemia i banchieri centrali erano preoccupati dalla tendenza deflazionista dell’economia. Presso la Bce e la Fed si era già consolidata una nuova convenzione teorica, secondo cui le politiche monetarie fortemente espansive, introdotte nel corso della «grande recessione», non avrebbero messo in pericolo la stabilità dei prezzi.
Tra il 2020 e il 2021 entrambi gli istituti decidono persino di modificare le proprie strategie di gestione monetaria, ammettendo nel breve periodo scostamenti transitori dei tassi di inflazione dal target del 2%. Il rischio di un momentaneo rialzo dei prezzi, dunque, non destava preoccupazione.
I banchieri centrali ritenevano, e ancora sostanzialmente ritengono, che i sindacati e le lotte economiche non sono strutturalmente in grado di minacciare aumenti congiunti di salari e dei prezzi. Lawrence H. Summers, ex segretario del Tesoro Usa (1999-2001), insieme ad A. Stansbury, entrambi docenti a Harvard, pubblicano nel 2020 un articolo dal titolo eloquente: The Declining Worker Power Hypothesis: An explanation for the recent evolution of the American economy.
Sarebbe andato tutto secondo programma, se la pandemia non l’avesse colti di sorpresa. Nonostante qualche voce fuori coro, nessuno si aspettava che la crisi da Covid 19 stimolasse una violenta e persistente esplosione dei prezzi.
Negli USA l’indice dei prezzi al consumo è aumentato del 7% nel 2021, con i prezzi della benzina in aumento di quasi il 60%, mentre i rincari delle auto usate hanno sfiorato il 30%.
Nell’Eurozona, secondo le ultime stime, il tasso di inflazione raggiungerà circa il 5% nell’ultimo anno, toccando il livello più alto dagli inizi degli anni ’90.
Nei paesi baltici lo squilibrio dei prezzi è stato ancora più intenso. In Estonia, solo per fare un esempio, l’inflazione a dicembre ha superato il 12%, raggiungendo il picco degli ultimi venti anni.
Jeremy Powel e Christine Lagarde, attualmente al vertice della Fed e della Bce, continuano a ritenere che il rialzo dei prezzi, seppur più persistente del previsto, sia comunque temporaneo. Resta altissima, tuttavia, la tensione all’interno dei direttivi delle due banche centrali.
Non è escluso, che presso la Fed soprattutto, i falchi prendano il sopravvento, chiedendo una accelerazione del tapering e il rialzo dei tassi di interesse, con tutte le gravi conseguenze che questo genererà sull’economia e sul futuro dei progetti della transizione ecologica e digitale.
All’inizio della pandemia Adam Tooze ha lucidamente definito questa crisi come «la prima crisi dell’antropocene», nell’intento di legare crisi ambientale e sanitaria, con quella economica. Allo stesso modo potremmo azzardarci a dire che questo nuovo fenomeno inflattivo costituisce proprio una delle espressioni di questa crisi “multilivello”.
Poiché origina dall’interno delle contraddizioni del modo di produzione contemporaneo, dunque, riguarda la natura dei rapporti sociali di produzione, investe le regole di funzionamento delle istituzioni finanziarie, fino ad arrivare al nesso profondo che lega sviluppo economico ed ecosistema.
LA VULNERABILITÀ DELLE CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO GLOBALI
Secondo la teoria economica dominante il rischio inflattivo cresce quando il tasso di disoccupazione effettivo scende al di sotto del suo livello “naturale” o di equilibrio, anche detto «tasso di disoccupazione a inflazione stazionaria» secondo Tobin (o NAIRU secondo la terminologia più in voga). In quel punto l’economia agirebbe oltre il suo livello di “produzione potenziale”, surriscaldandosi, generando inflazione.
La disoccupazione, dunque, non può mai scendere al di sotto di un astratto livello di equilibrio. Così come, la spesa pubblica non può sollecitare un aumento incondizionato dell’occupazione. La coscienza politica sapientemente occultata dietro le apparenze neutrali ed eleganti della matematica dell’economics mette in guardia, a chi di dovere, che il lavoro vivo organizzato potrebbe approfittarsene.
Al di là dell’inconsistenza teorica della nozione di “produzione potenziale” e di “disoccupazione naturale” (naturale per chi?), il punto principale è che la teoria economica borghese è così rigidamente ossessionata dall’ obiettivo di disciplinare la forza lavoro, che oggi sembra incapace di interpretare teoricamente l’origine di questa inflazione, che deriva da altre contraddizioni del sistema capitalistico.
A luglio 2021 un gruppo di economisti della White House ha accostato l’attuale rialzo dei prezzi all’ondata inflattiva del secondo dopo-guerra. Anche allora le interruzioni della catena di approvvigionamento, combinate con la ripresa post-bellica della domanda di consumo, sollecitarono l’inflazione.
Solo un mese prima, il governo Biden, ha emesso un poco noto ordine esecutivo rivolto alle agenzie federali per proteggere e rafforzare le proprie catene di approvvigionamento.
Nel corso della prima ondata pandemica all’inizio del 2020, quando Wuhan è stata sigillata con l’esercito e la Cina ed altri paesi sperimentavano il lockdown, si sono manifestate le prime interruzioni dei flussi nelle global supply chain.
Le strozzature sono continuate in maniera irregolare sul piano spaziale e in forma asincronica lungo le catene globali del valore, prendendo di mira alcune particolari merci. Mentre il virus sars-cov2 continua a variare come conseguenza dei forti limiti nella gestione pandemica a livello mondiale, il fenomeno delle “ostruzioni” nella logistica si è rivelato un problema persistente.
Si è partiti con una iniziale scarsità di semiconduttori e altri microchip fabbricati nella provincia cinese di Hubei, impiegati nell’assemblaggio di device elettronici, nelle auto e in altri beni durevoli.
In Cina, molto prima che altrove, la produzione è ripresa già nell’ultimo trimestre del 2020. Nel mentre la domanda di consumo aggregata americana ed europea – espressa da soggetti incarnati che sperimentavano un nuovo stile di vita carico di incertezze, impoverito dall’assenza di relazioni sociali e da ristrettezze economiche – si è riorientata inizialmente sull’acquisto di servizi delle piattaforme digitali di rete o alcune tipologie di beni tecnologici, in linea con i bisogni ai tempi del coronavirus (secondo la stampa stay at home economy).
Ciò ha comportato un riaggiustamento just in time della logistica globale in modo da soddisfare questa nuova momentanea composizione della domanda di consumo.
Con l’affievolimento dei blocchi alla produzione negli Stati Uniti e in Europa e la successiva ripresa graduale di tutte le produzioni di merci, c’è stato un secondo aggiustamento nella composizione interna della domanda aggregata di consumo, con un ritorno in forze dei beni manifatturieri nei panieri dei consumatori compensato da una scarsa domanda di servizi, perché il sopraggiungere delle ondate pandemiche ha messo in ginocchio una buona parte del sistema terziario che costitutivamente ha bisogno di relazioni sociali eccedenti e flussi metropolitani intensi.
È così che, dunque, è entrato in crisi il sistema degli ordinativi che regola il ritmo della produzione e della circolazione di merci lungo le catene del valore transnazionali.
Come segnalato da Hyun Song Shin, economista della Bank for International Settlements, a un certo punto si è venuto a creare il paradosso di crescenti segnalazioni di carenze e ritardi nelle consegne di semilavorati alle imprese, combinate, però, con una offerta di fattori produttivi chiave (come i semiconduttori) che ha superato persino i livelli pre-pandemici.
Come se non bastasse, gli squilibri prodotti nel cervello logistico, a cascata, hanno coinvolto altre merci non tecnologiche, causando l’inedito fenomeno di navi cariche di merci ferme nei porti, in attesa dei porta container.
Richard Galanti, chief financial officer di Costco, la seconda catena di supermercati statunitense, già a settembre 2021 confermava che le pressioni inflazionistiche sui prodotti alimentari sono in parte attribuibili proprio al blocco dei container, al ritardo dei trasporti e ai problemi registrati nei porti.
“Ostruzioni”, “arresti”, “picchi di produzione” hanno rappresentato la metrica sincopata e contrastante della cosiddetta ripresa economica e hanno contribuito, quindi, a far lievitare i prezzi in alcuni punti delle catene del valore, dove non tutte le merci ne hanno risentito allo stesso modo.
Chi in questi mesi ha parlato di inflazione come risultato di una classica crisi dal lato dell’offerta, sintomo di una generalizzata scarsità di merci, non ha probabilmente afferrato il complesso funzionamento dell’«eco-sistema logistico» contemporaneo, il nuovo «segreto laboratorio» dell’accumulazione capitalistica.
Non è un caso, ad esempio, che nel pieno della pandemia le imprese non finanziarie posizionate sui punti chiave delle filiere globali, a cui corrisponde un maggiore potere di mercato, hanno accumulato enormi margini di profitto, come ci avverte Isabella Weber sul “Guardian“.
Mentre un recente rapporto della Janus Henderson investors, chiarisce che per quelle quotate in borsa è andata anche meglio, dal momento che il III trimestre del 2021 si è concluso con un incremento dei dividendi pari al 22% a livello globale.
Un differente fronte del mainstream economico, tra cui Lawrence H. Summers e Olivier Blanchard (qui e qui) ex capo economista del FMI, sin dall’inizio della crisi sanitaria hanno avvertito che i consistenti stimoli fiscali del governo Biden avrebbero condotto all’inflazione, poiché avrebbero spinto la domanda effettiva oltre la capacità produttiva sottostante dell’economia (in altri termini avrebbero portato il cosiddetto output gap, da negativo a positivo).
Una tesi che ha conquistato consenso nelle componenti più moderate del partito democratico americano e che ha portato al recente parziale ridimensionamento di alcuni programmi fiscali negli Usa, tra cui il Build Back Better.
Il non detto di questa tesi è che un minore stimolo fiscale, compreso un investimento ridotto in Welfare, se da un lato, avrebbe sicuramente prodotto un aumento delle diseguaglianze ancor più violento, con tassi elevati di disoccupazione maggiormente persistenti, dall’altro, non avrebbe avuto nessuno effetto positivo sul contenimento dei prezzi.
Una posizione che, per altro, suona anche come un atto di resistenza di coloro che provano a evitare la formazione di una nuova convenzione tra gli economisti ortodossi, nella quale i programmi fiscali espansivi potrebbero conquistare una nuova legittimità teorica oltre che politica.
Parole molto condivisibili, invece, sono arrivate da alcuni contributi di James K. Galbraith. Dal momento che la crescita dei prezzi non può essere attribuita a un generico squilibrio dal lato della domanda come conseguenza delle politiche fiscali espansive (tesi che non tiene conto del cambiamento profondo delle forme di vita, espresso anche attraverso nuovi bisogni di consumo e accesso a specifici valori d’uso), né dal lato dell’offerta, come riproposizione di problemi classici di scarsità, allora la questione in ultima istanza riguarda esattamente la razionalità e il funzionamento interno delle global supply chain.
È ancora una volta Galbraith ad aggiungere lucidamente che la controversia, dunque, «non è la loro poca efficienza, ma la troppa. Per essere precisi, l’estrema efficienza delle catene di approvvigionamento globali di oggi è anche il loro difetto fatale».
Aver congegnato i sistemi logistici annullando le scorte, stabilendo che qualsiasi capacità in eccesso costituisca un costo da minimizzare, tutto ciò le rende anche molto vulnerabili.
Con la pandemia che entra nella fase endemica e con tutte le incertezze connesse al climate chaos, la vulnerabilità delle reti costituisce una vera e propria contraddizione interna per il capitalismo difficilmente trascurabile.
LO SHOCK ENERGETICO E LA CRISI AMBIENTALE
Le statistiche mostrano l’impennata dei prezzi dell’energia, che hanno notevolmente contribuito all’aumento dell’indice generale dei prezzi al consumo in diverse aree globali.
«Che ci piaccia o no, viviamo all’ombra della Cina», così parte un illuminante contributo di Adam Tooze sull’inflazione dei prezzi energetici.
È necessario tener conto, come avvertono gli analisti di Wood Mackenzie, che «la crescita economica della Cina di oltre l’8% nel 2021 ha innescato un’impennata della domanda di energia: il consumo di elettricità della Cina è cresciuto del 10%, che è stata la crescita annuale più rapida per qualsiasi grande economia nella storia registrata del settore».
La crescita dei prezzi dell’energia, insieme agli aspetti delle catene di approvvigionamento, forse aiutano a comprendere come l’attuale ondata inflattiva sia intimamente connessa al modello di accumulazione storicamente determinato, investendo completamente il problema della crisi ambientale e sanitaria che minaccia le nostre vite.
Il rimbalzo dell’economia cinese, dopo la fine delle prime chiusure, ha prodotto un aumento vertiginoso della domanda di carbone, in un mondo in cui la produzione di energia della Cina si basa su quasi un terzo del consumo mondiale del minerale nero.
A partire dal XIV piano quinquennale del governo Xi Jinping, la Cina ha avviato la sua lenta transizione energetica (fortemente contestata dai movimenti ambientalisti).
Nei programmi governativi il gas è diventato il “combustibile ponte” per la transizione ecologica, trasformandosi contemporaneamente nel punto di tensione del sistema energetico mondiale; in un mondo in cui – grazie alle lotte ambientaliste – il capitalismo avvia i primi programmi di transizione ecologica.
Proprio come conseguenza dei vincoli del nuovo piano quinquennale, nel 2021 si è registrato anche un aumento della domanda cinese di gas, diventata il principale canale di trasmissione dell’inflazione dei prezzi dell’energia dalla Cina all’Europa, dove il consumo di gas costituisce, invece, una fonte fondamentale per la produzione energetica.
Dal momento che il gas rappresenta, ad oggi, solo una piccola parte del mix energetico cinese, tutto farebbe pensare che la tensione dei prezzi su queste materie potrebbe affievolirsi; se non fosse, però, che sul fronte dell’Europa orientale si accendono tensioni di guerra che complicano notevolmente la geopolitica energetica globale.
In una recente intervista, la tedesca Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Bce, sembra confermare il nesso tra transizione ecologica e inflazione, facendo trapelare la sua forte preoccupazione: «sono in corso dibattiti sull’impatto della transizione verde sull’inflazione. Se porta a un aumento dell’inflazione, la politica monetaria deve reagire».
SALARI E PREZZI
Negli anni ’70 nella gran parte dei paesi occidentali l’inflazione si era attestata stabilmente intorno alle due cifre e il dibattito tra i banchieri centrali si concentrò su come reagire all’aumento dei salari e all’oramai insostenibile potere di classe dei subalterni.
Arthur Burns, a capo della Fed tra il 1970 e il ‘78, ancora riteneva che «la politica monetaria potrebbe fare ben poco per arrestare un’inflazione che si basava così pesantemente sulle pressioni dei costi salariali».
Il punto di svolta, come noto, si ebbe solo con il «Volcker shock» del 1979, dal nome dell’allora presidente della Fed Paul Volker (1979-1987), che segnò la più violenta risposta alla stagflazione (crasi di stagnazione e inflazione) degli anni ’70.
Il forte rialzo dei tassi di interesse fece aumentare consistentemente la disoccupazione, con l’intento, ampiamente riuscito per altro, di contribuire a disciplinare la forza operaia.
Fu una vera e propria “rottura costituente” nella gestione della politica monetaria che preparò la strada a Ben Bernanke (1987-2006), e a ciò che lui stesso definì più tardi come la «grande moderazione».
Ovvero, l’inizio di un lungo ciclo del capitalismo segnato da stabilità dei prezzi dei beni di consumo insieme ad una elevata inflazione del valore dei titoli finanziari. Due facce inseparabili della stessa medaglia. Lo yin e lo yang del capitalismo finanziarizzato. Due aspetti, inutile dirlo, che hanno modellato a fondo la costituzione materiale delle principali istituzioni monetarie, dalla Fed alla Bce soprattutto.
Un lungo ciclo economico di sostanziale stabilità proseguito – tra forte riduzione del potere di classe della forza lavoro e massiccia integrazione nel circuito monetario della finanza attraverso l’indebitamento – fino alla crisi del 2007. Se così stanno molto brevemente le cose sul piano storico, torniamo a chiederci cosa segnala, allora, questa nuova spinta inflattiva?
Un rilevante studio empirico sull’inflazione americana, ad opera di economisti della Bank for International Settlements, si è imposto nel dibattito. Dopo la svolta di Volker alla Fed, fino alla metà degli anni ’80 i prezzi dei tre principali aggregati (beni durevoli, non durevoli e servizi) dell’indice generale dei prezzi al consumo hanno continuato a muoversi sincronicamente.
Dopo quel periodo, invece, si è assistito gradualmente in Usa a una inedita asincronia nell’andamento dei prezzi, fino ad arrivare ad una forte dispersione del valore delle singole merci (lo studio considera ben 131 mercati ristretti).
Complice di questa irreversibile novità capitalistica è, da un lato, la radicale modificazione del modo di produzione lungo le catene del valore globale, dall’altro, il connesso fenomeno della «moltiplicazione del lavoro», per dirla sinteticamente con l’efficace espressione di Mezzadra e Neilson, così come l’esplosione di ampissime aree di lavoro vivo completamente de-salarizzato, o reso “invisibile” dall’affermazione dei processi estrattivi del capitale.
L’altra faccia della variabilità dei prezzi delle singole merci (anche sul piano internazionale) corrisponde alla graduale perdita di peso della «componente comune dell’inflazione» nella spiegazione dell’andamento generale dei prezzi al consumo, su cui si fonda la concettualizzazione stessa dell’inflazione nella teoria economica dominante.
A sua volta – e questo per noi è rilevante – la perdita di peso del «fattore comune» dell’inflazione ci riporta al cattivo funzionamento della cosiddetta «curva di Phillips» (che regolerebbe il rapporto tra l’andamento dei salari e dei prezzi), uno strumento teorico fondamentale su cui si sono fondate le politiche pubbliche (di governi e banche centrali) almeno dagli anni ‘70.
La “crisi” del «fattore comune» dell’inflazione, dunque, è inseparabile dalla “crisi” del funzionamento della «curva di Phillips»; che come più volte evidenziato negli ultimi anni nel discorso degli economisti eterodossi sarebbe oramai diventata strutturalmente piatta, poiché la variazione dei salari ha scarse capacità di trasferirsi linearmente sui prezzi.
La domanda che ci dobbiamo porre riguarda le implicazioni politiche che la crisi del «fattore comune» dell’inflazione potrebbe avere, nel contesto segnato dalla tensione dei prezzi.
Una delle conseguenze più importanti politicamente, e forse abbastanza sottovalutata, riguarda l’impasse dei banchieri centrali che fotografa questo momento di stallo dei poteri, dopo una fase di indiscusso dominio della scena della politica economica caratterizzata proprio dal Central bank-led capitalism, a seguito della grande recessione mondiale.
Nel momento in cui i prezzi hanno un andamento a-sincrono e il «fattore comune» dell’inflazione non ha più la stessa funzione-chiave, le banche centrali è come se avessero relativamente perso alcuni canali di trasmissione delle proprie decisioni connesse al governo dei tassi di interesse.
I banchieri centrali hanno sapientemente contribuito ad indebolire la forza antagonista del lavoro vivo. Così facendo, però, accecati dalla loro stessa arroganza hanno dovuto pagare il prezzo alto di privarsi dell’essenza stessa di «Das Kapital», la sua essenziale natura di rapporto sociale, l’unica che è in grado di assicurare la contraddittoria possibilità per il capitalismo di generare livelli accettabili di riproduzione sociale, come riflesso delle lotte dispiegate dai subalterni.
È la manifestazione di un antico paradosso, ogni volta difficile da accettare, che le crisi capitalistiche quando non sono direttamente impresse dalla capacità di lotta della forza lavoro, possono essere, al contrario, il riflesso della loro stessa passività, della difficoltà di iniziativa politica del lavoro vivo.
Dire questo non significa in nessun modo sottovalutare le tensioni nel mercato del lavoro e i conflitti sociali più espliciti che negli Usa e in Europa vanno dispiegandosi in alcuni settori del lavoro.
Gli uffici delle banche centrali, infatti, un po’ per riflesso incondizionato un po’ per scaricare sempre le responsabilità sulla forza lavoro, in queste settimane hanno gli occhi puntati proprio sull’andamento dei mercati del lavoro.
Le retribuzioni del quartile più basso dei lavoratori americani a novembre sono aumentate di circa il 5%, contro il 2,7% dell’ultimo quartile, mentre in Europa la dinamica è assai più contenuta.
Il nuovo rilevante protagonismo sindacale americano, le campagne del fight for $15, hanno indubbiamente contribuito a generare questo importante risultato. Accanto a questo, le ampie misure di sostegno del governo Biden per contrastare la disoccupazione – ribattezzate dalla stampa americana come stimmy economy – hanno indubbiamente contribuito a modificare le condotte della forza lavoro.
È significativo, ad esempio, che agli osservatori delle sottoculture non sia sfuggita la nascita di una vera e propria colonna sonora del nuovo welfare americano, con più di 30 canzoni hip hop nate negli ultimi anni, come quella di Curties Roach.
Sono fenomeni estremamente interessanti che ci autorizzano a parlare di inedite rigidità della forza lavoro sviluppate in forma molecolare, il più delle volte non organizzate, che esprimono una microfisica di controcondotte, l’indisponibilità ad accettare lavori sottopagati in un contesto in cui regna ancora il rischio di contagio.
Manifestazioni di micro-resistenze, dunque, che in parte sono anche connesse al più generale fenomeno della great resignation, soprattutto negli Usa e decisamente meno in Europa (compreso l’Italia). Tutte questioni su cui è necessario indagare, senza tuttavia perdere di vista la complessità di tali fenomeni.
Secondo alcuni dati della filiale new yorkese della Fed, ad esempio, i beneficiari degli incentivi hanno utilizzato almeno un terzo degli aiuti per ristrutturare i debiti precedentemente accumulati verso le banche, chiarendo che queste interessanti forme di “rigidità” della forza lavoro, ovviamente, si danno su un terreno in cui opera ancora la forza del controllo finanziario sulle vite.
Al netto di tutto ciò, il punto con cui bisogna realisticamente fare i conti è che questi rilevanti fenomeni, in assenza di lotte più larghe ed esplicite, capaci di coinvolgere ampi segmenti della forza lavoro, difficilmente condurranno a una nuova spirale salari-prezzi.
LA TRAPPOLA DEL BANCHIERE CENTRALE E LE LOTTE
Esiste una relazione, del tutto ignorata dalla teoria economica dominante, che lega l’inflazione all’accumulazione di capitale e al progresso tecnico (o innovazione).
In un tempo segnato dal discorso e dalle iniziative concrete sulla transizione ecologica e digitale del capitalismo, forse ha una qualche utilità riprendere questi nessi. Nel 1912 Schumpeter pubblica la sua Teoria dello sviluppo economico.
Il punto che più ci interessa in questo caso della sua teoria macro-monetaria di produzione, tralasciando alcune aporie del suo pensiero, è che l’accumulazione di capitale e l’innovazione capitalistica si producono necessariamente attraverso un processo di inflazione.
L’insieme della classe degli “imprenditori innovativi” – direbbe l’economista austriaco – per avviare la produzione prende a prestito moneta dal settore finanziario, che la crea ex nihilo.
Con questi nuovi mezzi monetari i capitalisti comperano forza lavoro e mezzi di produzione. Poiché in questo punto del processo la domanda di mezzi monetari è aumentata senza un proporzionale aumento delle risorse disponibili, si verificano le condizioni per una ondata inflattiva. Al momento non sappiamo quanto persistente sia l’attuale inflazione, potrebbe probabilmente ridursi come si aspettano le banche centrali. In ogni caso, ci interessa porre il dito su una questione.
Se nel recente passato le ondate di innovazione non hanno generato inflazione, secondo l’ipotesi di Schumpeter, è essenzialmente perché il lavoro vivo è stato momentaneamente sconfitto sul terreno della sua capacità di organizzazione ed è stato, contestualmente, integrato nelle logiche dell’accumulazione finanziaria mediante l’indebitamento di massa.
Quello che però ci dice Schumpeter, al di là del rapporto salari-prezzi, è che comunque nelle fasi di transizione dei modi di produzione si mette in moto un sistema articolato di tensioni che lavorano a favore dell’inflazione. Questa volta, questo insieme di turbamenti, è particolarmente sollecitato dal rapporto conflittuale che lega ecologia e produzione.
In un altro contributo, un vecchio articolo di Lucio Castellano sul sesto numero di “Metropoli” (1981) dal titolo elogio dell’inflazione, l’accento viene posto sugli aspetti politici dell’inflazione, intesa come motore di redistribuzione e di conflitto.
L’autore ci ricorda che: «l’inflazione è sempre inflazione dei poteri, delle aspettative, dei comportamenti; è crisi del loro ordine naturale e della gerarchia che li disciplina».
Poco avanti aggiunge: «[l’inflazione] non è un falso movimento di superfice che nulla cambia nella produzione delle cose: proprio perché essa disancora la ricchezza dal lavoro prima ancora che la moneta dal valore, esprime la non naturalità dei rapporti sociali di mercato, li politicizza, per così dire togliendo la parola alle cose e tornandola agli uomini».
Assumere l’inflazione come un motore di conflitto è utile per vari motivi. Nella fase attuale è piuttosto chiaro che l’aumento del “tasso di crescita” dei prezzi produca una redistribuzione dai salari ai profitti, accendendo (speriamo) un potenziale campo di tensione sociale.
Dall’altro lato, è utile accendere un faro anche su un altro fenomeno, un altro corno della tensione politica, questa volta tutto interno all’equilibrio tra “frazioni di capitale”, tra profitto e rendita.
Il punto è che in un regime economico in cui i prezzi salgono e la curva dei tassi di interesse reali continua la sua discesa in zona negativa, si mette in moto una controtendenza nel processo redistributivo che favorisce le imprese indebitate a svantaggio del settore bancario (creditori), in un mondo in cui, comunque, l’accumulazione è dominata dal potere della finanza. Qui la domanda da porsi è fino a che punto questa controtendenza può durare?
Se queste tensioni tra “frazioni di capitale” dovessero crescere, l’unica strada da percorrere per la Fed e la Bce potrebbe inevitabilmente a un aumento dei tassi di interesse. Correndo, però, il rischio di frenare la crescita dell’economia e di fare esplodere il già elevato livello di debito pubblico dei principali paesi europei, accumulati nella fase pandemica, attivando una serie di altre conseguenze economiche, politiche e sociali in questo momento piuttosto difficili da calcolare.
Consapevoli che la risposta non può che essere prodotta collettivamente, dovremmo porci ancora un’altra domanda, ed ovvero, come attraversiamo, da parte nostra, questa impasse dei poteri?
È oramai evidente, soprattutto nel contesto italiano, che il livello di contrazione dei salari non è più accettabile. È stato di recente evidenziato da più parti che in anticipo sugli altri paesi europei, la dinamica salariale italiana è stata bloccata dalla profonda riforma delle relazioni industriali avviata con il famoso accordo notturno di luglio 1992, che ha aperto la travagliata stagione della concertazione.
Il punto è che adesso non hanno più ragione di esistere le resistenze, di parte governativa e di parte confederale, sull’introduzione di un salario minimo legale caratterizzato da alcuni semplici criteri di indicizzazione, così come dalla capacità di salvaguardare il livello dei salari minimi dei contratti collettivi “più forti”.
Servirebbe una iniziativa politica e sociale larga, assolutamente non settaria, in grado di guardare alle dinamiche sociali nel contesto europeo, che metta al centro la questione dei salari minimi, insieme, a una legge sulla rappresentanza sindacale capace di favorire inediti processi di autorganizzazione, compresa una più matura democrazia sindacale nei luoghi di lavoro, adeguata all’attuale moltiplicazione delle forme del lavoro contemporaneo.
C’è forse un altro insegnamento che potremmo trarre dalle tradizioni del riformismo radicale. Se proprio c’è bisogno di una politica economica capace di contenere la dinamica dei prezzi, allora diversamente da quanto sostenuto dal mainstream, la strada da imporre attraverso le lotte, imparando questa volta da Hyman Minsky, dovrebbe essere quella di una spesa pubblica espansiva capace di riequilibrare fortemente la composizione della domanda aggregata, contenendo i consumi privati più inflazionistici a favore di processi di socializzazione degli investimenti pubblici, ovvero a partire dal finanziamento delle istituzioni della riproduzione sociale, dalla sanità alla scuola e l’istruzione, dalle tecnologie di rete comuni ai trasporti, passando per investimenti sulla cura dell’ambiente.
Una delle strade necessarie, ma non sufficienti, nella prima crisi dell’antropocene.
Questo articolo è stato pubblicato su DinamoPress il 9 febbraio 2022. Foto di copertina da Flickr.