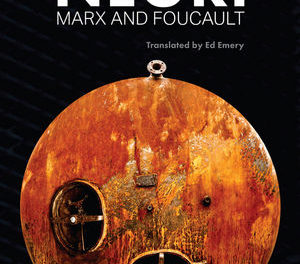di TONI NEGRI.
Fratello,
siamo qui,
per darti il cambio,
noi vinceremo,
ma da un altro
lato
Majakowskij, Lenin
Venivamo da un tradizione comunista e rivoluzionaria, rinnovatasi nella Resistenza antifascista, che ci era stata trasmessa dal Partito Comunista Italiano. Il culto di Lenin stava al centro di questa tradizione. Quando cominciammo a criticare o a rifiutare senz’altro la politica del PCI, non significò, negli anni ’60 e ’70, dimenticare Lenin. Anzi, se in quegli anni il marxismo resta l’asse di ogni presa di posizione critica dello stalinismo, il leninismo rimaneva centrale nella figura di un «autentico» marxismo nell’organizzazione operaia. E questo anche nel dibattito dei gruppi legati alle esperienze di intervento diretto sulle fabbriche – a quei gruppi operaisti che egemonizzano il movimento nel decennio successivo.
Lenin sta dunque al centro del dibattito. Per i giovani operaisti è la dimostrazione della possibilità della rivoluzione e il suggello della sua vittoria. E se il suo insegnamento e la sua esperienza rivoluzionaria vengono interpretate nelle più diverse maniere, dai vari gruppi politici che in quel periodo si formano, tutto avviene comunque in maniera avversa alla lettura che il PCI dà di Lenin. Nel PCI Lenin rappresenta la dittatura del proletariato, il Partito che la gestisce, il centralismo come linea di organizzazione del Partito e poi – a parere dei gruppi – il cinismo della politica delle alleanze, la strumentalità del rapporto operai/contadini (in Italia «nord e sud») l’opportunismo nel rapporto tra strategia e tattica. Questo giudizio era forse esagerato e tuttavia rivelava la corruzione cominformista e l’assoggettamento di Lenin al disegno stalinista di gestione del potere. Tale era il ruolo dei Partiti comunisti europei nel mantenimento dello status quo nella Guerra Fredda.
Varie sono le correnti che si organizzano su questa critica del PCI, attorno e dopo il ’68, differenziandosi in rapporto all’interpretazione del pensiero di Lenin. Ci sono i «maoisti»: più o meno si riferiscono alla Rivoluzione Culturale sviluppata in Cina dalle «guardie rosse» su appello di Mao, compongono un fronte che combina sollecitazioni anarchiche e rigide prescrizioni organizzative. Vi sono, fra i maoisti, correnti più morbide che concentrano il loro discorso essenzialmente sull’organizzazione – un’organizzazione che presto, nella pochezza dei mezzi e dei soggetti, scivola dall’assetto politico-organizzativo verso forme di comunitarismo e/o di vita generosamente o ingenuamente associata. Tra i più radicali, invece, la lettura maoista del processo rivoluzionario si distende nella discussione del rapporto fra organizzazione e guerra civile, meglio, dell’organizzazione per la guerra civile. Vi sono forme diverse in cui questo preteso leninismo si presenta: le fondamentali sono quelle guevariste (guerra di movimento organizzata attorno a «fuochi di guerriglia») oppure un progetto di guerra civile, rigidamente organizzato dall’iniziativa di partito (le Brigate Rosse si muoveranno in questa direzione, pur avendo in principio ondeggiato verso posizioni movimentiste).
In maniera originale e comunque strettamente legata ad un progetto organizzativo, la lettura di Lenin è fatta anche dai gruppi che si propongono una «lunga marcia attraverso le istituzioni». In questo proposito non c’è nulla di opportunistico, come non c’era stato nulla di opportunista nel progetto di Rudi Duschtke e della gioventù socialdemocratica tedesca quando lo slogan fu coniato. In Italia tuttavia, nei gruppi che propongono questa linea, essa è spesso interpretata come radicalizzazione di quel che essi riuscivano a recuperare, meglio, a scavare nel presunto gramscismo della tradizione comunista. Si trattava, nella maggior parte dei casi, di una libera ed onesta ripresa della gramsciana «rivoluzione passiva». Comunque ciò finiva con l’incrociarsi con le proposte avanzate dal PCI, fin dal periodo costituente della Repubblica, che, come si è ricordato, conducevano da un lato a un forte «centralismo democratico» nella questione dell’organizzazione (con la ferma subordinazione del sindacato alla linea del Partito) e d’altra parte ad un progetto di transizione democratico-parlamentare al socialismo. Nei nuovi gruppi che si formano attorno ad un progetto di radicalizzazione delle politiche del PCI, Lenin è recuperato essenzialmente come teorico della rottura rivoluzionaria, quindi di un processo di transizione al socialismo che rilanci l’opposizione della democrazia operaia alla dittatura borghese e capitalista. In fondo, per queste forze (il Manifesto, Avanguardia Operaia, ecc.) la lettura di Lenin resta agganciata alla tradizione pcista, meglio, alla lettura orientata in senso nazional-popolare ed epurata d’ogni elemento bolscevico, che Togliatti aveva fatto di Gramsci. Certo, nella posizione di questi gruppi, erano tolte di mezzo le illusioni comunitariste, minoritarie e settarie di gran parte delle costruzioni ideologiche del maoismo – e tuttavia era, a mio parere, messa in ombra la radicalità del progetto leninista.
Vi sono poi le posizioni (che già risaltano con un peso politico specifico all’inizio degli anni ’70) di quegli operaisti (Tronti, Cacciari, Accornero, ecc.) che a metà dei ’60 erano rientrati nelle organizzazioni ufficiali del movimento operaio, nel PCI in particolare. Ora la lettura di Lenin è qui essenzialmente (a differenza – e riprenderemo questo motivo – di quanto precedentemente teorizzato) portata non tanto sul Lenin insurrezionalista e bolscevico quanto al Lenin della «Nuova Politica Economica» (NEP) e del transitorio compromesso con le forze imprenditoriali, conseguentemente sul Lenin della dittatura del proletariato e del dirigente del Partito-Stato. Il discorso su Lenin comincia già qui a scivolare (politicamente e filosoficamente) verso la rivalutazione della «autonomia del politico» – nel senso, cioè, di un’assimilazione dell’insegnamento di Lenin a quello di Carl Schmitt. Su questa linea si recupera la tradizione politica del moderno, da Hobbes a Hegel, considerando «Lenin sullo Stato» non come teorico della sua estinzione ma come l’apologeta della sua trascendenza e potenza trasformatrice. Il Tronti postoperaista ha poi sviluppato per quarant’anni questo schema interpretativo e tuttora fa questa lettura di Lenin.
Obiettare che Lenin non era mai stato apologeta dell’«autonomia del politico» ma, ben diversamente, dell’«autonomia dell’avanguardia di classe», questa obiezione sta alla base della polemica degli operaisti, ancora impegnati dagli anni ’60 nella continuità delle lotte, a differenza dei sostenitori dell’«autonomia del politico». Si ragionava in questo modo. L’avanguardia di classe operaia ha in Lenin la capacità di porre il problema del potere perché, nell’epoca dell’organizzazione del lavoro nella forma della «cooperazione allargata», della «sussunzione formale» della società nel capitale, tipiche della prima industrializzazione in Russia, essa esprime ed universalizza l’interesse della classe operaia al fine di rivoluzionare e riorganizzare l’intera società sotto il suo comando e i suoi valori. Si faceva notare, contro la concezione dell’«autonomia del politico», che la pratica del Partito come avanguardia non celava, nella situazione leninista, la sua natura operaia ; che anzi, senza quell’avanguardia di classe operaia il proletariato – al livello di sviluppo industriale della Russia zarista – non sarebbe mai riuscito a farsi organizzazione per la rivoluzione. Lenin (quale che sia il fascino da lui esercitato su tutti i pensatori e gli attori del fascismo) non ha dunque nulla a che fare con Carl Schmitt. Lenin ha a che fare con Machiavelli, con la capacità di interpretare (e di agire) il rapporto tra composizione sociale di classe e organizzazione politica nella lotta per la conquista del potere. Questo è il Lenin degli operaisti, fra Lotta Continua, Potere Operaio e Autonomia Operaia, negli anni ’70. Il tema Lenin viene riproposto all’interno della prospettiva dell’insurrezione. L’arco delle letture che sostengono questa presa di posizione si estende fra György Lukács e Louis Althusser. È attraverso questi autori che è sviluppata una lettura marxista del marxismo di Lenin.
Le letture che di Lenin vengono fatte, negli ambienti operaisti in quegli anni in Italia, vanno tutte in questo senso. La genesi del pensiero di Lenin è costruzione di un soggetto d’avanguardia, immerso nella definizione della dimensione produttiva della classe operaia. La teoria dell’organizzazione deve passare attraverso una metodica che, attraverso una «sociologia marxista», traduca l’analisi dei rapporti sociali materiali, della «formazione sociale» determinata, in modello dell’organizzazione politica. Già nel 1894, in Chi sono gli amici del popolo, Lenin insiste che «soltanto riducendo i rapporti sociali a rapporti di produzione e questi ultimi a livello delle forze produttive» – è solo operando in questo modo che si può cogliere la possibilità di una fondazione politica ed organizzativa. E nel 1898, nel suo studio sullo Sviluppo del capitalismo in Russia, Lenin insiste sul fatto che soltanto ponendosi al livello della più alta astrazione del lavoro, cioè sul punto più alto dello sviluppo industriale – è solo allora che si potrà cogliere l’impianto di una forza rivoluzionaria nella lotta di classe. Questo procedimento rovescia, marxianamente, il senso corrente di determinazioni come «astratto» e «concreto»: ciò che sembra più astratto (lo sviluppo capitalistico, la fabbrica in un contesto sociale sottosviluppato com’è la Russia degli anni ’90 dell’Ottocento) diviene nella tendenza, nella sua comprensione rivoluzionaria, la cosa più concreta, il punto al quale l’organizzazione politica va commisurata. Non vi è nulla di più maxiano di questa determinazione leninista del processo organizzativo. Il Che fare? non è altro che la trasformazione di quelle scoperte teoriche in una proposta di soggettivazione.
Si intende cosi come il tema Lenin sia posto dall’operaismo e in quale coerente rapporto esso si sollochi con la lettura di Marx. Qual è l’enjeu? Far rinascere la lotta rivoluzionaria nell’Occidente capitalista. Ora, Lenin consente di immergere il tema politico della rottura dell’ordine capitalista nel processo sociale e nella prospettiva dell’organizzazione. Da un primo punto di vista, per gli operaisti, il discorso parte – oltre che dalla polemica feroce contro l’opportunismo del PCI – dalla ripresa della proposta gramsciana di «Marx contro Il Capitale», che significa polemica contro l’oggettivismo positivista, lo storicismo e l’opportunismo politico della Seconda Internazionale. Lenin è il segno della possibilità della rottura della continuità sovrana del potere e della continuità del profitto, organizzata dall’accumulazione capitalistica; è il segno di una determinazione politica soggettiva possibile. La lettura di Lenin è, a questo proposito, concentrata sugli scritti che portano a Stato e rivoluzione. Ma negli operaisti c’è qualcosa di più, ed è il lascito della lettura che Tronti (prima di essere tradito in una prospettiva schmittiana) ha fatto di Lenin. In Lenin in Inghilterrra, egli scrive: «la società capitalistica ha le sue leggi di sviluppo. Gli economisti le hanno inventate , i governanti le hanno applicate e gli operai le hanno subite. Ma le leggi di sviluppo della classe operaia, chi le scoprirà? Il capitale ha la sua storia e i suoi storici la scrivono. Ma la storia della classe operaia chi la scriverà?». A questo incipit brechtiano segue: «A livello di capitale socialmente sviluppato, le sviluppo capitalistico è subordinato alle lotte operaie, viene dopo di esse e ad esse deve far corrispondere il meccanismo politico della propria produzione». Ciò significa che il concetto di capitale è concetto di lotta di classe, che la struttura del capitale è scissa e formata nella/dalla lotta di classe. Ne viene, a questo punto, la riscoperta di Lenin:
La strategia leninista, con un colpo magistrale, portò Marx a Pietroburgo: solo il punto di vista operaio poteva essere capace di una simile audacia rivoluzionaria. Proviamo a fare il cammino inverso, con lo stesso spirito scientifico di avventurosa scoperta politica. Lenin in Inghilterra è la ricerca di una nuova pratica marxista del Partito Operaio: il tema della lotta e dell’organizzazione al più alto livello di sviluppo politico della classe operaia. A questo livello, vale la pena di convincere Marx a ripercorrere “la misteriosa curva della retta di Lenin’’.
Il «cammino inverso» doveva permettere di confrontare Lenin alla modificazione della struttura capitalista e della composizione operaia del modo di produrre, che si era data dopo la Rivoluzione d’Ottobre. Si trattava, cioè, fra il ’68 e i primi ’70, di attualizzare, in maniera leninista, la linea che conduceva dalla teoria critica del capitale alla teoria e alla pratica dell’organizzazione politica del proletariato. È qui che si apre un grande dibattito. Ora, il pensiero leninista è infatti confrontato all’attuale struttura del capitalismo ed alla presente figura della classe operaia, per dirla in breve al movimento dell’operaio massa. C’era dietro un radicale cambiamento della struttura del capitalismo che aveva condotto a compimento – per dirlo in termini marxiani – la formazione della «grande industria», ossia il passaggio dalla «sussunzione formale» alla «sussunzione reale» del lavoro sotto il capitale. In questo quadro – secondo gli operaisti – la struttura della classe operaia si era profondamente modificata, l’operaio massa comprendeva, raccoglieva, stringeva in sé e rendeva politicamente attiva quell’enorme forza produttiva che questo sviluppo aveva creato e che aveva interiorizzato alla classe operaia stessa. Quale differenza dalla classe operaia «qualificata», skilled nella specializzazione manifatturiera, solo « formalmente » sussunta nel capitale – e politicamente organizzata nei soviet e minoritaria nella società, con cui Lenin aveva avuto a che fare! Di contro, nei ’70, l’odierna classe operaia si muoveva con “spontaneità’’ enorme, con capacità di inventare continue e molteplici forme d’attacco contro il regime capitalista della produzione – e, soprattutto, la dimensione politica emergeva direttamente dalla lotta economica, si mostrava potente come una leva di lotta politica dall’interno della lotta salariale e della lotta sul tempo di lavoro. Era qui un’altra grande differenza dal modo in cui Lenin aveva – anche lui – estratto il modello di organizzazione dalla critica della struttura capitalista della produzione. Allora il Partito doveva trasformare la lotta economica del proletariato in una matura coscienza di classe. Oggi le cose andavano diversamente – lotta economica e lotta politica stavano insieme, l’una nell’altra. Non che Lenin disprezzasse o considerasse “minore’’ la lotta economica. Essa vale in ogni momento sia condotta: già nel 1898, nell’opuscolo I compiti dei socialdemocratici russi, Lenin esclama:
Se nel campo economico non vi è questione della vita operaia che non possa essere utilizzata per l’agitazione economica, neppure nel campo politico non vi è questione che possa servire per l’agitazione politica. Queste due specie di agitazione sono inseparabilmente legate nell’azione dei socialdemocratici, come le due facce di una stessa medaglia. L’agitazione economica e l’agitazione politica sono egualmente indispensabili per sviluppare la coscienza di classe del proletariato. L’agitazione economica e l’agitazione politica sono egualmente indispensabili come guida della lotta di classe degli operai russi, perché ogni lotta di classe è una lotta politica.
Lenin tuttavia radica il suo progetto su un modello di fabbrica nel quale il lavoro operaio organizzato rappresenta un’avanguardia all’interno del modo di produzione vigente e la classe operaia si riconosce in una condizione politica non solo indipendente ma separata. La sua indipendenza politica, fornitagli da una coscienza di classe sviluppata, doveva allora superare la distanza, la separazione dalla società (e dal resto del proletariato) ed imporle il comando operaio. Questo proposito era ulteriormente reso evidente dalla continua, feroce polemica contro ogni forma di populismo che privilegiasse forme consuetudinarie dell’organizzazione del lavoro e della vita rispetto a quelle della fabbrica.
Ci si è permesso ancora di esclamare, se la fabbrica restava al centro di entrambe le fenomenologie, quella del primo Novecento e quella degli anni ’60-’70, quale differenza, nell’uno e nell’altro caso, per quel che riguardava la classe operaia in lotta! Nel primo caso l’avanguardia politica trascinava il movimento di massa, il «tribuno politico» – come dice Lenin – guidava la forza-lavoro nella lotta. Nel secondo caso il movimento di massa si esprimeva in maniera autonoma, dura, compatta, e dalla sua spontaneità organizzata emergevano richieste irricevibili dal capitale, temi incentrati sulla distruzione dell’organizzazione capitalista del lavoro, del suo comando e della sua gerarchia, del suo governo della temporalità. Era lì attorno che si trattava, adesso, di costruire organizzazione. Il sindacato, dopo essere stato risvegliato dalle lotte colossali dell’«autunno caldo» del ’69, ha subito tentato di reintrodurre, già all’inizio degli anni ’70, forme organizzative («consigli di fabbrica») adatte a mediare e a rinnovare il rapporto tra fabbrica e politica generale, intendendo per «politica generale» la politica parlamentare del Partito. Da un lato, questi consigli di fabbrica, erano uno strumento vecchio, fallito nelle lotte del secondo dopoguerra perché presto ridotto in versione corporativa; dall’altro veniva cosi interrotta la linea che stimolava attraverso la lotta economica la massificazione politica capace di rompere le linee di assoggettamento sociale del proletariato. Quest’interruzione era in realtà un tentativo di mediazione dell’antagonismo di classe e di riconduzione della massa operaia alla continuità produttiva: rappresentava la negazione del principio leninista della discontinuità insurrezionale del movimento operaio rivoluzionario e di ogni strategia dell’evento, di ogni tattica di rottura.
L’enjeu di ricostruzione di un movimento operaio rivoluzionario si articola sui tempi dello scontro. Il ‘68 italiano era stato caratterizzato dalla confluenza del movimento studentesco e dei movimenti sociali nelle lotte degli operai industriali che, con lotte “spontanee’’ (sostenute cioè da una forte organizzazione interna alla fabbrica e indipendente dai sindacati), provavano a liberarsi dal giogo della regolazione economica capitalista. Le lotte portavano su rivalutazioni salariali, sulla diminuzione del tempo di lavoro e proponevano, in maniera generale, il tema della nocività del lavoro, contestavano la gerarchia e la divisione del lavoro in fabbrica. Alla pressione delle lotte di massa si aggiungevano comportamenti d’attacco, in genere legittimati dal movimento: forte assenteismo, fenomeni di sabotaggio, insubordinazione costante alla disciplina di fabbrica… Nelle aziende dove i tecnici prevalevano, si organizzavano esperienze operaie alternative nell’organizzazione del lavoro; nelle fabbriche chimiche era aperta l’indagine sulla condizioni ecologiche del produrre e le merci prodotte erano sottoposte alla prova scientifica di nocività. Ai movimenti di fabbrica si sono aggiunti i movimenti degli studenti di contestazione della scuola e del comando capitalista sul potere. Ed i movimenti sociali che hanno conosciuto un’amplissima gamma fra la ricerca di forme di controllo della governance delle istituzioni (scuola, ospedali ecc.) e, d’altra parte, azioni di “illegalità di massa’’ contro gli affitti, le tariffe dei servizi, fino a diffusi fenomeni di diretta appropriazione di merci e loisirs. Per tutto il «lungo ’68 italiano» ( che dura infatti un decennio) porre ordine e dare direzione a questi movimenti, costruire e collegare istanze di contro-potere sociale, furono allora i compiti che le organizzazioni si proposero. È in questo quadro che si può comprendere la centralità del tema «organizzazione» – quindi del tema «Lenin». In Italia, in quegli anni, non si può pensare organizzazione fuori da questo riferimento, non c’è alternativa né consigliare né comunitarista né altro che possa porsi credibilmente – vale solo l’approfondimento e l’adattamento del tema leninista, machiavelliano. Che conduce quindi a pensare l’organizzazione non più solo come fabbrica ma ormai come «impresa sociale». E l’insurrezione non più solo come «arte» ma come l’agire – massificato e istituzionalizzato – di un movimento che, di per sé, si configura come «doppio potere» (ma qui si aprirebbe un discorso troppo lungo da poter essere ora affrontato).
Vi era un altro quadro di ricerca ed anch’esso nasceva direttamente dall’insegnamento di Lenin. Era quello che conduceva dall’esperienza delle lotte e della loro organizzazione alla definizione di un programma rivoluzionario. Anche qui si partiva dal disegno leninista dell’insurrezione delle masse lavoratrici condotte da un’avanguardia che doveva consolidarsi in istituzioni di «contro-potere» sociale e cosi condurre al processo insurrezionale. Ora, come può organizzarsi l’avanguardia dell’operaio-massa in questo quadro? Quali differenze dall’organizzazione classica del proletariato rivoluzionario russo ? Una volta guardate le cose dal punto di vista dell’operaio-massa, la linea di condotta era semplificata poiché, nel dispositivo operaista di gestione delle lotte, era concessa come data l’interiorità della tematica economica alla dinamica politica. Questa relativa semplificazione (e la conseguente negazione della «mediazione» come elemento determinante dell’organizzazione) non permetteva tuttavia di ritrovare articolazioni efficaci fra tattica e strategia delle lotte. La massa si muove, la sua direzione è data, l’egemonia strategica le è concessa, ma la tattica, i passaggi, l’utilizzo delle occasioni/eventi, tutto ciò è da proporre come problema e da discutere. A parte la rozza riduzione del tema dell’avanguardia, e della sua articolazione interna al movimento di massa, alla semplice avanguardia armata (tema che negli anni ’70 non è stato irrilevante), il richiamo alla tematica leninista da parte operaista cercava altre vie di fuga – che eventualmente integrassero la variante armata ma che non venissero ad essa subordinate. Questa via di sviluppo è stata man mano identificata nella maturazione degli strumenti assembleari di decisione della lotta, degli obiettivi di questa e della loro propaganda sociale. Occorre fare attenzione a questo passaggio e non sottovalutarlo. La presa di parola assembleare e i processi di decisione assembleare, allora proposti e sperimentati, anticipano infatti, e prefigurano, proposte ed esperienze organizzattive rese poi possibili dalle tecnologie della comunicazione. La partecipazione è considerata elemento costitutivo della democrazia operaia nel corso del processo insurrezionale. L’avanguardia sta nella comunicazione e presto, con un improvviso impulso inventivo, saranno le Radio Libere, nella loro grande diffusione e nell’efficacia del loro lavoro, a riprendere questo incentivo assembleare.
Qui si apre un nuovo problema. Il tema assemblearista sarà infatti del tutto insufficiente a risolvere la crisi che si apre dopo il 1973. Ricordiamolo: è la prima crisi del petrolio ed essa segnala, dopo la decisione del governo americano (nel 1971) di sganciare il dollaro dall’oro, prima grande iniziativa neoliberale. È il momento della Trilaterale e della sua decisione – presa a livello globale – di finirla con i sommovimenti sociali e politici seguiti al ’68. Ora, a fronte dell’offensiva neoliberale, si sfasciano le residue reminiscenze leniniste nel discorso operaista. Se Lenin, come l’avevamo letto tra gli anni ’60 e i primi ’70, era servito a risolvere il rapporto tra molteplicità dei movimenti ed unità dell’obiettivo che ogni processo rivoluzionario proletario deve sapere gestire ; e se il tema dell‘unità-molteplicità era stato risolto a partire dall’inchiesta (e dalla scoperta della nuova composizione sociale del lavoro, quella dell’operaio-massa, riconducendo all’interno della classe il punto di unità), dopo il 1973 il contrattacco capitalista investe la classe operaia come tale. L’inchiesta, in questa fase, non rivela più la centralità della fabbrica, ma la sua dissoluzione, la diffusione sociale della produzione, il frammentarsi della divisione sociale del lavoro e l’emergere di nuovi settori trainanti. Il discorso leninista perde la sua pregnanza unificatrice perché perde qui il riferimento ad una unità, realmente impiantata nella lotta di classe. Di contro, questa operazione capitalista determina, in antagonismo alla spinta rivoluzionaria, un grande incentivo allo sviluppo delle forze riformiste ed opportuniste. Che cosa è più possibile recuperare del leninismo a questo punto?
Ci sono due linee che negli anni ’70 si susseguono dinnanzi a questo problema, entrambe costruite dall’«inchiesta operaia» e connesse alle modificazioni del modo di produrre. In primo luogo, se risulta sempre più difficile ricomporre la composizione tecnica dell’operaio-massa (attaccata e parzialmente distrutta dalla risposta neoliberale) in un’eventuale nuova figura politica, omogena ed unitaria, esistono larghi spazi, friches diffuse che il nuovo sistema produttivo e politico non riesce ancora a controllare e che diventano, in questo momento, i territori sui quali l’autonomia crea, in forma diffusa, momenti organizzativi, capacità di rottura della macchina capitalista della riproduzione sociale. Nelle metropoli e nelle zone extraurbane, dove l’industria si diffonde in piccole unità territoriali, si estende allora una nuova organizzazione operaia. È il momento dell’operaio sociale.
La distruzione capitalista della «grande industria» attraverso l’esternalizzazione produttiva e la costruzione di distretti delocalizzati viene inseguita dalle organizzazioni autonome che creano cosi nei territori luoghi di incontro e di mobilitazione. È interessante questo processo di organizzazione che intercetta la flessibilizzazione della forza-lavoro sui territori e sviluppa forma di lotta adeguate: comunicazione delle lotte di fabbrica in fabbrica, organizzazione della mobilità sui territori con cortei in movimento, blocchi dei trasporti, ecc. Sono lotte che ricordano quelle dei IWW e che si ripetono in fasi di trasformazione della composizione tecnica della classe operaia. In questo caso si stava appunto andando oltre la «grande fabbrica» e l’operaio massa che la abitava.
Vi è ancora leninismo a questo punto? Certo, le caratteristiche classiche del leninismo come forma moderna, machiavelliana di un’organizzazione politica sono venute meno. Ma vi è un’altra dimensione leninista, profondamente marxiana, che qui resta ed anzi è esaltata: è l’esigenza, l’urgenza di impiantare il progetto organizzativo, la forma della lotta nella realtà produttiva e di riconoscerla nella sua qualità sociale. Il punto di vista leninista, se non lo vogliamo chiudere dentro lo sfilacciamento dell’esperienza sovietica o in un feticcio dogmatico, nel suo nucleo fondamentale è sempre stato quello di collegare strettamente produttività del lavoro e organizzazione politica. È solo il lavoro vivo al più alto livello di produttività che può determinare forza rivoluzionaria: questo è l’aspetto centrale del leninismo che in questa fase, dopo il ’73, viene ripreso dai movimenti dell’autonomia nel mezzo della disgregazione delle forze politiche. I movimenti intuiscono il farsi sociale della produttività, in maniera progressivamente egemone, come potenza del nuovo modo di produrre. Come combinare quest’intuizione e la definizione dell’«operaio sociale» con lo slogan sempre attuale del «rifiuto del lavoro»? Molti di noi ricordano il motto marxiano dei Grundrisse: «la capacità di gioire trova la sua condizione, il suo primo mezzo nella forza produttiva; il potenziale di gioire ne è il prodotto», e lo proiettavano nel farsi sociale del lavoro e nella più alta produttività che esso cosi esprimeva – riconoscendo in questo passaggio, in quello reale, un incremento della potenza produttiva, in una larga cooperazione lavorativa e fuori dalla miseria della fabbrica. Questo era ancora e sempre di più rifiuto del lavoro salariato. Fuori dalla miseria della fabbrica e fuori da ogni illusione che il comunismo possa essere raggiunto attraverso il «culto del popolo», il lavoro organizzato secondo la tradizione nelle aree rurali – e questa rivendicazione produttiva significava, nella contemporaneità, deministificare ed attaccare ogni illusione «nazional-popolare», qual era quella nutrita dal PCI. Il nesso produttività del lavoro/distruzione del lavoro salariato non conosce alternativa – esalta il lavoro solo nella misura in cui lo nega nella forma del salario, esalta la produttività quand’essa liberi l’uomo dalla miseria del comando.
Abbiamo detto che vi erano due linee che, nella seconda metà dei ’70, rispondono all’indebolimento delle lotte dell’operaio massa. La seconda studia la genesi del lavoro cognitivo come asse di ricomposizione operaia. Tuttavia, il farsi sociale del lavoro vivo – come abbiamo fin qui visto – precede di buon tratto il suo farsi cognitivo. Per un certo tempo i due processi non si sovrappongono. Questo spiega perché la seconda via percorsa in quel periodo (che è più classicamente leninista della prima) trovi difficoltà ad essere interpretata in maniera diretta nelle lotte. Essa cerca la ricomposizione del lavoro vivo nella fabbrica sociale del General Intellect. Questa resta una forte anticipazione che soltanto negli anni ’90 comincerà a trovare espressione politica. Ma già nella seconda metà degli anni ’70 essa è presente ai militanti. La lettura del «frammento sulle macchine» dei Grundrisse, che già da un decennio era stato tradotto nei Quaderni Rossi e che aveva fin qui sollecitato fortemente l’immaginazione dei comunisti, diviene ora materia di inchiesta. Attraverso l’inchiesta si percepisce, proprio mentre la produzione si stende sui territori, quanto essa richieda di essere integrata da nuovi saperi e da conseguenti trasformazioni tecnologiche. La fabbrica sociale non ripeteva la «fabbrica» territorializzata, la comunicazione diveniva fondamentale al processo produtivvo, la tecniche dello sfruttamento si trasformavano e la resistenza si calibrava su queste nuove dimensioni. Si intuiva, in questa ricerca, sia che in questo passaggio produzione di merci e riproduzione della vita sociale veniva a sovrapporsi, sia che il sapere sarebbe divenuto la forza-lavoro fondamentale – e, dunque, che l’operaio sociale rappresentava solo l’inizio di una nuova figura produttiva del lavoro vivo.
Due sono dunque le vie che nella seconda metà degli anni ’70 si susseguono, quella dell’autonomia diffusa e quella della ricomposizione di un progetto unitario attorno all’egemonia della classe del General Intellect – ed entrambe le strade hanno un’impronta leninista. Il leninismo non solo permane ma il suo impatto si moltiplica in quel frangente. Su entrambe queste strade camminiamo, misurando l’estrema difficoltà del momento nel quale si danno la dissoluzione del vecchio progetto pcista, delle sue condizioni sociali e il forte avanzamento della contro-rivoluzione neoliberale. Il leninismo infatti non è semplicemente l’idea di un rapporto tra una forza organizzativa e il suo radicamento in una potenza sociale tendenzialmente affermativa e vincente – il progetto organizzativo leninista si sviluppa con un riferimento forte a due temi, quello dell’estinzione dello Stato e quello dell’affermazione del Comune. Si può forse lottare come leninisti e rivoluzionari (si riconosceva nei ’70) nello Stato e progettare una cammino rivoluzionario che usasse le istituzioni statali in fasi particolari del processo di liberazione della classe operaia, ma questo processo di uso dello Stato è limitato (e si insisteva su questo) ad uno stadio democratico-borghese dello sviluppo rivoluzionario. Il fine dei comunisti, della loro rivoluzione permanente, è quello di estinguere lo Stato e di portare il Comune a legittimare il maniera esclusiva l’ordine sociale. È su questo terreno che si conferma lo sviluppo delle lotte dell’autonomia nella seconda metà degli anni ’70, in tutte le sue dimensioni, dalle più fragili legate al lavoro teorico sulla tematica del General Intellect, a quelle più dure legate all’organizzazione sociale diffusa di un’autonomia che cerca di consolidarsi nella resistenza alle nuove forme della produzione (neoliberali) – bene, in ognuna di queste forme di resistenza c’è sempre un leninismo implicito. Era evidente che con la repressione dei movimenti al termine degli anni ’70, ogni progetto di «uso dello Stato» diviene impercorribile.
Per concludere. Vi sono tre punti sui quali abbiamo insistito a proposito della recezione italiana di Lenin nelle lotte dei ’70. Il primo apprezzamento si dà quand’egli sviluppa un’analisi coerente dalla critica dell’economia politica del capitale alla progettazione dell’organizzazione politica del proletariato, scoprendo un rapporto inclusivo dell’organizzazione del Partito nell’analisi della fabbrica – Lenin fa dunque, conseguentemente, emergere il Partito dalla composizione tecnica del proletariato e gli dona la figura della fabbrica rovesciata. Il secondo punto, ripreso da Lenin, consistette nel porre nella medesima maniera il tema dell’interruzione dello sviluppo capitalistico attraverso l’affermazione dell’indipendenza della classe operaia. E’ una linea capace di invertire il rapporto consecutivo fra composizione tecnica del proletariato e composizione politica della classe operaia, dopo averne costruito la continuità. Il terzo punto sul quale abbiamo insistito è il carattere direttamente programmatico che il Partito assume in Lenin: esso è fatto per la rivoluzione comunista e per null’altro che questo. A questi tre punti ci è sembrato di poter dare un’interpretazione che ne verificasse la pertinenza rispetto ad una duplice trasformazione delle condizioni nelle quali il leninismo era riuscito vincitore: quella – consistente nella stabilizzazione dell’operaio massa – che si realizza compiutamente negli anni ’60 ; e quella intravista nella nascita dell’operaio sociale e nello svilupparsi del General Intellect che, negli anni ’70, si comincia a sperimentare nel fuoco del caotico sviluppo della lotta di classe sotto l’aggressiva ristrutturazione capitalista del modo di produzione.
Abbiamo già sottolineato lo stretto rapporto «composizione tecnica/composizione politica» nel pensiero di Lenin. Questo nesso è poi confermato quando lo si consideri nella trasformazione delle figure politiche dell’organizzazione operaia. Il Partito di Lenin sta nella «sussunzione formale» del lavoro sotto il capitale ed in questa condizione si definiscono organizzazioni di massa e avanguardia come funzioni diverse dell’azione rivoluzionaria – l’una ai soviet, l’altra il Partito. Negli anni ’60 ci troviamo invece nel pieno della «sussunzione reale»: l’avanguardia si è ora accovacciata nel cuore del lavoro vivo, fattosi massificazione operaia. Composizione tecnica e composizione politica, per cosi dire, si confondono, tendono a configurarsi politicamente e ad esprimersi in forme assembleari, si scontrano con la capacità capitalista di dissolverne le condizioni di esistenza (attraverso la globalizzazione… ma questo è un altro argomento). È nel pieno di questo attacco, nella seconda metà degli anni ’70, che il problema dell’organizzazione viene ripensato, identificando in primo luogo una linea di resistenza che sorge e si incarna sulle pause e/o sui ritardi dell’iniziativa capitalista; ed un secondo modello che, in maniera leninista, cerca di identificare un nuovo emergere e una nuova figura dell’avanguardia. La costruzione dell’impresa rivoluzionaria del General Intellect, dell’«intellettualità di massa» precarizzata e dell’intelligenza sociale alienata nell’astrazione finanziaria, questo è lo sbocco sul quale una nuova biopolitica dello sfruttamento e una nuova immaginazione dell’«impresa rivoluzionaria» si incroceranno, in quegli anni della più pesante repressione – speranza teorica di una ripresa del movimento su nuove basi.
Detto ciò, non possiamo certo dimenticare quanto, negli anni ’70, lo scontro attorno alla definizione della composizione di classe fu feroce – fra le forze dell’autonomia ed i compagni del PCI. Il presentarsi dell’operaio sociale sulla scena fu da questi ultimi intepretato come il sorgere di una «seconda società», inadatta a ricomporsi con la classe operaia, piuttosto destinata ad un ghetto, quindi da escludere socialmente e da combattere politicamente – e qualora essa divenisse troppo irrequieta, da schiacchiare attraverso mezzi repressivi. Anche in questa polemica risuonavano diverse intepretazioni di Lenin: la prima ancorata al primato del politico – che significava del Partito, nel momento nel quale, attraverso il compromesso storico, stava facendosi Stato; la seconda che riprendeva l’energico invito leninista a non lasciare fuori dal movimento rivoluzionario alcuno strato sociale – soprattutto se, come era il caso dell’operaio sociale, avesse vocazione a divenire la rappresentazione egemone del lavoro vivo. Ma ebbe anche un altro aspetto, questo scontro attorno al leninismo, fra le forze del nuovo proletariato ed il PCI. Fu quando le forze riformiste, organizzate nei Partiti comunisti, rinfacciarono ai movimenti la loro incapacità di costituirsi in forza politica. Le assemblee, l’assemblearismo, la sua capacità di espressione di linee radicali di lotta e di ricomposizione di massa e avanguardia, tutto ciò fu indegnamente spregiato. Osserviamo che l’incompiutezza di queste esperienze di organizzazione non può dare spazio alla critica da parte di chi, della concezione del Partito, ha fatto il mezzo per il rifiuto di ogni principio di partecipazione di massa, di elaborazione cooperativa del progetto politico – rinunciando a rappresentare la speranza comunista. Dentro questo rovello siamo ancora. Gli anni ’70 hanno aperto un problema, quello della riorganizazione del proletariato, riconoscendone le nuove radici, affidando all’«inchiesta continua» indicazioni di avanzamento nella costruzione del progetto rivoluzionario. Su quella linea sono state fatte esperienze singnificative (in particolare nelle lotte altermondialiste del 1999-2001 e nelle lotte degli indignados dal 2011 ad oggi) di nuove forme di organizzazione. Se vogliamo chiamare «problema Lenin» il problema di organizzazione aperto negli anni ’70 ed oggi nuovamente davanti a noi, possiamo senz’altro farlo, purché si comprenda che il richiamo a Lenin non significa nostalgia o feticismo organizzativo, ma riguarda una nuova soluzione per i problemi che egli si era posto e vittoriosamente risolto.
Questo testo è stato pubblicato sul n. 62 di Actuel Marx dedicato a Lenin