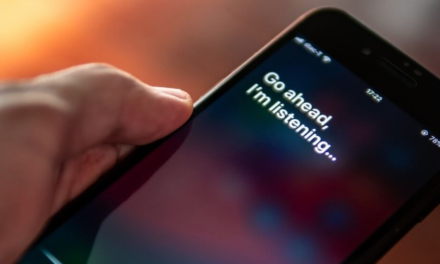di BENEDETTO VECCHI
Tutto ha inizio quando il clima un plumbeo seguito al crollo del Nasdaq del 2001 comincia a diradarsi. In Rete c’è una società, Google, che fa parlare molto di sé. Fornisce un motore di ricerca che aiuta navigare in Internet. Fa molti profitti, vendendo a milioni di piccoli inserzionisti spazi pubblicitari a pochi centesimi di dollaro. I suoi fondatori, Larry Page e Segej Brin, sostengono che mai e poi mai faranno come la Microsoft, ormai sorvegliata speciale da giudici e dal dipartimento della giustizia statunitense che l’accusano di pratiche monopoliste. Google fornisce i suoi servizi gratuitamente e nella sede a Mountain View campeggia il motto “Don’t be evil”, non essere il diavolo, chiara allusione proprio alle strategie della Microsoft. Usa programmi informatici open source e i suoi fondatori criticano apertamente le leggi sulla proprietà intellettuale, omettendo però il fatto che l’algoritmo alla base del suo motore di ricerca è coperto da un brevetto e che è stato sviluppato all’interno di un progetto di ricerca finanziato anche da soldi pubblici. Nel frattempo, un giovane e spregiudicato di nome Mark Zuckeberg ha lanciato un servizio per condividere con amici e conoscente impressioni, pensieri, immagini. Si chiama Facebook, ed è indicato come il secondo, rilevante segnale che il web è arrivato alla fase del 2.0. Finito il periodo dello scontro sui sistemi operativi standard e sui software applicativi, l’economia della Rete sarà caratterizzata dalla condivisione dei contenuti prodotti collettivamente o da singoli. A San Francisco, ha fatto il suo ingresso in società Blogger. È una start up che ha fatto molto parlare di se. Ha sviluppato un insieme di programmi informatici che consentono di scrivere, diffondere immagini e suoni e, al tempo stesso, di poter interagire in tempo reale con chi accede ai quei contenuti e li commenta.
Blogger ha conosciuto un momento di notorietà e ha portato nelle tasche del suo fondatore, Evan William, qualche decina di milioni di dollari ed è indicata come un altro segno che la crisi del 2001 può essere archiviata come un incidente di percorso e che le cose hanno cominciato di nuovo a girare nel verso giusto, visto che i venture capitalist sono disposti nuovamente a investire centinaia di milioni di dollari in progetti avveniristici, anche se non hanno un business model, condizione necessaria, anche se insufficiente per rendere redditizie le società che li sviluppano. L’obiettivo è di farle crescere, quelle società, al punto giusto per poi farle quotare in borsa e così rifarsi del capitale iniziale con i lauti profitti annessi. Evan Williams, questo è il nome del fondatore di Blogger, potrebbe ormai tranquillamente vivere di rendita, ma non vuole proprio ritirarsi a vita privata. E’ alla ricerca di una nuova idea “rivoluzionaria” che può cambiare il mondo della Rete. Ma annaspa, gira a vuoto. L’unica cosa chiara che ha in testa è che la condivisione dei contenuti è il nuovo eldorado del cyberspazio. Pensa che può trovare il modo di sviluppare un programma di podcast, perché le persone oltre che scrivere o fotografare o filmare o “postare” file musicali vogliono anche parlare tra di loro. Non si tratta solo di poter inviare o ricevere suoni dal web, bisognerebbe sviluppare software per fare una specie di radio attraverso internet, con tanto di interattività, di condivisione e, perché no?, di poterla fare senza una redazione centrale, ma ognuno con il suo computer, attraverso un coordinamento facilitato dalla connessione in rete.
Affitta una sede scalcagnata, in un quartiere degradato, popolato da homeless, disoccupati, prostitute e tossici. Il quartiere scelto non è però solo abitato da “marginali”, ma anche da bohémien digitali bravi però a scrivere codice informatico. Imbarca nella sua avventura sei ragazzi alla deriva, dall’infanzia non senza problemi, ovviamente squattrinati. Tutti vogliono, in una maniera o nell’altra, lasciare un segno nella storia dell’high-tech; inoltre sono convinti che la Rete è la concreta dimostrazione che il potere del sistema può essere combattuto fornendo ai singoli la possibilità tecnologica di far sentire la propria voce e di diffondere il loro punto di vista. Due di loro hanno partecipato ai movimenti no-global e della pace con posizioni radicali (gli Stati Uniti sono intervenuti prima in Afghanistan, per poi invadere l’Iraq nella disastrosa guerra infinita di George W. Bush contro il terrorismo), sviluppando anche un software per impedire l’intercettazione dei telefoni cellulari usati negli scontri con la polizia in alcune manifestazioni negli Stati Uniti o in Europa.
Per imbarcarsi in una avventura dagli esiti incerti, il gruppo deve garantire ai suoi componenti quel tanto che serve per mettere insieme il pranzo con la cena e avere un letto dove dormire. Inoltre, c’è chi deve estinguere il debito contratto con le università per pagare le rette e giungere alla sospirata laurea. Evans, Ev per gli amici, è colui che mantiene il rapporto con venture capitalist disponibili a investire 200-300 mila dollari. In fondo, con Blogger, ha dimostrato che è uno che ci sa fare. Anche se mai lo ammetterebbero, sono tutti influenzati dallo spirito new age, ma pragmatico di un imprenditore multimiliardario di nome Steve Jobs, che ha sollevato dalla polvere Apple, facendola diventare, con iTunes e iPod, una impresa che, assieme a poche altre, detta ormai le regole dentro la Rete.
Inizia così la narrazione su Twitter che il giornalista e blogger Nick Bilton ha condensato nel libro Inventare Twitter (Mondadori, pp. 324, euro 18). Costruito, come un thriller, ricostruisce lo scontro di personalità e di potere dentro la società che ha come logo un fringuello. Non può però occultare l’habitat sociale e culturale dove nasce Twitter. I rapporti con il mediattivismo è, occorre ripeterlo, una delle componenti fondamentali nelle vicende dell’impresa, anche quando viene quotata decine di miliardi di dollari. Altrettanto evidente è l’insofferenza verso “il sistema”, anche quando i conti in banca dei fondatori passano dal rosso fisso a cifre di cinque, sei, sette zeri: Twitter, inoltre, rifiuta ogni forma di collaborazione con i servizi di intelligence e della Fbi, a differenza di Google, Apple e Facebook, che invece hanno, chi più, chi meno, collaborato con la Nsa, la Fbi, il governo di Pechino nel reprimere il dissenso in Cina o nella attività di spionaggio condotti dai servizi di intelligence statunitense. Noto è anche il rifiuto di fornire alla Fbi i tweet scambiati dai militanti di Occupy Wall Street durante le manifestazioni di New York. E’ il classico esempio dello “spirito hacker del nuovo capitalismo” descritto da Pekka Himanem e Manuel Castells nell’omonimo e noto saggio pubblicato in Italia da Feltrinelli.
La breve storia di Twitter dimostra così ancora una volta che lo spirito hacker non è incompatibile con il capitalismo. Semmai favorisce la legittimità culturale allo sviluppo di forme imprenditoriali specifiche per un habitat indifferente e a volte ostile alla logica capitalista. Nel libro di Bilton le gerarchie aziendali di Twitter sono ridotte al minimo: ogni dipendente scrive il suo codice, definendo tempi e modalità del proprio lavoro. Ciò che conta è che sia un buon codice, facendo così emergere uno dei tratti distintivi dell’etica hacker: la meritocrazia, perché la reputazione si acquisisce dimostrando di essere bravo. E se in Google, vige la regola dell’Ottanta per cento del tempo di lavoro dedicato alle scadenze aziendali e il 20 per cento rimanente dedicato allo sviluppo di progetti individuali, dentro Twitter i controlli sono ridotti al minimo. Il clima lavorativo ricorda infatti quello di un campus universitario e non di una impresa. Inoltre, lo stile di vita è rigorosamente alternativo. Molti sono vegani, frequentano abitualmente i rave e i meeting, come il Burning Man, considerati, più a torto che a ragione, appuntamenti di artisti antisistema e anticapitalisti in erba. Alternativo non fa rima con anticapitalista. Semmai emerge il fatto che la differenziazione imposta dalla logica economica capitalista segue altre derive. Ad esempio, l’uso intensivo di knowledge workers a tempo determinato; oppure vige la differenziazione tra chi ha diritto di accesso alle stock option e chi invece viene tagliato fuori. E’ ormai acquisito che la gerarchia nel mondo high-tech passa proprio per questi due aspetti. Da una parte ci sono i perms, i permanenti che accedono alle stock option; dall’altra stagisti e temps (i temporanei) hanno spesso salari da working poor. Inoltre, nell’apologia del capitalismo digitale vengono cancellati tutti i lavoratori e le lavoratrici della logistica, e dei servizi alla produzione ridotti a una sottoclasse. Se mai ha avuto un potere esemplificativo della segmentazione del mercato del lavoro in una grande metropoli, l’analisi di Saskia Sassen sulla presenza di una minoranza ben pagata di professional e una maggioranza di lavoratori poveri vale proprio per Silicon Valley; o per Boston e San Francisco, come d’altronde testimoniano le recenti contestazioni di una parte della popolazione della metropoli californiana ai mezzi di trasporto delle imprese high-tech. Con toni allarmati, il sito del “San Jose Mercury News”, considerato il bollettino di Silicon Valley, ha riportato nei giorni scorsi i resoconti di alcune manifestazioni e picchettaggi che hanno coinvolto bus di Google e la sede proprio di Twitter. In ogni caso, la presa di parola degli “schiavi della rete” a San Francisco evidenzia il fatto che il capitalismo per espropriazione costituito dalle imprese high-tech sta imparando a conoscere il linguaggio ruvido del conflitto di classe.
Per anni a Twitter, tuttavia, la possibilità di accedere alle stock option è ancora un miraggio. Per i primi, lunghi cinque anni non è stata quotata in borsa ed è stata sempre alla ricerca di finanziamenti, perché seppur la crescita degli utenti cresceva velocemente, la voce ricavi è sempre rimasta a inchiodata sullo zero. Dunque, si accetta di prendere un salario basso, perché nel futuro, se si lavora sodo, i soldi arriveranno.
Poco, e di sfuggita, Bilton cita anche la costellazione di imprese che sviluppano applicazioni. Software house di quattro, cinque persone che producono programmi informatici finalizzati a potenziare il nucleo centrale del software, ma che rivestano un ruolo fondamentale nel garantire la crescita degli utenti del social network perché consentono di svolgere operazioni aggiuntive a quelle iniziali. Per Twitter significa inviare messaggi lunghi al massimo 140 caratteri, ma nel tempo è stato possibile arricchire il messaggio, attraverso applicazioni sviluppate al di fuori dell’impresa, con link ad altri social network, siti informativi; oppure aggiungendo immagini. Dunque un messaggio, nel tempo, sempre più carico di contenuti. E questo agli utenti è piaciuto, facendo crescere gli account a un ritmo vertiginoso che ancora non si è fermato, né rallentato.
E’ nello sviluppo delle applicazioni che le due vision dell’impresa presenti dentro Twitter sono entrate in rotta di collisione. Da una parte, Evan Williams ha sempre proposto che Twitter servisse per comunicare “cosa stava accadendo”. Uno degli altri fondatori, Jack Dorsey, riteneva invece che il servizio di messaggistica e di microblogging potesse, anzi dovesse essere usato per comunicare il proprio “status” (come mi sento, cosa sto facendo). Da una parte, un servizio per informare; dall’altro uno strumento per chiacchiere frivole e rivolte prevalentemente a dare libero sfogo al proprio ego. Mediatore tra le due concezioni è stato Noah Glass, altro fondatore di Twitter estromesso nel 2006 e cancellato nel tempo dalla storia ufficiale dell’impresa. In fondo, era una distinzione cara ai fondatori, non a chi twittava, poco interessati a specificare che quanto scrivevano era relativo a cosa stava accadendo o a come si sentissero in quel momento. Poco spazio è dedicato nel libro alla scelta di anteporre il cancelletto all’’hastag e il simbolo @ all’utente, una consuetudine già abbastanza diffusa in Rete nelle comunicazioni tra la caotica comunità professionale dei programmatori e degli “smanettoni” ma che ha fatto scrivere tonnellate di ipotesi agli opinion makers della Rete.
Nel libro di Bilton ampio spazio è invece dedicato all’uso di Twitter da parte dello star system e della politica istituzionale. Attori, musicisti, scrittori lo hanno usato per stabilire un canale privilegiato con i propri fan, per renderli ancora più fedeli, visto che sono loro lo strumento di marketing virale per vendere dischi (meglio scaricare i brani musicali dalla Rete), per far accorrere il pubblico ai concerti; per promuovere libri. Per la politica istituzionale, Twitter dal 2006 in poi è stato lo strumento comunicativo di iniziali outsider del sistema politico americano. Il caso più eclatante è l’uso che ne ha fatto Barack Obama nella prima vittoria presidenziale. Tutto cambia quando Twitter comincia invece ad essere usata da attivisti e militanti politici di base. Le mobilitazioni antifondamentaliste in Iran nel 2009, l’uso intensivo che ne viene fatti dai movimenti sociali o le rivolte delle cosiddette primavere arabe sono considerate dentro Twitter segnali di un mondo in fibrillazione. Che i sismografi del conflitto sociale e di classe registrino l’impennata di traffico su Twitter non sorprende, ma neppure inorgoglisce i fondatori. Per loro, Twitter è un servizio “indifferente” ai contenuti che veicola. Non preoccupa neppure la scelta di Wikileaks di usare il servizio di microblogging dopo che altre imprese hanno accettato la censura imposta dal Pentagono e dal dipartimento di Stato in seguito alla rivelazioni veicolato dal sito fondato da Julian Assange. Twitter ha infatti sempre sostenuto la neutralità della Rete, cioè che i contenuti veicolati, qualunque essi siano, sono di responsabilità di chi li mette su Internet e che nessuno deve ostacolarli e selezionarli. Per questo ha sempre rifiutato i diktat della Fbi, del Pentagono e del Dipartimento di Stato di fornire informazioni su chi metteva on line contenuti sgraditi. Inquietante, tuttavia, è l’ultima parte del libro, quando il giornalista segnala che il nuovo “vertice” di Twitter, emerso dopo una lunga e reiterata lotta per chi governa l’impresa oramai valutata 100 miliardi di dollari, manifesta una tendenza a favorire i potenti di turno, sia che si chiamino Barack Obama o Dimitrij Medvedev.
In ogni caso, e siamo arrivati ai nostri giorni, Twitter ha ormai più di 500 milioni di utenti. Ha resistito alle offerte di acquisizione di Facebook e Microsoft; ha ormai rapporti commerciali con Google e Microsoft e ha trovato il suo modello di business (vende spazi pubblicitari più o meno come Google; un’altra voce di bilancio spetta alle percentuali sull’aumento di traffico di alcuni siti dovuto ai link inseriti nei tweet degli utenti). I suoi fondatori sono ormai miliardari, eccetto Noah Glass, estromesso dall’impresa senza neppure un benservito. E’ diventata cioè un’impresa leader della Rete. Ha poco più di 450 dipendenti, mentre la costellazione di imprese che sviluppano applicazioni è in costante crescita. Per molti, è destinata a prendere il posto di Facebook nelle preferenze dei teen agers, che sembrano però preferire sempre più servizi come WhatsApp, WeChat e altri imprese per comunicare tra loro.
E’ dunque evidente che il suo core business sta nel veicolare contenuti prodotti dalla comunicazione sociale. Poco importa se sono contenuti di qualità, oppure se sono cinguettii frivoli. E’ con la nuvola informativa che si fanno affari, perché lì si condensano i dati che verranno elaborati per poi essere venduti ad altre imprese. Questo non significa che su Internet le cose tangibili abbiamo perso la loro importante. Cisco, Intel, Dell, Lenovo, Nokia, Apple e tante altre imprese continueranno a produrre microprocessori, computer, smartphone, tablet e computer portatili. E continueranno a ridurre i costi di produzione e a spostarsi da paese a paese per tenere bassi i salari operai, dando vita a una dinamica che ridisegna a ritmi veloci la divisione internazionale del lavoro, ma su Internet gli alti profitti provengono ormai dalle imprese di Big Data, un iceberg che ha in Google, Apple, Facebook, Amazon solo la parte emersa.
In un recente scritto di Tiziana Terranova dedicato a un incontro tenuto nel gennaio 2014 al Centre for Cultural Studies di Londra sul rapporto tra Algoritmi e capitale (www.euronomade.info, alla sezione Reti) , la teorica italiana svolge una analisi sugli algoritmi interpretati come capitale fisso, cioè come prodotto del lavoro vivo, che può creativamente essere estesa anche ai social network. Se per Terranova è ormai acquisito che gli algoritmi come PageRank di Google o EdgeRank di Facebook sono componenti fondamentali per comprendere il funzionamento della Rete, lo stesso si può dire anche per gli algoritmi e il software che fanno funzionare i Big Data. Altrettanto importante è la sottolineatura della studiosa italiana delle dinamiche di potere che tali algoritmi determina nei rapporti tra le imprese e, c’è da aggiungere, tra la cooperazione sociale e le imprese. Senza dilungarsi più di tanto sul ruolo svolto dalla proprietà intellettuale come forma di governance della Rete e dei rapporti tra capitale e lavoro vivo, per quanto riguarda imprese come Twitter ci troviamo di fronte a una situazione dove il capitale fisso costituito dal software è funzionale alla circolazione di contenuti, che saranno in seguito assemblati e elaborati da altri algoritmi. Ciò che è rilevante è dunque la cooperazione sociale che deve continuamente alimentare la nuvola di dati. Cercare di renderla “fedele” al social network comporta quindi precise tecnologie del controllo. Uno degli elementi meno indagati è che la rete impone standard e regole ben precise nello stile di enunciazione. Non è certo una novità, questa. I linguisti e i filosofi del linguaggio hanno già ampiamente spiegato perché le regole enunciative sono importanti, così come una certa standardizzazione nella costruzione di una frase è fondamentale nel poter comunicare.
In Rete, tuttavia, standardizzazione e regole conseguono due obiettivi complementari: da una parte servono a rendere i siti internet user friendly, cioè facili da usare; dall’altro lato, consentono alle imprese di poter intervenire facilmente nella elaborazione dei dati che vengono prodotti nella comunicazione on line. Per Jason Lanier, teorico delle realtà virtuali, c’è un inquietante effetto collaterale di tale standardizzazione: la riduzione, meglio un impoverimento della comunicazione, che può così essere facilmente controllata, addomesticata. Twitter, con i suoi messaggi da 140 caratteri, è l’esempio più calzante di un’impresa che sì garantisce libertà di espressione, ma a patto che non sia niente di più che di un cinguettio. Analisi impietosa, che non troverebbe conferma sull’uso politico del servizio di microblogging: in questo caso, infatti, Twitter ha avuto un indubbio potere performativo nella ricezione di un “evento” politico, da cercare però non nella parola scritta, ma nelle immagini veicolate in Rete. Non è questa la sede per discutere del rapporto tra visuale e parola scritta e della perdita di importanza di quest’ultima. Quel che è qui rilevante è il fatto che la libertà di espressione garantita da Twitter non presenta una autonomia dalle gerarchie definite dai media mainstream: i messaggi e i commenti inviati sono spesso annotazioni a informazioni “confezionate” dai media dominanti o dall’industria dell’entertainment. Più che una comunicazione alternativa a quella dominante, Twitter ne favorisce dunque il commento, l’irrisione talvolta, ma non c’è una sovversione delle gerarchie di importanza che un fatto ha. Il potere performativo di Twitter sta dunque nella possibilità di modificare il flusso dei dati e delle informazioni, facendo emergere fatti e “eventi” già contemplati dai media, ma relegati in una posizione secondaria rispetto alle prime tre, quattro notizie che i siti dei siti mainstream presentano nella loro home page. Altro fattore essenziale per comprendere che con Twitter siamo di fronte a una forma “innovativa “ di espropriazione della comunicazione sociale è la “fedeltà” degli utenti. Anche in questo caso, il flusso di dati originato dal servizio di microblogging può deragliare dalla rotta fissata, ma poi gli utenti devono tornare ad alimentare i contenuti che andranno ad accumularsi nei suoi archivi. Una ricerca di “fedeltà” che non è solo prerogativa di Twitter, ma di tutte le imprese della Rete. Perché i Big Data sono diventati l’eldorado da saccheggiare. E’ per questo motivo che le strategie imprenditoriali per vincolare gli utenti ai social network sono così importanti. In un passaggio del libro di Bilton, il giornalista e blogger statunitense riporta i timori di alcuni dirigenti di Google sul fatto che il suo motore di ricerca è sempre più usato per cercare hashtag e account di Twitter. Per Google, questo significa che l’accesso alla rete di centinaia di milioni se non miliardi di persone passa sì attraverso il suo motore di ricerca, ma questo non coincide con la permanenza degli utenti nella nuvola informativa originata dal motore di ricerca. Sono uomini e donne che entrano in Rete, ma poi migrano su altri social network. Google, ma lo stesso si può dire per Apple, ha cercato di strutturare l’offerta di servizi in maniera tale che l’utente non esca mai dalla “nuvola” generata dal motore di ricerca o dal’account Apple. Lo stesso timore lo ha Mark Zuckeberg, che infatti ha fatto offerte miliardarie per acquistare Twitter, respinte però sempre al mittente. Per il momento, Facebook ha acquisito WhatsApp, ma è consapevole che il flusso di informazioni, di comunicazione può eccedere le tecnologie, gli algoritmi sviluppati per controllarli. Da qui, il potere dei social network, ma anche la loro fragilità. Un esodo repentino da un social network ne mette infatti in discussione l’esistenza.
I padroni della Rete sono certo potenti. Espropriano la cooperazione sociale dei contenuti che produce. Ignorano la privacy individuale. Stringono patti luciferini con le agenzie di intelligence per poter meglio esercitare il controllo sulla Rete, ma sanno – e la storia di Twitter lo dimostra in maniera più che esauriente – che la sottrazione al controllo da parte di chi vive in Rete è altrettanto efficace. Nel racconto di Bilton, i mediattivisti anarchici scompaiono dalle pagine quando i venture capitalist e il managment di Twitter si pongono l’obiettivo di far crescere i ricavi. Se ne vanno. Perché l’etica hacker può essere compatibile con il capitalismo, ma non è detto che la sua declinazione ribelle non segua altre vie. Come quella di mettere in relazione ciò che avviene nelle strade e nelle piazza e quello che accade dentro lo schermo. E quando questi due momenti della vita in società entrano in relazione, le nuvole dei dati si ingrossano, ma viene ridotto il potere di controllo su di esse. Oppure preannunciano solo una tempesta che colpisce proprio quei padroni della Rete che ne vogliono fare solo un modello di business. Il conflitto più evidente e radicale dentro Internet ha infatti come oggetto principale la contestazione delle forme di controllo che viene esercitato dentro e fuori la Rete. In fondo, nelle strade e nelle piazza di un mondo sempre più interconnesso si vedono uomini e donne che indossano la maschera di Guy Fawkes, il protagonista di un film assunto dai mediattivisti come simbolo della lotta contro la società del capitale.