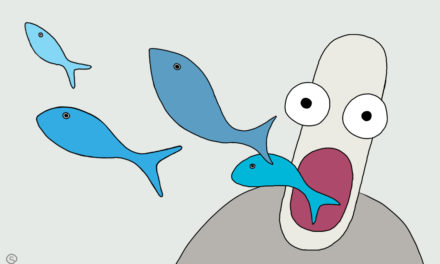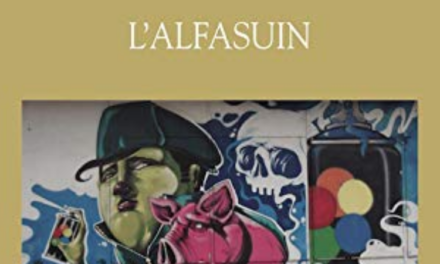Di BRUNO MONTESANO
La riforma dei Decreti Sicurezza (il decreto Lamorgese, DL 130/2020) è stata approvata e segna alcuni timidi passi in avanti. Tuttavia, per far fronte al razzismo odierno – che si manifesta tanto nel discorso pubblico, quanto nella pratica istituzionale e amministrativa – servirebbe molto di più. Forse sarebbe stato troppo ambizioso (ma soprattutto ingenuo) aspettarsi che questa dinamica cambiasse con lo stesso premier che ha condotto il governo più a destra della storia del paese. Così come poco c’era da aspettarsi da un centro-sinistra che da venticinque anni fa politiche sostanzialmente uguali a quelle della destra, di cui condivide lo spirito securitario ma ne attenua la retorica.
A scontare i danni del regime confinario europeo sono i migranti della periferia dello spazio europeo, così come chi viene da altre zone geografiche dove la vita è più precaria e insicura. Il sogno della cittadinanza europea che avrebbe dovuto disarticolare cittadinanza e nazionalità non si è realizzato e sempre più si va determinando un apartheid europeo, come lo hanno chiamato Etienne Balibar e Sandro Mezzadra. La discriminazione sociale e normativa, la retorica dello scontro di civiltà, non servono a impedire l’ingresso dei migranti ma servono piuttosto a inserirli in una posizione subalterna all’interno delle gerarchie delle economie e delle società europee. D’altronde, la cittadinanza istituisce una discriminazione legale, che può esser radicalizzata – dietro alla apparente naturalità della differenza nazionale – per via normativa e amministrativa. Non tutti i cittadini hanno gli stessi diritti, e, in assenza di un reale riconoscimento dei diritti umani, appena si varca il confine di un altro paese la loro formale inviolabilità si fa retorica.
E se parte della violenza discriminatoria delle leggi sull’immigrazione in Italia è condivisa con altri stati-nazione, è pur vero che la normativa italiana è andata, con particolare coerenza, costantemente restringendo diritti e libertà per i non cittadini nel corso degli ultimi trent’anni. È rimasto invece invariato l’assorbimento delle politiche migratorie nelle politiche del lavoro e della sicurezza, nonché la loro funzione discriminatoria. Si vuole, da un lato, produrre forza lavoro precaria e vulnerabile, espellibile all’occorrenza e regolarizzabile nelle emergenze – come con la parziale, e fallimentare, sanatoria di maggio. Dall’altro, si intende riprodurre e performare un’identità nazionale altrimenti fragile e esposta alla sua contingenza, così come c’è bisogno di disciplinare e dividere la società, strumentalizzando il rancore sociale. Per rassicurare le popolazioni impoverite si lascia il residuo di welfare ai soli nazionali, rassicurati sulla superiorità della propria cultura rispetto ai nuovi arrivati o alle popolazioni precedentemente colonizzate. C’è infine l’esigenza di rassicurare la popolazione nazionale sulla persistenza del potere sovrano a fronte dei fenomeni di erosione e trasformazione dello stesso. Si crea così un circuito di reciproca legittimazione tra illegalizzazione, discriminazioni a mezzo di legge e pregiudizi e violenze nella società. Poco importa che i migranti siano regolari o irregolarizzati, dato che nel dibattito pubblico sono sempre più identificati come parte della stessa emergenza. Non conta che le persone passino spesso da uno status all’altro, la clandestinità è una condizione considerata ontologica, un sinonimo di propensione alla delinquenza. Tutti sono discriminati perché senza diritti e tutti sono senza diritti perché non meritevoli degli stessi – si pensi alle parole di Arcuri su vaccini da negare ai “clandestini” e all’effetto che avranno sulla più vasta popolazione di non-cittadini in possesso di permessi.
L’umanità di chi muore ai confini d’Europa – a Ventimiglia, così come nel Mediterraneo o nei Balcani – è negata dai decisori politici che senza troppe difficoltà, e con diversi livelli di violenza, pagano milizie e forze di sicurezza per trattenere parte della popolazione “in eccesso” a distanza di sicurezza. Quando arrivano in Italia – su navi spesso tenute fuori dai porti anche sotto il governo Conte II -, con il pretesto della pandemia, possono essere rinchiusi in navi-lazzaretto e messi poi nei CPR senza poter fare domanda d’asilo, pronti per l’espulsione, come raccontato su questo giornale. I confini sono porosi e le persone arrivano ma l’accesso deve essere pericoloso e il rischio di venir deportati, così come l’esperienza della detenzione, devono segnare l’orizzonte di senso di chi accede allo spazio europeo. Nel dibattito sull’immigrazione, la dignità umana di chi vive la violenza dei confini, esterni ed interni, polizieschi ed amministrativi, è una posta in palio, non un dato di partenza.
L’ultima riforma dei Decreti sicurezza, pur se con qualche luce, rientra all’interno della lunga tradizione di leggi securitarie e repressive che hanno disciplinato le migrazioni. La “sicurezza” rimane il contraltare con cui bilanciare le timide aperture su alcuni fronti. Infatti, Luigi Manconi e Federica Resta hanno qualificato la normativa italiana sull’immigrazione come un diritto asimmetrico e deformalizzato e, in relazione ai Decreti Minniti-Orlando – che l’attuale riforma non mette in discussione -, di un diritto etnico, “minore”. Con la riforma non scompaiono le sanzioni alle Ong – che diventano penali e non più amministrative – e aumenta la criminalizzazione di chi si ribella nei CPR, il cui tempo di permanenza si restringe di nuovo a 90 giorni. Il Daspo urbano per selezionare e disciplinare la popolazione viene rafforzato. Rimangono le procedure accelerate di valutazione delle domande d’asilo, secondo l’approccio hotspot proposto dal Patto sull’immigrazione e l’asilo che dovrebbe riformare il Regolamento di Dublino. Così come rimane la norma sulla revocabilità della cittadinanza. Si accorciano “in compenso” i tempi per il rilascio della cittadinanza che però sono comunque più lunghi di quanto lo fossero prima della riforma di Salvini. L’aspetto più importante forse consiste nell’introduzione della protezione speciale e nell’ampliamento dei casi di inespellibilità, che riguarderà chi abbia una vita consolidata nel paese così come chi rischi trattamenti inumani. Inoltre, sarà possibile convertire la protezione speciale, insieme ad altri permessi temporanei, in un permesso per lavoro, ed è stato tolto il tetto massimo alle quote del decreto flussi sugli ingressi per motivi di lavoro. Viene ripristinata l’accoglienza per i richiedenti asilo, nonché l’iscrizione anagrafica – che recepisce da un lato una sentenza della Corte Costituzionale ma dall’altro la subordina al volere degli operatori dell’accoglienza, come rilevato da Enrico Gargiulo.
In definitiva, questa riforma, pur introducendo alcune norme positive, non interviene sull’inferiore considerazione della vita di chi non è cittadino. Restano la detenzione arbitraria nei CPR e negli hotspot, l’assenza di canali umanitari e di visti d’ingresso per la ricerca di lavoro, il proseguimento della stigmatizzazione delle Ong e gli accordi con la Libia, l’inferiore tutela delle procedure di domanda d’asilo rispetto a qualsiasi altro processo, così come l’enorme discrezionalità lasciata a sindaci e questure nel determinare le sorti di chi vive o transita in questo paese. Il vincolo tra lavoro, reddito e status giuridico rimane intatto. L’esclusione legale o de facto dai diritti fondamentali di chi non ha la cittadinanza non diviene – come servirebbe per configurare la “rivoluzione” di cui le forze della maggioranza parlano – l’ingiustizia da interrompere. D’altronde le parole della ministra che hanno accompagnato la riforma non lasciano dubbi: il pur necessario accoglimento delle minimali indicazioni del Presidente della Repubblica e delle sentenze della Corte Costituzionale va bilanciato da una maggior severità nella repressione di chi si rivolta nei CPR. Tra politica dell’eguaglianza e polizia, si propende per la seconda.
Questo articolo è stato pubblicato, in forma più breve, su il manifesto il 23 dicembre 2020.