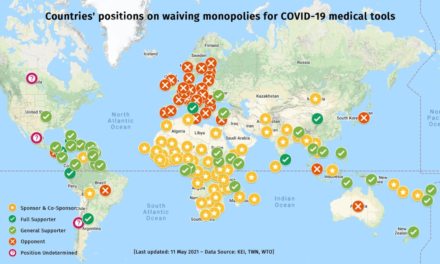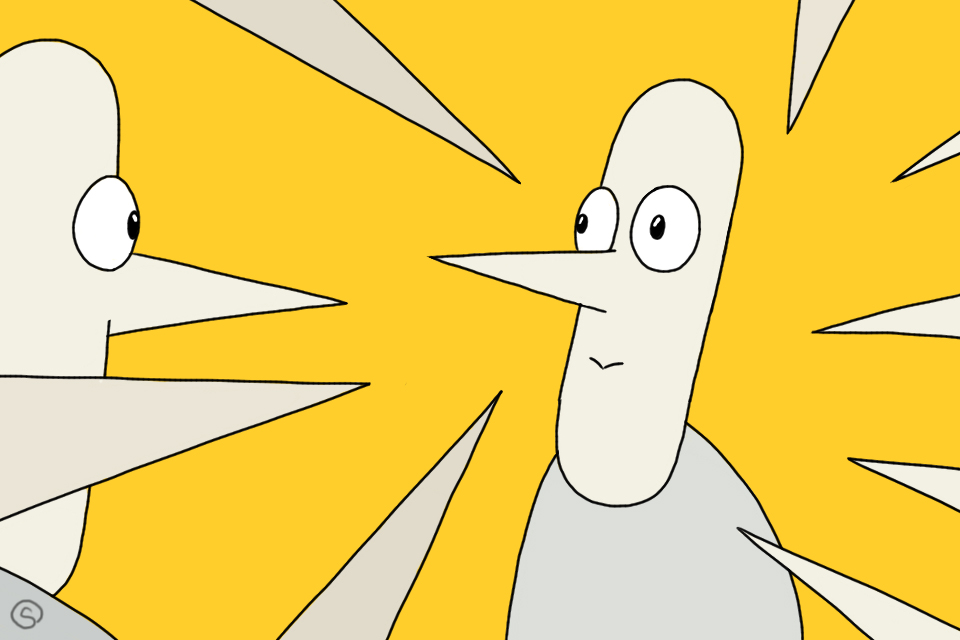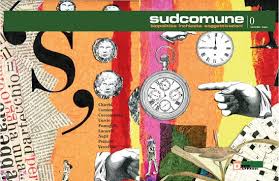SILVIA FEDERICI intervistata da MARINA MONTANELLI e TANIA RISPOLI
Silvia Federici è protagonista indiscussa e tra le più autorevoli della critica dell’economia politica da una prospettiva femminista. A questi temi ha dedicato una vita, spesa con contributi scientifici e come attivista, teorica e docente, oltre che – dagli anni Settanta – aver ricoperto un ruolo centrale nel movimento internazionale per il Salario al Lavoro Domestico. L’abbiamo incontrata per porle alcune domande e ripercorrere in tal modo alcuni tra i temi decisivi che legano la sua presenza alla Conferenza sul comunismo. Domani, nel contributo video si potranno ascoltare parte delle risposte che seguono.
Ritiene che sia avvenuto un cambiamento radicale di paradigma fra economia politica classica e neoliberismo, quindi fra gli approcci tradizionali al conflitto di classe e quelli attuali?
Dal mio punto di vista non c’è stata un’effettiva modificazione qualitativa nell’approccio dell’economia politica: il neoliberismo ripete alcuni schemi fondamentali che abbiamo visto in atto già nel corso del Novecento, prima fra tutte l’idea che il lavoro non sia il motore principale dell’accumulazione capitalistica. Il cambiamento va individuato, piuttosto, all’interno della critica dell’economia politica, a partire dagli strumenti che hanno fornito i movimenti sociali negli ultimi decenni del XX secolo: il movimento anticoloniale e quello femminista, i quali hanno ampliato la critica marxiana dell’economia politica, portando alla luce la centralità del lavoro non salariato nell’accumulazione capitalista. Questi movimenti, anticoloniale e femminista, ma anche quello operaio e studentesco, durante gli anni Sessanta e Settanta, hanno infatti sovvertito le strutture fondamentali dell’organizzazione capitalistica del lavoro, quelle gerarchie produttive che si fondavano su una serie di divisioni operate all’interno del proletariato, giustificate ideologicamente con il razzismo e il sessismo. Questa è stata la più grande novità nella ridefinizione dell’accumulazione capitalistica e dei suoi attori, esito dell’emersione di queste nuove soggettività. Se teniamo a mente queste premesse si può comprendere perché la crisi è divenuta permanente. Guardando all’accumulazione capitalistica dal punto di vista della rivolta dei non salariati, possiamo comprendere che cosa sia accaduto nell’organizzazione mondiale della divisione del lavoro: il capitale ha fatto della crisi permanente – non più concepita quindi come declino nel ciclo economico e produttivo – lo strumento primario per «recuperare» queste trasformazioni. Recupero che si attua con le vecchie «medicine» applicate a livello globale: la separazione dei produttori dai mezzi di produzione attuata con lo spossessamento di massa, le migrazioni forzate, la privatizzazione delle terre, ma anche dei servizi e del Welfare State. La globalizzazione non va intesa tanto o solo come svolta economica, ma come una vera e propria macchina politica che, permanentemente, spossessa e disloca persone. Essa è un processo continuo di ricolonizzazione, che avviene con la massima violenza.
La finanziarizzazione dell’economia ha inoltre prodotto la trasformazione delle principali relazioni monetarie, come quella del debito. Debito che ormai investe non solo la sfera pubblica ma anche quella privata, interrogando alla radice la trasformazione della relazione salariale. In che modo l’esercizio del credito da parte delle banche si collega allo sfruttamento derivante dal rapporto salariale?
Rispetto al contesto sopra indicato, fondamentale è il ruolo svolto dall’uso capitalistico del debito: pensiamo agli anni Ottanta, quando l’uso del debito nazionale e della sua crisi è servito come strumento di ricolonizzazione e attacco alle conquiste dei movimenti di liberazione. Con l’aumento del tasso di interesse sul dollaro, si sono mandati in bancarotta interi Stati. A questo uso del debito si è poi aggiunta un’altra tipologia, quella del debito individuale, che va di pari passo con la riduzione dei salari, lo smantellamento del Welfare State, la precarizzazione, il crollo dei redditi. Vi è chiaramente un’interazione tra debito e salario: le persone accettano salari bassi per essere in grado di pagare il debito – si tratta di una vera e propria coazione al lavoro, che è la forma specifica dello sfruttamento imposto con il debito. È il caso degli studenti negli Stati Uniti costretti a prendere prestiti che non saranno mai in grado di ripagare. Il problema poi politicamente è che lotte contro il debito, dal punto di vista dell’organizzazione, sono molto più difficili da costruire rispetto quelle collettive sul salario, perché il debito individualizza, isola, colpevolizza.
La critica femminista – pensiamo al lavoro da lei svolto con le compagne di Lotta femminista – ha posto la «riproduzione sociale» come base per un ripensamento complessivo del lavoro, mostrando l’esistenza di attività essenziali per il funzionamento del capitalismo, benché non retribuite e non riconosciute socialmente. In che termini la riproduzione sociale può oggi presentarsi come un elemento fondamentale della critica dell’economia politica?
Da anni sono interessata alla questione della riproduzione, da quando i movimenti femministi lottavano per il salario e, dunque, per il riconoscimento del lavoro domestico e riproduttivo. Con Mariarosa Dalla Costa e le altre compagne italiane del Comitato Triveneto per il salario al lavoro domestico abbiamo rimesso al centro la riproduzione, anche da un punto di vista teorico: se Marx l’aveva collocata ai margini della produzione capitalistica, noi abbiamo sostenuto al contrario che essa, in quanto produzione di forza lavoro – ossia della capacità delle persone di lavorare – è un pilastro centrale della società capitalistica. Per me questa tradizione è stata fondamentale tanto per comprendere il processo capitalistico quanto per individuare i punti decisivi attorno a cui sviluppare le lotte: non ci può essere una lotta davvero vincente, se, contemporaneamente, non riorganizza la vita di tutti i giorni. Questo è stato uno dei più grandi contributi del movimento femminista: non separare la lotta contro il capitale dal problema della riproduzione della nostra vita.
In tempi più recenti si è occupata della cooperazione nel lavoro di riproduzione: quali sono le possibilità che con essa si aprono e quali i suoi limiti?
Negli ultimi venticinque anni, in risposta alle varie forme di esproprio a cui tante comunità sono state sottoposte (a causa dell’estrattivismo, della deterritorializzazione delle industrie, delle privatizzazioni), sono nate varie forme di sperimentazione sociale centrate sulla costruzione di forme collettive della riproduzione – penso per esempio ad alcune esperienze in America Latina legate a situazioni di completo spossessamento, alle lotte contro l’agribusiness e per la riappropriazione dei mezzi di produzione. Queste pratiche sono sorte direttamente dalla necessità di sopravvivere, ma, allo stesso tempo, hanno creato delle nuove forme di cooperazione e di collaborazione. Basti pensare alle comunità zapatiste e alle forme di riproduzione autogestita che si sono create in tante città dell’America Latina. Ritengo che questi nuovi tipi di riproduzione sociale cooperativa siano essenziali nel rimodellamento della vita quotidiana: non sostituiscono le forme di lotta tradizionali nei luoghi di lavoro, ma certamente sono un passo fondamentale verso la costruzione di comunità di resistenza. Cucine popolari, orti urbani, ambulatori autogestiti sono luoghi costruiti e organizzati dalle persone attraverso decisioni collettive. Credo che la trasformazione della riproduzione sia l’unico modo possibile per rompere l’isolamento del lavoro domestico, da un lato, e per riappropriarsi del controllo territoriale, creando forme di autogoverno dall’altro. Naturalmente ciò implica una lotta per la riappropriazione della ricchezza sociale, affinché l’autogestione non sia autogestione della nostra miseria. Molti limiti della cooperazione nella riproduzione si possono superare quando si comprende che simili attività non sono solo dirette a sopravvivere, ma ricostruiscono un tessuto sociale che è indispensabile per confrontarsi con lo Stato da una posizione di forza. È ovvio che oggi non possiamo andare completamente al di là della lotta salariale. Ma allo stesso tempo non possiamo neanche dipendere completamente da essa. Le questioni che per me rimangono centrali sono: come, a livello internazionale e globale, possiamo sviluppare un rapporto politico tra lotta sul salario e lotta sui commons? Come queste lotte si possono potenziare a vicenda? Come si può non solo pensare ma anche praticare una lotta comune, e costruire organizzazioni capaci di contrastare la violenza del capitale?
L’articolo è stato pubblicato il 18 gennaio su Il Manifesto