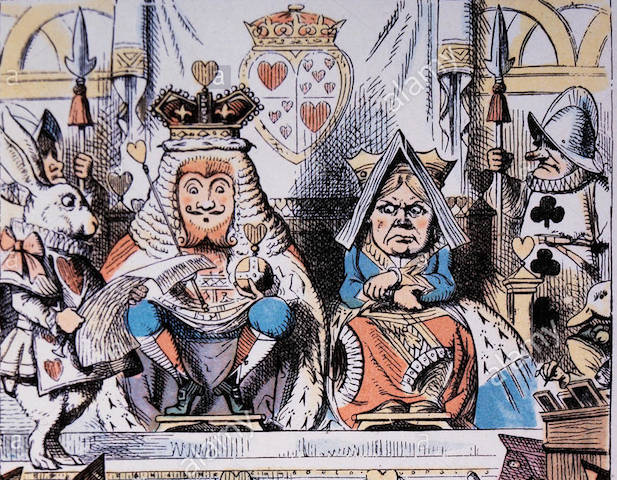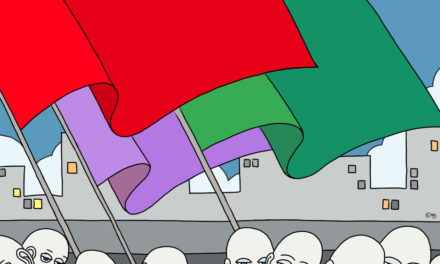di FANT TiBiCino.
la prima parte ⇒ qui
IV – Moltitudini a Licola
Sempre l’altro giorno (cioè il 23, e solo per farvi vedere quanto sono sul pezzo) l’uomo di ferro del fu partito comunista più grande dell’Occidente ha aperto la diciottesima legislatura confermando quello che sto cercando di dire: «Ha contato molto nelle scelte degli elettori il fatto che i cittadini abbiano sentito i partiti tradizionali lontani e chiusi rispetto alle sofferte vicende personali di tanti e a diffusi sentimenti di insicurezza e di allarme», dove “sicurezza” sta per tepore del caminetto, fumarsi una Muratti lontano dai negri e dai pensieri, e “allarme” e sempre e solo quello – siam fascisti.
L’individuo proprietario (de che? ormai più nessuno se lo chiede) nella propria pochezza è il cardine della democrazia, inseguito nelle paure più oscure e meschine: e la legge insegue. C’è paura degli incidenti stradali? ci inventiamo la fattispecie dell’omicidio “stradale”; le strade sono sporche? partono i DASPO contro chi mangia le patitine per la via. È tutta un’emergenza, una lotta: alla droga che uccide i bambini, al gender che ci fa tutti checche svirilizzate e plutosorosiane, ai centri di aggregazione perché ivi si annida il germe della socializzazione. Il sudore è bandito, il pensiero che non sia ratifica della vita di merda che si conduce è escluso dalle capacità umane.
Un procuratore genovese si è lamentato della carriera fatta da coloro che si sono macchiati di atti “discutibili” nel corso del G8 genovese. Il mondo pacificato è insorto: perché ciò che conta è la pace sociale – che poi detta pace sia costrizione e catene poco importa, che pace sia diventato sinonimo di coma, dove ogni eccitazione, anche quella più equilibrata e pudica è combattuta, ancora meno.
Si potrebbe affermare che:
Se oggi nella stampa è diventato un episodio ordinario di cronaca nera, che lascia indifferenti i lettori, il fatto di detenuti che soccombono alle sevizie inflitte loro nel carcere, si deve ringraziare ancora quel celebre art. 16 del Codice, di procedura penale del 1930, che garantendo praticamente l’impunità agli agenti di pubblica sicurezza “per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica”, costituiva una specie di tacita istigazione alla tortura.
Non si deve dimenticare che nell’inasprire il sistema penale e penitenziario, il ministro era ben d’accordo col suo padrone. Quando, al congresso di una società che continuava a intitolarsi al “progresso delle scienze”, si trovò un professore ordinario di diritto penale che dedicò un panegirico alla “funzione della pena nel pensiero di Benito Mussolini”, il festeggiato, che aveva concesso a quei bravi scienziati la degnazione della sua presenza, volle benignarsi di aggiungere egli stesso qualche parola a illustrazione di sé medesimo; e pronunciò anche in quella occasione alcune di quelle frasi lapidarie colle quali soleva inchiodare la storia. In polemica contro coloro che “si erano agganciati all’antropologia criminale”, egli in quattro battute sventò i pregiudizi di chi si ostinava a fare apparire Beccaria come contrario alla pena di morte. “Io avevo avuto sempre l’impressione che molti di coloro i quali si riferivano a Cesare Beccaria, in realtà, come spesso succede, non avevano letto il suo libro Dei delitti e delle pene. Io mi volli documentare, e chiesi alla biblioteca Sonzogno quel volumetto di proporzioni minuscole, che ognuno di voi probabilmente può facilmente acquistare. E allora, – controllate, vi prego, se io dico il vero – venni a questa semplice constatazione: che Cesare Beccaria non era affatto, contrario alla pena di morte….“. E poi, anche a proposito delle carceri, egli portò, come soleva, il verbo definitivo: mise in guardia coloro che studiano le carceri, dal “vedere questa umanità sotto un aspetto forse eccessivamente simpatico…. Credo che sia prematuro abolire la parola pena e credo che non sia nelle intenzioni di alcuno convertire le carceri in collegi ricreativi piacevoli, dove non sarebbe poi tanto ingrato il soggiorno” [Calamandrei, Bisogna aver visto, ne “Il Ponte”, 1949, qui].
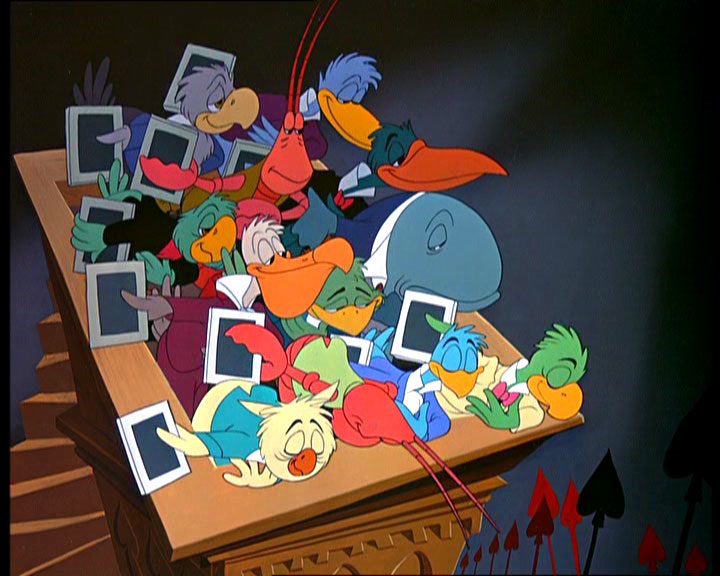 Ecco dove alligna il pericolo odierno, che toghe protocollanti (magari impediti nell’esercizio delle proprie funzioni da carenze d’organico, pressioni “politiche”, inerzia del legislatore) assecondino assessori al decoro, manganellatori, sparatori esasperati, cittadini votanti nel desiderio di rendere unico assetto legittimo (legale?) quello della paralisi dei sensi, dell’ostacolo a ogni espressione psichedelica, dell’alternativa soccombenza/espulsione. La tortura, il carcere ridicolizzato a “soggiorno” da non rendere “piacevole”, accuse di guardare il reo “con simpatia” solo a non volerlo costantemente bastonato.
Ecco dove alligna il pericolo odierno, che toghe protocollanti (magari impediti nell’esercizio delle proprie funzioni da carenze d’organico, pressioni “politiche”, inerzia del legislatore) assecondino assessori al decoro, manganellatori, sparatori esasperati, cittadini votanti nel desiderio di rendere unico assetto legittimo (legale?) quello della paralisi dei sensi, dell’ostacolo a ogni espressione psichedelica, dell’alternativa soccombenza/espulsione. La tortura, il carcere ridicolizzato a “soggiorno” da non rendere “piacevole”, accuse di guardare il reo “con simpatia” solo a non volerlo costantemente bastonato.
Ma andiamo avanti. Un utile strumento di lettura del problema sotto una diversa angolazione ci è offerto da Ludovico Mortara (invero uno dei più grandi giuristi, lui davvero, che abbiano calpestato i Tribunali del Regno); di seguito riporto il discorso per l’inaugurazione dell’anno 1911 (quello della guerra Italo-Turca, dell’invenzione del bombardamento aereo, della grande proletaria che si muoveva, di Enrico Millo, per intenderci) presso la Corte di Cassazione di Palermo. Ebbene, il figlio del rabbino svolge un discorso lineare e potente trattando dei problemi (di allora e oggi) della giustizia italiana e lo fa da grande interprete delle problematiche, che ben conosceva e a cui tanto tentò di ovviare; tratta anche degli infortuni sul lavoro, con piglio corretto; però – ed è questo che vi invito a considerare – a un certo punto il desiderio di decoro assume il comando delle ostilità. La tragedia della misera condizione dei lavoratori è ben compresa, ma… signora mia, questi poveri. La prospettiva si ribalta. La tutela consente abusi (ieri i trucchetti dei lavoratori della solfara, oggi il wifi dei negri) e questa va combattuta senza pietà.
Ma diamo la parola all’officiante (perdonerete ogni tanto il commento tra parentesi):
Ogni infortunio è sventura che colpisce il lavoratore onesto e povero, e con lui la famiglia, quasi sempre troppo numerosa [poteva pensarci prima di affogare nel sesso promiscuo la propria misera condizione, direte voi], che lo scarso salario [e mica è colpa del padrone, è lui che è ignorante e non lo hanno preso come CEO all’UBS] appena difende giorno per giorno dai tormenti dell’inopia e della fame. Onde legittimo è il compianto e benedetta e provvida la legge che soccorre a tanta iattura e vuol medicate da una bene ordinata previdenza dell’industria le piaghe che industria stessa ha dolorosamente aperte [e qui c’è l’unica osservazione politica rilevante, laddove si pone la responsabilità per l’attività di impresa, però attenti, al “ribaltone” in arrivo] però la malizia e la frode, nimiche di ogni buona istituzione, sonosi presto anche qui infiltrate esercitando la loro azione corruttrice. Operai infingardi, e sfruttatori indegni, cooperano assiduamente alla creazione di infortuni fittizi e alla enorme esagerazione dei veri, suscitando così il sospetto e la ripugnanza là dove solo il mite senso della pietà dovrebbe regnare [il padrone legittimamente sfrutta per il benessere sociale, l’incidente è fatalità, che merita pietà e ristoro moderato]. I fatti sono spesso per indicare come la sete dell’illegittimo profitto tocchi il confine dell’incredibile rammento la condanna testé pronunziata dall’autorità giudiziaria di Napoli contro un cotale che teneva una vera e propria fabbrica d’infortuni, una casa di salute a rovescio, come l’han argutamente denominata, e divideva con gli sconsigliati, operai il frutto delle mal carpite indennità. A questa causa perturbatrice gravissima, altre se ne aggiungono, che alterano nella sua essenza la benefica istituzione. La certezza della indennità, e la speranza che il profitto sia maggiore del danno, fanno tacere la naturale prudenza che servirebbe ad evitare la più gran parte degli infortuni leggieri [assetati di indennità gli operai si cacciano giù dai ponteggi, bevono l’acciaio incandescente, irretiti dall’ingiusto benessere – che al povero spetta unicamente una decorosa sopravvivenza].
Invero, il mantovano, estende il ragionamento ad argomenti simili a quelli trattati dagli odierni estensori di protocolli, dove il desiderio di chiarire, assecondare “svariatissimi casi” implica l’uso di misure “concordate” tra i protagonisti del processo, che debbono collaborare:
La liquidazione degenera poi troppo sovente in litigio, con aumento sproporzionato non solo di dispendio ma anche di pericolo che la legge sia deviata dai suoi diritti propositi nelle singole applicazioni pratiche [nell’oggi, fingersi “profughi” mentre si è “economici”]. Dovendo essa contemplare una infinità di casi svariatissimi non poteva tutti individualmente definirli e disciplinarli. Di qui la naturale perplessità della interpretazione, che fornisce esca sovrabbondante alla sofistica difesa di pretensioni cavillose e illegittime [se elimini l’avvocato, il cavillo è evitato]. E la legge, così saggia nel suo concetto fondamentale, può molte volte incontrare censura non temeraria, come se avesse voluto essere subdola ordinatrice di ingiusta spogliazione a carico dell’industriale [il ribaltamento delle responsabilità è concluso] o dell’assicuratore. Il giudice fa del suo meglio per non riuscire complice involontario e sanzionatore inconsapevole di baratti e imposture. Ma la rettitudine dei propositi è anche insidiata e deviata dalla fallacia dell’istruzione dei processi, che poggia essenzialmente sugli apprezzamenti dei periti, spesso errati per insufficienza di mezzi d’esame e di controllo, o per tardività di esecuzione; non sempre scevri dal sospetto di errore volontario, prodotto di compiacenza colpevole ed interessata. Queste brutte sorprese, che il legislatore non aveva prevedute, sono ormai note e deplorate; e i ripari legislativi non solo furono invocati, ma pure a lungo studiati e più d’una volta proposti al parlamento. Sia la, difficoltà della materia, sia la resistenza degli interessi contrari, sia la fatalità del nostro regime politico per cui il succedersi dei gabinetti produce improvvisa variazione nel criterio con cui i ministri valutano l’urgenza dei provvedimenti, finora la riforma legislativa pare un vano desiderio.
La stessa pietà da Ancien Régime cui attinge la sentenza del Tribunale di Palermo che condanno i popolani per i fatti dell’8 luglio 1960: «quasi tutti incolti, alcuni addirittura analfabeti e privi di buona educazione familiare, dell’educazione scolastica e forse anche di quella religiosa, sottoposti a continue iniezioni di odio contro i poteri costituiti e per tradizione plurisecolare educati al disprezzo del poliziotto».
Il proletario, il povero fanno sempre paura, risultano il nemico da battere, sia zolfataro terrone, sia negro munito di cellulare. E non perché “rivoluzionari”, ma perché pongono – per la loro stessa esistenza – una domanda circa l’ineluttabilità dell’attuale assetto. I piccoli stratagemmi del lavoratore delle solfatare per arrubacchiare quale centesimo in più di indennità, il rifiuto del lavoro salariato perché orribile, il desiderio di fuga da un luogo indecente (indipendentemente dal fatto che laggiù vi siano guerre e pestilenze).
V – Il mio regno per una maschera antigas
Ecco da dove nasce il desiderio di ordine, decoro, muri altissimi. Ecco la voglia di mascherine per difendersi dalle malattie dei negri. L’emigrante porta con sé la miseria del paese d’origine, la propria magrezza (e in effetti i senegalesi vengono additati perché la loro fisicità non è conforme ai parametri codificati del migrante, laddove la potenza fisica che nega la fame e il dolore comporta un’eccedenza di disappunto tra avvocati e magistrati abitualmente non troppo dotati nel fisico, nonostante approfondite sedute in palestra).
Le foto del ’38 riprendono molte volte belle ragazze con la maschera antigas; mia mamma raccontava degli esercizi a scuola con quell’attrezzo che faceva quasi paura. L’incubo di Ypres, di Caporetto quando la morte arrivò con la brezza, pervadeva l’ignara giovane italiana la cui madre avrebbe donato oro alla patria e il padre già ebbe a donare i polmoni.
Vedere magistrati (ma anche saccenti avvocati del sindacato) portarsi, non si quanto ironicamente, la mascherina dietro, non è ignoranza ma replica della paura della malattia; quante volte si è detto di Coppi: perché è andato in Africa a prendersi “l’ameba”?, quante volte reaganiamente si è pensato: Rock Hudson si meritava l’aids che è una malattia che dio getta ai culattoni.
Meritocrazia: in senso inverso, ma pur sempre meritocrazia. Il terrore della TBC disvela l’inutilità della giurisdizione che non è più esercizio di un potere ma potere in sé. Morto il diritto resta il comando, nudo e feroce. Lo scherno del potere verso i poveri, verso chi la povertà disdegna, rifugge e quindi combatte.
Il magistrato che guarda su Facebook se i negri che deve giudicare si fanno i selfie nelle piscine comunali non compie un abuso, ma distorce la prova. La pruriginosa ricerca dell’indizio di benessere è tentativo di consacrare un teorema già scritto da altri (a sua insaputa, verrebbe da dire, perché ripeto parlo di persone degne e rigorose).
Dietro a tali atti la sofferenza di un ruolo sradicato dalla storia.
VI – Figli di nessuno (we don’t need this fascist groove thang)
Come forse saprete, a Baffo non piaceva essere contraddetto, tanto più in pubblico. Una volta disse (così, tanto per riciclare alla cazzo il povero Lenin) che il fascismo era la fase suprema dell’imperialismo. Palmiro – che c’aveva famiglia, anzi due) – nulla oppose, ma poi al bar, dopo aver versato un bicchiere di bianco moldavo, disse: sai Beppe, secondo me, il capitale è più contento se può essere libero da vincoli e il fascismo è vincolante per l’impresa; il capitale ricorre al fascismo solo se ne è costretto, e controvoglia.
Baffo, che da solo aveva riportato l’ordine a Kronstadt, condotto i carri a Berlino, sconfitto orde di medici ebrei, inventato con quasi 20 anni di anticipo la rivoluzione culturale, ristette, lo sguardo era triste, gli occhi guardavano cose mai viste, poi disse a Palmi, con voce sognante: mi piaccion le fiabe raccontane altre.
Quindi l’osservazione del migliore è esatta e convalidata – ma allora, perché il capitale ha bisogno di ordine, disciplina? Perché questa montatura sulla lotta al degrado?
Forse perché siamo più forti di quello che crediamo, di quello che la carente (assente) organizzazione di lascia intendere. La TBC in effetti ci infetta. Tutti siamo malati, da Taranto a Cornigliano, i polmoni corrotti e non ci sono mascherine a proteggere le “forze” dell’ordine e del decoro. Non esiste altro rimedio che ridicolizzare la controparte assumendo ridicoli protocolli, un po’ come fece Fujimori con Gonzalo. Il capitale deve mettere a ogni singolarità precaria la divisa da carcerato sul tipo della Banda Bassotti perché, con l’esasperazione di tutti i cittadini onesti, svanisca anche il desiderio, l’espressione della fuga, la possibilità di modificare quell’angelo di marmo che, sotto il nome di protocollo, è posto sulle nostre tombe….
E ora, se siete nati chissà quando chissà dove allevati dalla pubblica carità senza padre senza madre senza un nome e vivete come gli uccelli in libertà ballate ora con me, please: