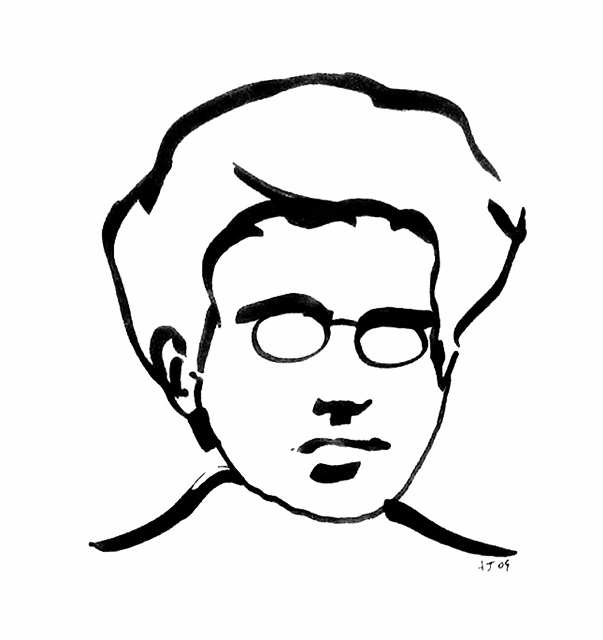di FANT PRECARIO.
Detta come va detta: sono i vecchi (i reduci) a rompere i coglioni con il proverbiale “ai miei tempi” (che accomuna tutti i reduci, di ogni tempo e credo politico) o sono i giovani davvero incapaci di prendere il capitale per le corna?
La rilevante questione è già stata trattata magistralmente in Totò, Fabrizi e i giovani d’oggi, e più direttamente in senso politico in Don Camillo e i giovani d’oggi (con una Carol Andrè che Lazzaro avrebbe dominato i 200 metri di Monaco ’72 alla faccia di Borzov, ma soprattutto testimonianza di come a Bologna, prima che a Washington, ci si portasse avanti con la finanziarizzazione); e soprattutto, involge il senso delle nostre esistenze militanti, chi più, chi meno (e “chi più,” mi auguro non si offenderà per l’accomunamento ai “chi meno) di tutte le epoche.
È rilevante:
(i) per noi, old school, perché non siamo morti (e a vedere come mi guardano a volte amici e parenti, probabile sia un male); e perché persistiamo a calcare un palcoscenico che ormai ci vede tralatici riproduttori di gesti inutili (parlo per me, ovviamente, e a smentirmi Robert Wyatt e Jagger-Richard, per non buttarla in politica sennò verrei bacchettato per culto della personalità);
(ii) per i giovani (ammesso che esistano), in quanto titolari di sfilacciate pretese e doglianze che si schiudono e appassiscono nel giro di un minuto (storia di un minuto, verrebbe da dire evocando il compagno Mussida).
Ed è proprio da sub ii) che l’indagine deve prendere avvio.
Ma è proprio vero che le lotte attuali non si “sedimentano”?
E prima?
Il maggio, calendario alla mano, è durato un mese.
Il ’77, un anno (anche se, a dirla tutta, era finito nel ’76).
E, poi, cos’è la sedimentazione? Secoli di combattimenti di poveracci riuniti fittiziamente da un afflato storicista? O pochi giorni che, tramandandosi nel ricordo, diventano mesi e i mesi, anni?
Un esempio su tutti: la “resistenza” inizia subito dopo Caporetto? O sull’Aventino? O il 25 luglio? E quando muore? A Salerno? Con il partito nuovo? Quando Alexander dismise il Montgomery e indossò gli occhiali alla Mac Arthur? Sta di fatto che il 26 aprile del 1945 era già consegnata alla leggenda e alla sconfessione [Calamadrei ragiona di resistenza tradita nel 1947: «e se i legislatori saliti al potere dopo la liberazione non hanno avuto il coraggio o l’accortezza di sconfessare apertamente la vecchia legalità e di crearne una nuova, non c’è da meravigliarsi che i magistrati, rimasti attaccati al filo illusorio della continuità giuridica, si siano fatti senza volerlo i restauratori della legalità fascista» P. Calamandrei, Restaurazione clandestina (1947), in Scritti e discorsi politici, a cura di N. Bobbio, vol. I, t. 1, Firenze, La Nuova Italia, 1966, p. 354].
Insomma, quanto dura un anno (più corretto sarebbe: quanti litri pesa un metro?)? Quanto vogliamo farlo durare, ovviamente.
Basta non guardarsi allo specchio e siamo sempre teenagers, oppure impariamo a “truccarci” da giovani.
PRIMA DOMANDA:
Quindi, la prima domanda è: chi ha introdotto l’uso biopolitico del botox nel movimento operaio?
****
Mettiamo, anche, qualche punto fermo.
1- I giovani sono numericamente pochi, in un’Italia di vecchi;
2- L’Italia non è comunque un paese per vecchi (per le stesse ragioni per cui non è paese per giovani);
3- Rosario Nicolò era ordinario a 24 anni. Andreotti a 30 demolì il neorealismo. Quanti anni aveva il Ferroviere di Germi? (sicuramente era più giovane di me, che faccio il pagliaccio scrivendo queste note in spiaggia con il cappellino da jeune fille permalosa alla Rohmer per salvare la pelata dai raggi del sole). Non parliamo del Coppi del giro del ’40 e dello Steve Winwood che ancora oggi ci consola.
Well, my temperature is rising, got my feet on the floor
Crazy people rocking ‘cause they want to some more
Let me in baby, I don’t know what you got
But you better take it easy ‘cause this place is hot
And I’m so glad you made it, so glad you made it
You got to gimme some lovin’,
gimme, gimme some lovin’
Gimme some lovin’, gimme, gimme some lovin’
Gimme some lovin’ everyday
4- Non solo i vecchi la menavano ai giovani del movimento, i giovani stavano alla larga dagli anziani, in via cautelativa: il comandante partigiano Buranello non si cagava i vecchi PICINI, e così i ragazzi dalle magliette a strisce i resistenti. Pochi “autonomi” nei mid seventies conoscevano la storia del movimento operaio. C’è bisogno di conoscere la patristica? E il culto per la scolastica? A Bolzaneto (ed erano passati poco più di 10 anni) ignoravamo la Baia dei Porci, tanto che volevamo chiamare così una discoteca (ancora oggi mi pare eccezionale doppio senso, manca solo Aldo Maccione alla consolle). E il Che? Era ancora caldo e il ricordo (neppure vivissimo) pareva quello verso classici tipo Kerouac e Omero, non certo esempio colto nell’attualità.
Insomma, quando è che il movimento operaio ha smesso di essere una masnada di masnadieri? Una brigata di briganti? Quando abbiamo conosciuto la nostra patria, il nostro nome? Per opera di quale maledetto demone? Quando la pubblica carità ha smesso di allevarci e ci siamo accontentati del welfare?
SECONDA DOMANDA:
quando abbiamo accettato il campo di gioco avversario?
*****
Uno dei fratelli della nonna paterna perse una mano giocando con una bomba a mano; il nonno paterno non mangiava acciughe perché aveva visto come divoravano gli alpini annegati in divisa “da campagna” nell’affondamento delle navi che li trasportavano. Il nonno materno tornò dal fronte tubercoloso e appena giunto sull’argine del Polcevera apprese (per fortuna non era vero) che la “sua Laura se l’era portata via la spagnola”. Subito dopo l’insurrezione mio padre puliva i silos di grano respirando merda perché così guadagnava qualcosa di più.
La morte era una costante nella vita del proletario: la morte ondeggiava sulle vite dei (per noi) vecchi, e non lo dico per gusto dell’ovvio o fingermi pensatore [tranquilli, eroi della precisazione, lo so che anche ora si muore e tanto (non lo nego né potrei: ma ai tempi, va detto, si moriva il doppio), ma non è più consapevolezza di una certa sanzione comminata al povero in quanto tale, bensì sfiga che talvolta capita anche da giovani, e poi ormai si è giovani sino a 47 anni, basta un Aperol Spritz ed è subito Turtles. E qui si snoda la confusione, dove la canzoncina mielosa perde il connotato ridicolo e assurge a memoria del bel tempo andato, mondo trasversale dove tutto è permesso, dall’autunno caldo alla summer of love agli occhiali alla CBGB, purchè sia morto].
Ti istruivano a morire in chiesa, sul lavoro, a militare, i compagni di cellula (novelli carbonari feat. Caronte). Eri pronto, bastava un gesto, uno sguardo di disappunto ed eri morto.
Quando parlavo con loro, i vecchi della brigata Balilla, scampati a italianissimi rastrellamenti e delazioni (e poi alla Celere e ai magistrati repubblicani, anche quelli “costituzionalmente orientati”) non si dolevano mai dei morti in “battaglia” (a parte forse per Zamperini, caduto nella battaglia del Monte Sella): il refrain era “alla SANAC si moriva”.
Non voglio parlare del culto della morte (che lascio volentieri ai fascisti o a chi pensa che un “tumore sia dono”), ma della presa d’atto che in ogni comportamento, in ogni azione c’era il rischio di lasciarci le penne. Il rischio iniziava con il parto, proseguiva con le mille malattie dell’infanzia, poi il lavoro in fabbrica, poi le lotte nei campi e ancora nell’officina. E l’abuso delle uniche droghe che il partito e Hollywood consentivano ai poveri: Bacco e Tabacco [e per i più hard, Venere, anche se la mia generazione è stata too young to sifilide, too old for AIDS].
Ecco, un bel giorno ci si stufò di morire e questo ha inciso non poco sulla modalità delle lotte (già) “come un sol uomo”.
TERZA DOMANDA:
quando abbiamo aderito al I teorema dell’OREAL: perché io valgo?
****
Si, minchia! Noi valiamo e i nostri corpi sono certo organi sparsi del proletariato, ma non è che possiamo regalarli al primo che ci dice “è bestiale, ragazzi! L’ha detto anche Lenin” (cit.) o fare da bersaglio per gli esperimenti di Placanica.
Una cosa che colpì i partigiani fu l’approccio americano allo scontro: prima bombardavano con gli aerei, poi quando erano rimasti uno o due elmetti teutonici (o un pugno di “musi gialli”) passavano ai cannoni, poi ancora avanzavano i carri. Quando del nemico restava solo una copia scolorita del “Tempo” che annunciava “li fermeremo sul bagnasciuga” arrivava la fanteria. Salvare il soldato Ryan era cosa estranea agli altri eserciti del mondo (libero o meno che fosse): mai sentito il motto: salvate il soldato Calogero, o Franz o Maurice? Morire, non ripiegare ripeteva ossessivamente Cadorna e aggiungeva «le sole munizioni che non mi mancano sono gli uomini».
Se la guerra è scuola di vita, gli studenti che la frequentano non possono non ridurre la vita ad optional. Ancora Buranello, a 18 anni: «ieri ho concluso che occorre sacrificarsi, che il sangue dei Martiri segna la strada più sicura alle idee; il nostro Risorgimento era fatto inevitabile già dopo i primi tentativi falliti e soffocati nel sangue… Occorre trasformare il pensiero e i sentimenti in azione […] Ma prima di giungere al sacrificio supremo bisogna prepararsi, perché tale sacrificio possa effettuarsi ed abbia maggiore efficacia».
No Giacomo, non va un cazzo bene! Eri il più coraggioso e il più geniale, sfidavi i tedeschi e i fascisti come 20 anni dopo i tuoi paesani avrebbero fatto con i tornanti dei Giovi e ancora dopo, noi – su improbabili mezzi che chiamavamo moto – l’ascesa alla Bocchetta o le “campagnole” blu o verdi. A ogni curva la madama, a ogni salto un repubblichino, a ogni incrocio un camion.
Non va meglio così?
E poi, quelle parole…: “Il risorgimento” è evento buono per tutte le stagioni al quale si potevano abbeverare indistintamente Bava Beccaris, Roatta, Mazzini, La Malfa, Craxi, Agnelli (quale in quella famiglia di cannibali? Fate voi, sono tutti uguali); e perché un “sacrificio supremo”? il Comunismo non doveva essere godimento dei sensi?
Infine, prepararsi a cosa? Fare la rivoluzione per riprodurre un mondo di merda? Magari dopo aver intinto le bandiere monarchiche in una latta di vernice rossa che sarebbe finita sempre troppo presto?
Allora, però, i vecchi erano pochi (dalla Russia non è che tornarono in troppi) e i giovani tanti. Nelle prime sere del dopoguerra, grazie a una musica per anni occultata, si consumarono amori di un attimo o di una vita: nacquero tanti figli della ricostruzione. Li riconoscevi senza bisogno di essere Tom Ponzi o lavorare al SIFAR: canottiera sempre sporca di sugo, pantaloni sdruciti, scarpe senza calze anche d’inverno e non era vezzo come con le rockstud, proprio che non c’era una lira. Comunque, musica da scimmie + velocità contro ortodossia + livore (per la vittoria mutilata) fu il primo scontro giovani/vecchi di cui ho notizia. Ci pensò Scelba a chiarire i termini della questione, grazie – anche – alla sagace regia dei fascisti rimasti ai vertici della Repubblica, pur tutelata dalla costituzione più bella del mondo (che si cominciò ad applicare quando il progetto che la informava fu superato dall’esistente). Gli anni ’50 e i primi ’60 si segnalano per l’enorme numero di morti e per il definitivo scollamento fra il partito (che si ricordava dei militanti solo quando finivano sotto i colpi del destino cinico e baro) e i militanti (se ancora si potevano definire tali in relazione ad un partito che si assestava nell’empireo dell’assessorato all’edilizia).
[Una questione che meriterebbe di essere affrontata è la ricerca di allora verso la canzone popolare e per il recupero di una cultura che affrontasse il pattume che la scuola democratico (poco) cristiana (molto) e la TV di Bernabei (e la rivalutazione che ne fu fatta anni dopo in chiave antiberlusconiana fa comprendere molto dell’infamia Veltroniana) seminavano tra le giovani menti; ma non è questa la sede: ai “giovani” della periferia – ancora rivolti alle scuole professionali quando non direttamente alla catena – tutto questo non interessava e quindi non interessa a me; resta il fatto che, una volta, Giovanna Marini, raccontando quei tempi, disse che cantava solo di morti, il cipresso è l’albero mio, e a me, questa “sedimentazione a mezzo di vita (perduta)” mi è sempre parsa inutile artifizio.].
Riprendiamo dopo l’interruzione. Quindi, ci sono giovani e vecchi, e ci sono sempre stati. Ci sono sempre stati scazzi e incomprensioni, ma alla fine il capitale – sussumendo la spinta opposta che tra quegli scazzi si produceva – contribuiva a unificare la “sinistra vecchia e quella nuova” (talvolta a mezzo di manganello, talvolta agevolati da un’apparizione strana, una damigiana).
Una prima risposta (gratis):
è più rivoluzionario il “saltino” di Joe Sentieri di mille condoglianze a mamme/mogli/figlie di poveracci morti per perpetuare la produzione fordista, ma con un’avvertenza: tanto il saltino di Joe che il bacino di Elvis, che la chitarra incendiata (Jimi)/spaccata (Pete), che (ancora, ma con qualche necessaria precisazione) il Bono scemo che va a cavallo bandieromunito sono tutti saldamente innestati nel sistema di produzione industriale.
Com’era la questione giovani/vecchi? I vecchi sedevano sulle poltrone facevano il loro dovere (spostando sempre più avanti il giorno in cui sarebbe apparso il sole dell’avvenire), i giovani cominciavano a volere “tutto subito”. Possiamo dire che i vecchi bloccarono questo desiderio?
Certi si, certi no.
E poi,
(i) non dimentichiamolo, c’è stato un momento in cui D’Alema era giovane. Basterebbe questa considerazione per sparigliare le carte buttate sul tavolo in senso solo cronologico;
(ii) tutto era più facile: i vecchi volevano l’ordine (uno qualsiasi), i giovani il disordine, e basta riguardarsi un documentario qualsiasi su Woodstock (la visione del film originale non la auguro neanche ai fans degli Slipknot) per vedere che la cosa più importante era l’eliminazione della vigogna, e il conseguente senso di liberazione accomunava “grandi e piccini”;
(iii) la catena “incatenava” al lavoro ma liberava le menti desiderose di “sporco”. L’internazionale del degrado trovò uniti giovani e vecchi, operai e studenti, perché l’ordine era superabile e (già) superato nell’interesse (anche) dello stesso capitale. La questione non era insormontabile: l’ordine à la Franco (parlo dell’occidentale primo mondo) era venuto a noia anche ai più puri; c’erano auto volanti e ancora i falangisti si riducevano a guidare vecchie SEAT 600?
La possibilità di un comunismo come elegante benessere non poteva non solleticare, ma (forse?) costava troppo. Detto meglio: avrebbe dovuto generare sempre nuovi modelli di auto volanti (e di nuovi ministri/piloti in sempre proficue carrere), ma il prezzo del carburante, troppo basso, non consentì sufficiente profitto. Occorreva qualcosa che consentisse una rendita svincolata dalla produttività e dal consumo di merce (e la sterilizzazione del desiderio di vedere volare i propri nemici).
Seconda risposta (parimenti non richiesta, maggiormente “alla cazzo”):
È il passaggio dalla fase “consumistica” a quella antropofagica del capitale che accentua la divisione giovani/vecchi, dove però i vecchi sono orizzontalmente quelli che pensano che si possano riprodurre schemi lontani per pungere il nuovo ordine che non esita a organizzare macellerie messicane nel centro di Genova (un po’ come i diciottenni che votano Rizzo o i sampdoriani che pensano alla presidenza Vialli come rigenerazione del vecchio Ferraris). La capacità del capitale di dislocare forme repressive dell’altrove (rispetto alla nostra patria socialista, intendo) nel cuore della nostra piccola patria, appunto dovrebbe renderci perlomeno più attenti nel piangere, rimpiangere le bastonate del passato (che, pur rimarginate, erano e restano bastonate).
Ci fu un momento in cui le macchine rubate nel centro delle città del Triangolo Industriale trovavano mercato nelle periferie delle stesse città, poi furono mandate al sud (un modo pratico di compensare l’irrisolta questione meridionale), poi in Albania (sotto lo sguardo indispettito delle casematte di Enver), infine in Madagascar.
Si deve forse smettere di rubare? Si deve forse smettere di sognarsi gioventù bruciata per un giorno? Se sì, siamo allora davvero vecchi.
Non sarebbe forse meglio rinnovare il senso del furto, inventare sempre nuove elaborazioni per i nostri vespini, ormai caricati solamente a salve?
La sconfitta della mia generazione (e di quelle successive) non la misuri (o non solo) in termini di (minori) salario e tutele ma di attenuazione progressiva del senso di insofferenza verso gli indumenti (in)gessa(n)ti.
Un numero di “Vogue” dei primi ’80 intitolava Siamo donne o caporali?, alludendo alle geometrie squadrate che partite da Lyotard (o era Montana ubriaco che recitava?) arrivarono al Duca Bianco e da lì dritte nei libri della finanza in via di autonomizzazione. Il professore di statistica che mi interrogò in un improbabile esame alla Bocconi nell’agosto del 1981 mi invitò a vestirmi in modo più degno per un giovane del mio lignaggio (che rinveniva direttamente dall’onere di essere interrogato da lui, evidentemente). Quando risposi che io, sulla sua fiammante Lancia Gamma, ci avrei cagato, da buon padre di famiglia mi sollecitò a uscire dal passato. Aveva ragione, ma perché uscire dal passato espungendo proprio quello che del mio sentire era più rivolto al futuro?
Tutto verte sull’ordine e sulla possibilità del suo contrario (chiamiamolo disordine, ma preferirei attingere dall’attualità e chiamarlo degrado) di generare organizzazione.
Sarà un caso che i superstiti dei Joy Division di Disorder, quando abbracciarono la dance per valorizzare la morte, mutarono il nome in NEW ORDER (e anche lì risiede una truffa: il “nuovo ordine” può essere quello di Gramsci ma anche quello di Pino Rauti e la cessione di “sovranità” proletaria della disco alla dance è ben più grave dell’omicidio del reverendo King. Chi vendicherà il reverendo Gary Davis? Chi ha ucciso Pigpen, e perché affidare le indagini ai Ros)?
Ma quale ordine? Quale disciplina? Cosa produrre attraverso la riconduzione all’ordine dei nostri movimenti (tanto in senso politico che propriamente fisico, la postura dell’ordinato è differente da quella del degradato e la puoi solo imporre, non vendere, che se da un lato è più facile, ti scordi la rendita)?
L’ordine costituito (quello dei codici e dei caramba) era rigore formale; bastava andare in chiesa con una gonna della lunghezza gradita a Scalfaro, rispettare il padrone, essere produttivo e i problemi finivano lì. Poi potevi anche bestemmiare, pisciare per strada, ammazzarti di cancarone: quello – come il voto – restava nel segreto dell’urna (funeraria). E, probabilmente, potevi anche riuscire a condurre con relativo successo queste due vite parallele: così saresti andato bene anche nel caso di ipotetica vittoria dei Soviet modello coopsette.
QUARTA DOMANDA:
morta una fabbrica se ne fa un’altra?
No, quell’ordine è finito, finito con la fabbrica. L’ordine, come il lavoro di fabbrica (inteso come quello che noi vecchi abbiamo conosciuto), come la fabbrica stessa, sono morti. Meglio: sopravvivono come feticci ma vanno a dislocarsi in altri luoghi e per altri fini.
Terza risposta:
<u>La Madonna di Salvini non è la stessa che Mons. Siri portava in giro per le elezioni del’48, l’ordine del codice penale non è quello del partito dei sindaci tipo Sala e Nardella.</u>
Quarta risposta:
<u>Salvini non è fascista se non quanto e come Sala e Nardella.</u>
A. De Marsico [Il primo decennale del Codice penale fascista, in Annali di diritto e procedura penale, 1941, pp. 859 e 861] ci avvisa:
Il privilegio della nuova codificazione, riflesso del carattere essenziale della nostra Rivoluzione, è stato associare a principi della nostra tradizione classica (supremo quello della imputabilità morale), altri (preminentemente quello della pericolosità) senza i quali il diritto penale è incapace di conseguire i suoi fini. […] Così, introducendo fra le categorie dei delinquenti di maggiore pericolosità il delinquente per tendenza, la nostra legge penale ha conseguito una tappa avanzatissima dell’accordo tra antropologia e diritto.
V. Manzini [Un decennio di applicazione del Codice di procedura penale Rocco, in Annali di diritto, cit., ppg. 2-3] precisa che
il codice di procedura penale, sveltendo le forme processuali, rinforzando il principio di autorità, eliminando formalità ingombranti, introducendo disposizioni nuove dirette a far prevalere la sostanza sulla forma (parecchie delle quali hanno servito di esempio al nuovo codice di procedura civile), ha conseguito pienamente lo scopo della riforma. […] una riforma conforme allo spirito dello Stato fascista.
F. Vassalli [Motivi e caratteri della codificazione civile, Milano, Giuffré, 1947, p. 2] chiosa:
il Codice civile cessato e in generale i Codici dell’Ottocento presentavano ancora la disciplina di rapporti atomistici, tra individui in regime di libera concorrenza, conforme al concetto che l’interesse generale coincida col libero esercizio dei diritti individuali […]. Il diritto soggettivo figura ancora nel Codice […] ma lo spirito della legge è mutato. I fini ai quali l’attività umana si volge e per cui chiede protezione sono tutti minutamente valutati dal legislatore.
Senz’altro, queste parole troverebbero ampia condivisione tra le frange sovraniste: il legislatore “valuta” e prevede i fini che debbono informare l’attività umana, che per tale (sola) ragione è consentita; il diritto soggettivo degrada a diritto oggettivo e rivolto a una ben individuata categoria di “soggetti” (che tali sono ove annegati nelle adunate oceaniche o nella “gente” odierna). Perché la tutela giurisdizionale ti è accordata solo se le lamentate violazioni incidono non sul soggetto ma sullo stato che misura il respiro e lo vincola.
Però, se con le mazzate non puoi che mandare la gente a morire, se con la lotta dentro alla fabbrica e le correlative mazzate puoi vendere frigoriferi e 600, come puoi perpetuare la legge del valore (o sbaragliarla) quando ogni gesto (tanto del capitale che del suo antagonista) è già altrove?
Quando il diritto implode nella generalizzazione dello statuto dell’impresa, quando tutto passa per la produzione che chiunque offre a chiunque anche solo vivendo e riproducendo gli attimi della propria esistenza, come si possono violare i recinti che dirigendo la naturale produttività generano la nostra morte e attraverso questa trasformano l’agire del de cuius in rendita?
Ancora una volta si parte da uno statuto (quello dell’impresa dematerializzata, come prima da quello laborista, pur per fini diversi), ancora una volta lo scontro è fra due classi produttive, ancora una volta la lotta è per il dominio sui mezzi di produzione – che siamo noi: di qui la necessità di un nuovo sabotaggio, contro la merda che risiede in ogni nostro afflato apprendibile.
Non per essere patetici (anche perché in pensione non ci si va più tanto per volontà dell’INPS quanto per volontà della nuova costituzione materiale che ci regola) ma qui davvero ogni differenza (che non sia singolarità) si affievolisce come già il diritto soggettivo nell’oggettività paradossale del Codice Rocco.
Tutti abbiamo un tornio innestato nei polmoni malati, tutti ci troviamo a elaborare nuove forme di libertà (anche a nostra insaputa) e a goderne nello sfruttamento che pur ci uccide.
Non più tumori come alla SANAC (o a Taranto, per essere attuali, e il nuovo codice ARCELOR MITTAL appare plausibile laddove consente la non punibilità agli imprenditori assassini e non alla moltitudine che pure fa impresa e ben produttiva): confini, recupero delle modalità espressive del (fu) proletariato in termini piatti e “oggettivi”, protezione dell’attività di impresa solo se diretta allo stravolgimento degli affetti e della cura.
Ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra, vogliamo vedere nessuno sottoterra (al limite alla Kolyma), ognuno al mondo deve essere libero di non sfruttarsi.