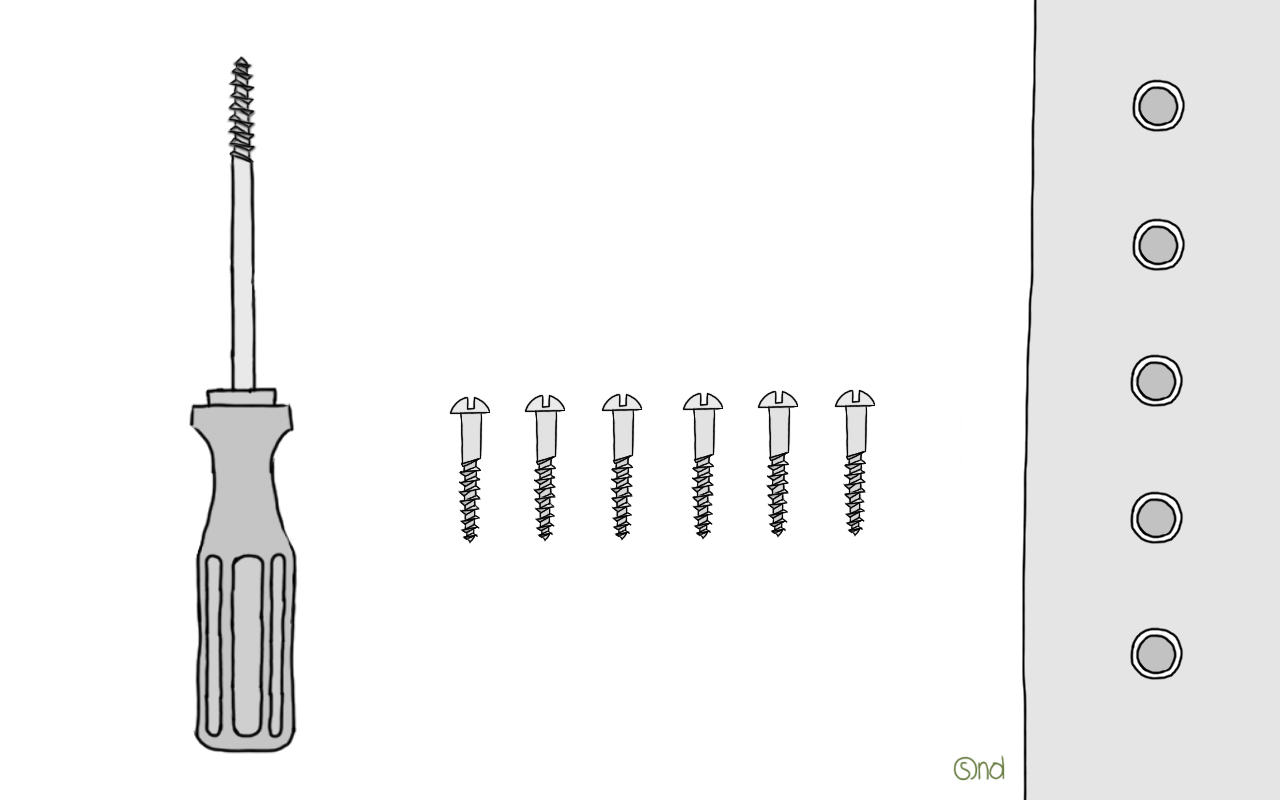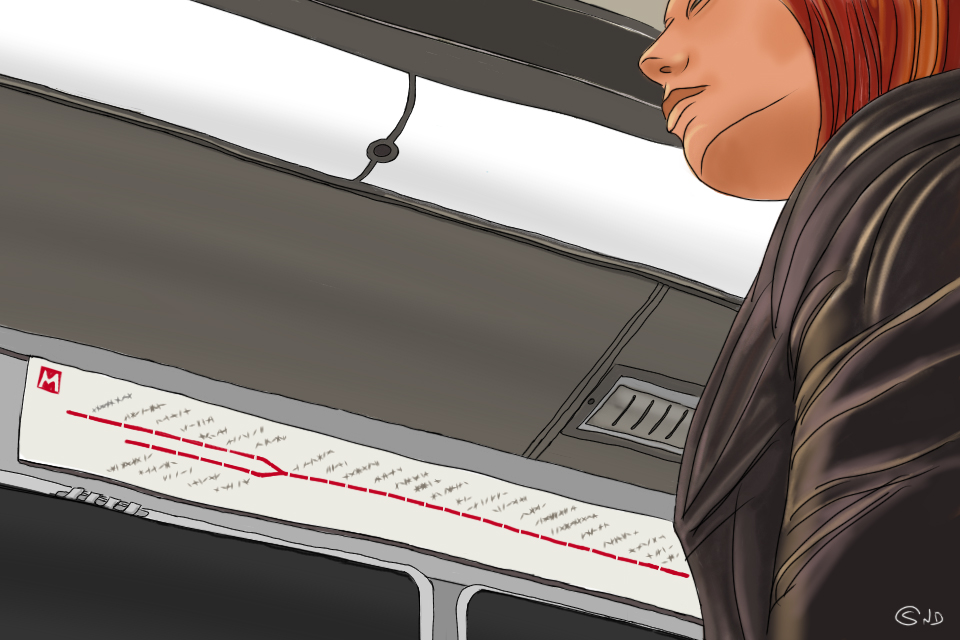Intervista a TONI NEGRI.
Come definiresti il concetto di “movimenti sociali” e la loro pratica? Ritieni che tale nozione possa avere cittadinanza e un qualche ruolo in un’analisi marxiana della società?
Credo che la definizione di movimento sociale sia estremamente variabile nella storia. Per questo nutro una certa antipatia per la sociologia dei movimenti sociali, perché li assume come un oggetto statico nell’epistemologia delle scienze sociali – un po’ come si fa, ad esempio, con la tipologia delle “generazioni”. Penso invece che il concetto di movimento sociale sia assai variabile.
Nel mio percorso intellettuale mi sono trovato, per esempio, di fronte alla definizione di “movimento sociale” di Carl Schmitt. Una concezione affascinante e importante, in cui il movimento sociale è quello che chiede Stato, è un movimento che ricerca, sostiene, desidera essere organizzato dallo Stato: è il movimento sociale nazista, le SSA. E ho incontrato amici che cercavano di unire questa concezione schmittiana con quella marxista (che attacca lo Stato, vuole distruggerlo), producendo confusioni sul terreno della definizione del concetto. La prima cosa da fare è dunque, a mio avviso, togliere di mezzo il progetto stesso di una definizione dei movimenti sociali. I movimenti sociali si definiscono solo in situ, solamente e precisamente dal punto di vista delle relazioni di potere in cui si pongono e da cui prendono forma dentro uno specifico momento storico.
Da questo punto di vista, mi sembra utile e importante riconsiderare una cosa che ho studiato “da piccolo”: la sociologia dei movimenti religiosi. Anch’essa è una sociologia importante, dove figurano grandi nomi, fra cui lo stesso Weber. Lì si introduce, ad esempio, la distinzione fra “chiesa”, “setta” eccetera, definendola a partire dalla specifica realtà storica. Cosicché risulta chiaro che la teologia millenarista di Gioacchino da Fiore e le molte sette protestanti e il successivo nomadismo ereticale possono essere definiti solo specificatamente, senza farne un tipo o un modello. Ad esempio, essi sono completamente diversi dalle tendenze millenariste presenti nell’ebraismo dell’Europa orientale, pur sfasati temporalmente ma situati nella stessa fase di costruzione della modernità. Insomma, non si debbono fare dei “tagli sociologici” omogeneizzanti, perché non ci aiutano a comprendere, si debbono piuttosto operare delle specificazioni storiche.
E allora: esiste una definizione di “movimento sociale”? Certo che sì! Ma, appunto, è definita storicamente. Penso che i movimenti sociali siano oggi movimenti che si pongono all’interno di una specifica struttura capitalistica e che all’interno di questa – oggi quella del capitale finanziario – cercano un processo di liberazione. I movimenti sono sempre processi di liberazione – oggi ad esempio dalle varie figure nelle quali il capitale finanziario esplica il suo comando. Quindi ci saranno, ad esempio, battaglie anti-patriarcali per la liberazione della donna, o battaglie contro il debito per la liberazione da una serie di condizioni sociali in cui si muovono i subalterni. Insomma, c’è tutta una serie di elementi che interpretano – a questo punto bisogna pur riconoscerlo – la lotta di classe, e cioè la lotta tra i poveri e i ricchi, la lotta tra il sistema di sfruttamento e coloro che nel sistema non vogliono stare.
Con quest’ultima affermazione tocchi il nodo cruciale del rapporto reciproco fra teoria dei movimenti sociali e analisi marxiana della società. Un nodo che potremmo riassumere domandandoti se ritieni che le nozioni di classe e di lotta di classe siano in grado di incorporare complessivamente l’azione dei movimenti sociali oppure se esistono degli spazi di eccedenza e di autonomia reciproca fra tali categorie.
La risposta risulta necessariamente ambivalente. La lotta di classe esaurisce la definizione di movimenti sociali? No e sì! No se la lotta di classe viene interpretata in modo brutale come movimenti dei poveri, dei proletari, puramente come questo. Sì se il movimento sociale è interpretato come rappresentazione del capitale variabile o meglio del lavoro vivo, cioè il lavoro produttivo che vuol rompere quel rapporto di capitale che lo trattiene e cerca liberazione. Quindi, si tratta di definire prima che cosa è la lotta di classe e poi il movimento sociale. Perché non c’è nulla di più stupido che assumere una definizione statica di lotta di classe – alla maniera del vecchio marxismo – e conseguentemente di movimento sociale. Questo irrigidire i concetti e poi cercare di applicarli è un’operazione culturale di origine americana che ha un respiro molto corto.
Marx ha scritto sui movimenti sociali alcuni dei libri più belli che siano stati mai pubblicati, i suoi testi “storici”, quelli sulle lotte di classe in Francia, sul Quarantotto, sulla Comune di Parigi. In essi troviamo un’interpretazione, uno sviluppo profondo non solo della lotta di classe proletaria, ma anche della borghesia, insomma delle lotte, dell’etica e della morale che fanno capo ai grandi poli della lotta di classe. Ecco, questi grandi poli esistono ancora oggi? Certamente! E su quale terreno si battono? Vado senz’altro troppo in fretta, ma la mia ipotesi è che ormai tutto ciò avvenga su un terreno investito dalle trasformazioni tecnologiche – dunque che i movimenti si qualifichino e si sviluppino in termini di appropriazione di “capitale fisso”. Oggi dappertutto, nelle lotte urbane, in quelle dei lavoratori, in quelle ambientali, il grande tema attorno al quale ci si batte, ha a che fare con la volontà di mettere le mani sul capitale fisso. In questo senso si potrebbe dire che oggi i movimenti sono “movimenti imprenditoriali“: imprenditorialità tecnologica, imprenditorialità moltitudinaria, imprenditorialità del Comune. Oggi il movimento sociale vuole dire prendere in mano il comune, tenerlo e gestirlo. Non esistono più movimenti di pura protesta, esistono solo movimenti di potenza – e credo che questo allargamento concettuale risulti anche da una lettura marxiana dei movimenti sociali.
Dunque tu suggeriresti agli studiosi di movimenti sociali di provare a incorporare il concetto di lavoro vivo al centro della loro analisi? L’interpretazione operaista della nozione marxiana di lavoro vivo potrebbe in qualche modo funzionare come una sorta di concetto ponte per l’analisi dei movimenti sociali? E si potrebbe in questo senso pensare l’operaismo degli anni Sessanta anche come una sorta di tentativo di studiare attraverso questo concetto un movimento sociale di lavoratori che si dava in quel periodo?
Certo! E dopo tanti anni vediamo che è stata un’interpretazione vincente. L’operaismo non è stato solo una corrente culturale, ma un insieme di ipotesi intellettuali di un piccolo gruppo che ha proposto alcune ipotesi al fine di capire come mutava la lotta di classe e cosa si era riconfigurata nel secondo dopoguerra. La storicità di questo processo e di questa tecnica di indagine è quindi molto precisa, specifica. C’era una classe operaia in profonda mutazione, in una situazione post-bellica dentro la quale i meccanismi capitalistici di ristrutturazione del capitale si davano, appunto, con una specificità di bisogni che si esprimevano fondamentalmente attorno al salario, quindi nelle lotte salariali, con la successiva dinamica dell’allargamento della lotta salariale alla lotta sociale per la conquista del welfare. E ciò è durato per una lunga fase: l’iniziativa capitalistica rispondeva alle lotte vincenti del proletariato, della classe operaia, e cercava di eliminarne la potenza assumendo i bisogni espressi dalle lotte.
Ecco, questa può essere una metodologia. Se assumiamo il metodo di analisi dei movimenti dentro la relazione servo-padrone – per dirla hegelianamente – o capitale-lavoro – per dirla marxianamente – o autorità-suddito – per dirla alla maniera schmittiana – allora cos’è il movimento sociale? È quella cosa che “sta in mezzo” e che però si caratterizza sempre come potenza contro potere. Se non c’è il contro i movimenti sono espressione del potere, dello Stato, della classe dominante – come voleva Schmitt. Potenza da un lato e potere dall’altro: questo possiamo dire in termini generali, ma poi ciò deve essere sempre declinato nella specifica realtà storica. Puoi avere uno schema in testa, ma esso risulta sempre rigido; peggio sarebbe se fosse uno schema dialettico, perché presupporrebbe un’Aufhebung, offrirebbe una chiusura dall’alto. E invece qui non c’è nessuna soluzione, c’è semplicemente il problema di mantenere sempre, praticamente, aperto il conflitto e, teoricamente, il questionamento. Dopo Marx c’è Foucault ad indirizzarci su questa via.
I movimenti sono sempre caratterizzati non solo dalla definizione della condizione storica, ma anche dalla strategia che dentro questa condizione storica essi esprimono. È il principio dell’unicità, della singolarità, dell’irrepetibilità di ogni movimento: questo è il nodo centrale… soprattutto se i movimenti li hai vissuti.
Quasi parallelamente al consolidarsi delle ipotesi e del metodo operaista che hai ora descritto, veniva emergendo, in differenti ambiti, il discorso sui cosiddetti “movimenti post-materialisti“, che descriveva come tali quelli degli studenti e delle donne, quelli pacifisti e per i diritti civili. E proprio a partire da questa prospettiva ha preso forma la sociologia dei movimenti sociali, i social movement studies, come sforzo di valorizzare, anche in opposizione al supposto economicismo marxista, elementi direttamente politici e di agency che si riteneva l’approccio classicamente materialista fosse incapace di cogliere. Di qui l’elisione di concetti come capitalismo, classi sociali, sfruttamento, rivoluzione dal campo della sociologia dei movimenti sociali. Cosa pensi di questo discorso e di queste prospettive teoriche?
Personalmente sono un teorico del lavoro immateriale. Penso che il lavoro cognitivo sia assolutamente centrale e che esso non rappresenti semplicemente una particolare attività, ma un insieme di razionalità, attività, affetti, volontà, comportamenti, eccetera. Credo che la figura attuale del lavoro vivo abbia una consistenza cognitiva, affettiva, cooperativa, caricata insomma di tutti quegli aggettivi attraverso cui una volta si definiva la spiritualità. Forse è per questo che, quando si dice “movimenti post-materialisti”, non capisco proprio di cosa si parla. Si parla della lotta degli angeli? No, si deve comprendere che si fa riferimento invece a movimenti propriamente materialisti come lo sono tutti i comportamenti piantati storicamente nella realtà – nel senso che nascono in un mondo di merci, di tecnologie, di reificazione e di alienazione – in una natura completamente trasformata dall’azione umana (natura 1, natura 2, eccetera all’infinito) – in un rapporto di forza sempre aperto, liberatorio o distruttivo. È così che si toccano le funzioni specifiche del vivere.
La lotta femminista non è una lotta post-materialista! È una lotta sul potere, sul potere materiale. È una lotta sul salario, sul lavoro domestico, sulla posizione della donna nella famiglia e nella società. Ma soprattutto di liberazione contro il giogo secolare sofferto dalla donna sul suo corpo, sui suoi affetti, emozioni e potenze; è un processo di liberazione dinamico, sempre in movimento (a meno di non assumere posizioni identitarie e/o teologiche come quelle assunte dal movimento della “differenza”).
Tutti i movimenti contemporanei si collegano alla scoperta della forza lavoro immateriale, di una classe lavoratrice cognitiva e cooperativa, e quindi a una ricchezza di emozioni, affetti, volontà, odio, amore… E tutto questo in un mondo che non è più quello di una volta, non è più il mondo dell’uomo e della natura, ma è il mondo dell’uomo e della seconda, terza, quarta natura, cioè delle macchine. E, quindi, che cosa vuol dire appropriazione tecnologica, appropriazione del capitale fisso? Vuol dire riuscire a comandare sulle strutture materiali e tecniche – prodotte dal capitale in termini acquisitivi, di sfruttamento – che circondano la tua vita, che la “situano“. Questo vale per il vivere nella metropoli come per il lavoro in fabbrica, come vale, alla fin fine, anche per i rapporti fra due persone, che, non appena mettono al mondo un bimbo, si accorgono quanto le tecnologie siano importanti, quanto la natura sia diventata ormai – come dice Judith Butler – un semplice ‘assetto’ di queste cose naturali (storiche).
Il tuo lavoro con Michael Hardt è citato due volte in questo numero di “Anthropological Theory”. Per concludere questa intervista vorremmo rivolgerti due domande inerenti alle osservazioni critiche che ti vengono avanzate. In primo luogo, nel suo Feminisation of labour and the “new sexual contract”, Brunella Casalini sottolinea l’importanza del tuo contributo nell’affermare che contatto e affetti sono una componente decisiva del lavoro contemporaneo, ma al tempo stesso richiama l’esempio delle donne migranti impiegate nei servizi di cura e assistenza per affermare la distinzione e i punti di eccedenza fra lavoro immateriale e lavoro di cura e riproduttivo. Cosicché le caratteristiche del lavoro “femminile” nella fase contemporanea dell’accumulazione capitalista mostrerebbero l’impossibilità di distinguere tra la dimensione materiale e quella immateriale, piuttosto che l’assestarsi di un’egemonia di quest’ultima che rimane invece confinata a una minoranza del globo e della popolazione mondiale…
Sono d’accordo sull’impossibilità di distinguere lavoro materiale e immateriale. Come si sa, la questione del lavoro immateriale è stata per noi la necessità di affermare che il lavoro non era più solo quello delle mani callose, ma era anche quello del pensiero, dell’affetto, della relazione, della cura. Era assolutamente necessario, per affrontare tutti gli aspetti del lavoro, introdurre con forza questo discorso, che abbiamo chiamato “lavoro immateriale” pur sottolineando centinaia di volte i limiti e l’inadeguatezza del termine. Tanto più che insistere su questa nuova forma cognitiva, affettiva del lavoro, ci permetteva di capire come il neoliberalismo si andava sviluppando.
Da questo punto di vista tanto accetto la critica dell’impossibilità di distinguere il lavoro immateriale da quello materiale, ma ritengo al tempo stesso pericolosa ogni riaffermazione di un’egemonia della materialità. Basta guardare come stanno sviluppando oggi le fabbriche e i servizi: questa mutazione è ormai di troppo lungo corso per poterla negare, revocare; la cogenza di questi aspetti “immateriali” è diventata ormai talmente evidente da non permettere equivoci. E considerare il lavoro femminile tendenzialmente decisivo nell’affermazione della preminenza degli elementi affettivi e cognitivi è stata un’intuizione corretta e lungimirante.
Insomma, è giusto affermare che il lavoro è sempre unitario, che materialità e immaterialità sono sempre due astrazioni rispetto alla realtà della forza lavoro. Tanto più di fronte alla materialità di quello che Tronti chiamava il “soggetto operaio”, la sua intensità emotiva e cognitiva quanto materiale. Dall’altra parte, è chiaro che il privilegio tendenziale e fondamentale, probabilmente transitato attraverso le “virtù femminili” del lavoro, è quello del lavoro cognitivo: è su di esso che il neoliberalismo si è affermato.
E tutto ciò suscita una seconda riflessione, inerente al fatto che il nostro – mio e di Michael Hardt – è stato un lavoro di rottura. Noi abbiamo aperto uno spazio, ed è dentro questo spazio nuovo che oggi i risultati di questo lavoro possono essere criticati e corretti. Noi abbiamo elaborato un operaismo per il post-, ed è stato tutt’altro che facile, ci sono voluti dieci anni di lavoro, ma il problema è che si trattava di spezzare un fronte granitico, che per molti aspetti ci appare ancora oggi tale, basti guardare ad alcuni limiti delle odierne lotte in Francia così come ai blocchi tradizionali nel campo socialista, certo in disfacimento, ma ancora presenti e attivi come macigni.
Quindi: sono d’accordo sull’inconsistenza della distinzione di lavoro materiale/immateriale, ma d’altra parte riaffermo – anche per il lavoro femminile così come per gli aspetti del lavoro femminile che oggi vengono recuperati a quello, per dirla brutalmente, “maschile” – della prevalenza di questa nuova “qualità” immateriale della forza lavoro come tendenza reale.
Un secondo punto analizzato da Casalini e sottolineato anche da Della Porta è il carattere ottimista della tua lettura del nesso fra la composizione del lavoro vivo contemporaneo e l’apertura di potenziali spazi di libertà e di resistenza, o perfino di ribellione globale. Questo tema della postura ottimistica è un altro oggetto di critica ricorrente: vuoi dirci qualcosa in proposito?
Sono quarant’anni che ascolto questo argomento, questa giustapposizione ottimismo/pessimismo, che ora ha trovato una cristallizzazione più matura in quella eschaton/catechon. Ma ritengo questa distinzione una sciocchezza, che può però talvolta essere portatrice di un rischio peggiore.
Dicevo prima che il nostro discorso teorico – di Michael e mio, ma di tutto l’operaismo più in generale – è sempre stato un discorso di rottura. E da questo punto di vista siamo stati certamente ottimisti, se con ottimismo si intende apertura, assumere le cose alla loro radice, ragionare a partire da alcune domande lanciate nel vuoto. Agire è procedere per dispositivi, e direi che in questo ottimismo come “pensiero dell’apertura” c’è effettivamente il meglio della contemporaneità: Foucault, Deleuze, i grandi storici a partire da Thompson, è un pensiero che considera il mondo in maniera completamente materialista e vede la sua verità solo nella capacità di costruirlo dal basso. Ricordo qui il dibattito fra Chomsky e Foucault, in cui quest’ultimo diceva all’altro «l’ottimista sei tu che affermi grandi principi e in parallelo una pratica teorica che mai li tocca, io cerco di mettere insieme questi due elementi, alla maniera che ci ha spiegato Spinoza». E aggiungeva poi che la classe operaia non si muove sulla base di grandi ideali, ma piuttosto perché vuole costruire la propria felicità. Questo è un primo asse di risposta a chi critica il mio ottimismo.
Poi si tratta di capire che cos’è il “pessimismo” che vi si oppone. È quel pessimismo della ragione instancabilmente ripetuto da coloro che nelle Humanitates e in sociologia si ritengono “scienziati”, che vi affiancano poi l’ottimismo della volontà, coppia concettuale a mio avviso incomprensibile. Questo pessimismo è castrante. È “realismo”? Certo, ma è sempre un realismo al servizio del dato, del potere, dell’esistente. A mio avviso qualsiasi pensiero aperto – soprattutto se ambisce ad essere “dal basso”, a radicarsi cioè nelle lotte, nella materialità – non può che essere un pensiero ottimista. Un ottimismo della ragione, secondo la definizione classica dell’Illuminismo così come proclamata da Kant e poi ripresa e sviluppata da Foucault.
Il nostro pensiero non è soltanto di rottura, ma è un pensiero di lotta. L’apertura non è semplicemente ciò che contrasta o che attraversa la rottura, ma una cosa che si costruisce nella lotta, è un pensiero costruttivo, costitutivo, produttivo.
Marx è ottimista. Il marxismo agiva e costruiva nella storia. Penso al Tronti di Operai e Capitale: chi potrebbe definirlo pessimista? Lo diventerà solo dopo a partire dal discorso sull’autonomia del politico. Si tratta di capire che il mio ottimismo non è mai stato un ottimismo della volontà. Quest’ultimo può essere soltanto o terrorista o reazionario. Unità del lavoro e unità dell’uomo significa cercare, essere aperti con la ragione, e dunque essere ottimisti, e, dall’altra parte, scontrarsi con la realtà sapendo muoversi con la volontà in situazioni difficili. Io ho vissuto undici anni di carcerazione, ed è soprattutto lì che ho imparato come l’ottimismo della ragione e il pessimismo della volontà siano armi fondamentali non soltanto per resistere, ma per vivere e continuare a costruire.